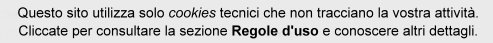Jidai
Akira Kurosawa: Il trono di sangue (Kumo no su jo)
1957
Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Akira Kubo, Eiko Miyoshi, Chieko Naniwa
Nel 1957 Kurosawa pose mano in breve tempo a due opere che traevano ambedue ispirazione dall'occidente anche se ambientate nel Giappone classico. La prima, conosciuta in Italia come Il trono di sangue (il titolo originario è Kumo no su jo, Il castello del ragno) ebbe uno straordinario successo; Kurosawa era già noto per Rashomon e I sette samurai, che avevano riscosso premi e consensi unamini della critica anche se non sempre del pubblico, e questa era praticamente la prima volta che si cimentava in temi "alti", avendo in precedenza cantato soprattutto le vicende degli umili, eccezione fatta per Tora no ofumu otokotachi, opera dedicata ad una impresa del leggendario principe Yoshitsune ma prodotta in condizioni di fortuna al termine del periodo bellico e praticamente mai distribuita fino ai giorni nostri.
 La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.
La trama riprende la nota vicenda del Macbeth di Shakespeare, con numerose licenze formali che non ne intaccano la sostanziale fedeltà al modello originario: accecato dalla brama di potere il comandante Taketoki Washizu viene trascinato in un vortice di delitti senza fine, che lo porterà inesorabilmente alla rovina ed alla morte.
L'intervento del soprannaturale, impersonato da una strega incontrata da Washizu in una foresta tenebrosa, non toglie nulla alla tragicità delle vicende umane: gli dei e gli spiriti si limitano a prendere atto della volontà degli uomini e delle donne, e delle loro azioni
 Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.
Kurosawa imposta perciò la recitazione dei suoi interpreti su toni che dichiara appartenere al teatro Nô: apparentemente impassibili, delle maschere che non lasciano trasalire i loro sentimenti, che trasmettono anzi l'impressione di non averne o di averli deliberatamente soppressi.
Sembra fare eccezione il solo Mifune, mentre gli altri protagonisti mostrano una impenetrabile maschera che copre il loro volto ed i loro veri sentimenti, quasi a simboleggiare l'impotenza dell'essere umano di fronte alle grandi scelte della vita, affrontate con decisioni prederminate dalla morale corrente e che lo sottraggono al libero arbitrio, tra l'indifferenza degli dei.
Washizu sembra fin dal primo momento avere coscienza ed orrore del ruolo assegnatogli dal destino, pur non avendo la forza di sottrarvisi, attirato come una falena dalla possibilità di arrivare al potere.
Toshiro Mifune aveva fino ad allora sostenuto ruoli, sia pur drammatici, di tuttaltro spessore. Altrettanto credibile sia come giovane ladro (L'angelo Ubriaco) che come giovane poliziotto (Cane randagio), sia come ladro di strada senza scrupoli (Rashomon) che come vagabondo dai modi rudi ma dal grande cuore (I sette samurai), qui per la prima volta affronta l'impegno di dare anima e volto ad un personaggio di grande levatura e di grandi ambizioni destinato a condurre uomini - forse alla gloriosa vittoria, forse alla tragica disfatta - e non un semplice seguace.
E' usuale affrontando la produzione artistica di Kurosawa scontrarsi con una antinomia: l'uso contemporaneo, che troviamo specialmente in questa sua opera, di due metodi di realizzazione che si direbbero antitetici. Un estremo realismo degli eventi, fino ad allora sconosciuto al cinema giapponese - come dimostrato dalla visione delle opere di un artista che pure Kurosawa indica come suo maestro e punto di riferimento, Kenji Mizoguchi - e di una recitazione astratta e simbolica.
 E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.
E' forse proprio questa la ragione della grande sorpresa suscitata dall'opera nel pubblico e nella critica d'occidente: l'uso di stilemi recitativi inusuali, la rappresentazione inedita della tragica bellezza estetica della guerra nel Giappone feudale, ove si mostrano reparti ordinati di uomini che si muovono apparentemente a caso senza alcun criterio logico, ma con troppa determinazione e troppa precisione di movimenti per non essere piuttosto gli esecutori attenti e fedeli di piani di battaglia oscuri allo spettatore ma visibilmente rispondenti a proprie leggi e propri metodi.
Ma anche la brutalità e disumanità della guerra vengono realisticamente resi: rimase scolpita indelebilmente negli spettatori di allora l'agghiacciante scena della rivolta delle truppe di Washizu che lo crivellano - tragica beffa per lui, celebre arciere - con una tempesta di frecce.
Kurosawa ricorrerà ancora nelle opere successive agli stilemi che appaiono per la prima volta in Kumo no su jo. Il precipitare drammatico degli eventi in seguito alla rivolta di un feudatario infedele viene scandito dal succedersi incalzante di una serie di messaggeri a briglia sciolta, che esausti fanno il loro rapporto davanti al quartier generale del signore del feudo, che attende gli eventi sul suo seggio di comando, pronto ad accorrere ove sia necessario ma in fondo anche lui coinvolto emotivamente - ma non materialmente - in eventi che si susseguono secondo logiche che prescindono dalla sua volontà e dal suo intervento.
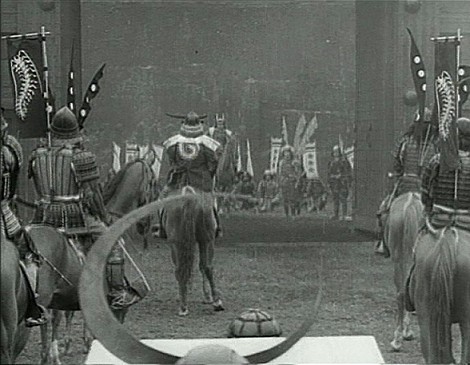 Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.
Sarà molto simile, circa 30 anni dopo, l'incipit di Kagemusha: un corriere, questa volta appiedato, corre instancabilmente per portare il suo messaggio, muovendosi senza nemmeno vederli tra i sanguinosi segni di un tragico assalto.
Ed il ruolo simbolico delle porte delle fortezze, impenetrabilmente chiuse ed ostili, che si aprono con sinistri cigolii solo per mostrare schiere di armati che entrano od escono furiosamente per sfuggire al nemico oppure recarsi alla battaglia, o che sfilano in lenta e solenne processione rituale, viene riproposto in Kagemusha ed ancora, ed ossessivamente, in Ran.
Singolare anche notare che Kurosawa per dare sfogo al suo pessimismo sulla natura umana in generale e del popolo giapponese in particolare sembra dover fare appello ad autori occidentali, qui Shakespeare e Maxsim Gorkij in I bassifondi, opera immediatamente successiva, ancora Shakespeare in Ran, opera tarda che riprende la trama del re Lear innestandola su un episodio reaie ma conosciuto al contrario come esempio di concordia familiare: il principe Mori è celebre soprattutto per l'episodio storico in cui consegna ai figli tre frecce mostrando come messe assieme in un unico fascio non possano essere spezzate mentre da sole non febbero resistenza nemmeno al braccio di un bambino. Ma i 3 figli di Mori non si dimostrarono affatto avidi di potere al punto di uccidersi tra di loro per esso, sono anzi ancora indicati a distanza di secoli come esempio di amore fraterno e filiale.
Ma ci piace credere che Kurosawa, dandoci rappresentazioni così artisticamente elevate della perfidia e della miseria umana abbia voluto darci un ammonimento e metterci in guardia. Giusto così: se avesse ceduto al compiacimento di "darci una morale" o concludere le sue opere con finali appaganti, se avesse rinunciato a mostrare impietosamente le bassezze in cui può cadere l'animo umano, il suo messaggio sarebbe stato meno immediato, meno efficace, meno forte. E forse, in fin dei conti, anche meno avvincente e privo del soffio dell'arte.
 Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:
Ritornando alla staticità espressiva del teatro Nô che volle utilizzare in questa opera, Kurosawa ne disse:
"La semplicità, la forza, la concentrazione del dramma richiamavano alla mia mente il Nô. Gi attori del Nô si muovono il meno possibile, comprimono le loro energie, perciò il minimo gesto produce un'emozione intensissima. Le espressioni degli attori nel mio film corrispondono a quelle delle maschere stilizzate del Nô".
Lo vediamo qui, naturalmente con il suo inseparabile cappellino, intento a dare le ultime istruzioni a Isuzu Yamada al momento di girare una delle scene più drammatiche del film, quella in cui Asaji, orami resa folle dai rimorsi e dal terrore di una sanguinosa vendetta da parte degli spettri delle sue vittime, si lava ossessivamente le mani indelebilmente macchiate di un sangue immaginario.
 L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.
L'immagine successiva ci mostra la Yamada dal punto di vista approssimativo in cui si trovava Kurosawa al momento di darle queste istruzioni, che coincide con questa inquadratura.
E' evidente come l'estrema economia di gesti richiesta da Kurosawa accentui e non diminuisca minimamente la tragica grandezza del momento.
Il volto, apparentemente impassibile, riesce tuttavia a restituire la tempesta di sentimenti di una persona resa schiava dalle sue folli ed inappagabili ambizioni.
 Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.
Lo stesso Mifune si muove con glaciale freddezza ed apparente impassibilità, alternata però a travolgimenti emotivi tanto più evidenti quanto più contrastanti con la precedente rigidezza formale.
Ma anche nei momenti più statici riesce a trasmettere emozioni importanti.
Nel momento in cui riceve dal suo signore la spada simbolo del potere, assieme al comando del Castello del Nord, ci rendiamo conto che il verme della sfrenata ambizione, scatenato dalla profezia della maga, ha già fatto presa nel suo animo e, per quanto cerchi invano di nasconderlo, nel suo volto.
 In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).
In questa opera Kurosawa riprende alcuni degli innovativi stilemi da lui introdotti negli anni precedenti: l'ambientazione nel bosco (Tora no ofumu otokotachi, 1945 e Rashomon, 1950). l'intervento della pioggia (Sugata Sanshiro, 1943, Rashomon, 1950 e I sette samurai, 1954).
Ne è un esempio la scena in cui i due generali vittoriosi, Taketoki Washizu e Yoshiaki Miki (Minoru Chiaki), dopo avere sventato l'attacco proditorio di un vassallo, si perdono nel bosco, sotto gli scrosci di un temporale, mentre si stanno recando a rapporto dal loro signore, Tsuzuki Kuniharu.
 Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.
Qui si imbattono in una strega, che Kurosawa rende come una parca della mitologia greca: intenta a tessere su un arcolaio i destini dell'uomo, pronta a reciderli secondo una logica che forse nemmeno lei conosce.
E' lei a pronunciare la sinistra ma morbosamente affascinante profezia: Washizu è destinato a diventare il signore del Castello del Ragno.
 Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.
Sia Wahiszu che Miki, che non regnerà si persona ma attraverso suo figlio, sono rimasti sconvolti dalla profezia della strega, che li ha immersi in una foschia dell'animo oltre la quale non è possibile vedere nulla.
Kurosawa ce li mostra immersi in una fitta coltre di nebbia materiale, dalla quale invano tentano di uscire per raggiungere il castello ove sono stati convocati dal signore.
Se Washizu è destinato a regnare, regneranno infatti anche i discendenti di Miki.
Quando oramai esausti e disperati hanno perso ogni speranza di uscirne, è la nebbia a levarsi, senza che i due guerrieri - inermi in questa battaglia interna - abbiano modo di intervenire nel loro destino.
Il castello è, sorprendentemente, vicino a loro. I loro passi, anche quando avvolti nella nebbia, andranno sempre là dove il destino vuole che vadano.
 Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.
Il destino inizia immediatamente a mutare il loro cammino. Washizu riceve il premio più ambito, viene nominato signore del Castello del Nord.
Levando alta nella mano la spada che hanno ricevuto in compenso del loro valore, ma attoniti, atterriti dall'avverarsi della profezia, lasciano come due automi la scena.
 Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.
Sarà Asaji da quel momento a prendere in pugno la situazione.
Si è immediatamente resa conto della inadeguatezza di Washizu, e non intendere lasciarsi sfuggire per la sua ignavia la grande occasione che si è presentata inaspettata.
Washizu non deve limitare le sue ambizioni: la signoria del Castello del Nord deve essere solamente la base da cui lanciarsi alla conquista del Castello del Ragno.
 Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.
Washizu nonostante il suo valore in battaglia è un debole.
E' chiaro immediatamente che Asaji lo porterà senza alcuna esitazione là dove vuole.
Lo lusinga come un grande guerriero, ma non manca di mettere in risalto l'inadeguatezza delle sue limitate ambizioni.
E gli fa presente, con crudele realismo, che se il signore venisse a conoscere la profezia della strega, Washizu verrebbe immediatamente messo a morte, che abbia o non abbia l'ambizione di regnare.
L'occasione per mettere in atto i suoi piani viene abilmente presentata come una necessità.
 Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.
Una imprevista visita del feudatario Tsuzuki (Sasaki Takamaru) al Castello del Nord, per una partita di caccia ed in incognito.
Si tratta in realtà di uno stratagemma per iniziare una nuova campagna di guerra, in cui sia Washizu che Miki sono chiamati ad un ruolo importante. Per questo vuole che la sua presenza venga mantenuta segreta.
Washizu si sente tranquillizzato: il signore ha piena fiducia in lui.
Akaji non è dello stesso parere: in pratica il signore gli ha ordinato di uscire in campo aperto, senza alcuna protezione alle spalle, per affrontare il nemico, mentre lui occupa il castello.
Una situazione ideale per togliere sbrigativamente di mezzo uno scomodo servitore. E non è il caso di farsi illusioni sugli scrupoli del signore, che ha conquistato col sangue il suo potere e con il sangue lo mantiene.
 Occorre agire, immediatamente.
Occorre agire, immediatamente.
Washizu è ormai una marionetta che si piega suo malgrado, senza essere in grado di opporre la minima resistenza, al volere, all'mabizione, ai folli piani di Akaji.
Durante la notte, nonostante la stretta vigilanza da cui è protetto, con tre guardie armate di tutto punto che vegliano fuori della sua stanza impedendo il passaggio a chiunque, il signore deve essere ucciso.
 Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.
Akaji prende l'iniziativa, occupandosi di rendere innocue le guardie.
Farà recapitare loro, per aiutarli a tenere desta l'attenzione, del sake.
Vi ha disciollto in realtà un potente sonnifero, cui non potranno resistere pi♂ di pochi istanti.
 Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.
Washizu attende, preda dei suoi dubbi, delle sue angosce, attanagliato nonsotante tutto dall'ambizione.
Si trova nella stanza in cui fu costretto a commettere seppuku Fujimaki, il vassallo ribelle che riuscì a sconfiggere in battaglia poco tempo prima, ponendo le basi della sua scalata al potere.
Le pareti della stanza sono ancora ricoperte da orrende macchie di sangue, che nessuno è mai riuscito a far scomparire.
Akaji ha sottratto alle guardie addormentate una lancia: è con quella che Washizu dovrà compiere il suo delitto.
La guarda a lungo, inorridito e allo stesso tempo affascianto.
Infine, l'afferra.
 Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.
Quando torna, materialmente al tempo stesso il signore del Castello del Ragno, ma è ridotto all'ombra di se stesso.
Non riesce a rendersi conto delle ragioni per cui il destino lo abbia portato fin lì, probabilmente nemmeno riesce a rendersi conto delle trasformazioni che la lebbra del potere sta apportando in lui.
Akaji ha dovuto strappargli dalle mani irrigidite la lancia insanguinata, per andare invece a deporla nelle mani della guardia del corpo cui l'aveva sottratta, ancora addormentata come le altre guardie.
 Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.
Solo le urla di Akaji, che chiama l'allarme fingendo di avre scoperto per caso l'assasinio del signore, hanno il potere di ridestarlo - provvisoriamente - dai suoi incubi.
E' troppo tardi per pentirsi, da uomo di azione capisce nonostante tutto che non è il momento di perdersi nei pensieri e deve solo andare avanti lungo la strada che ha preso, che porti al disastro o alla gloria.
Armatosi immediatamente, abbatte la guardia che impugna ancora la lancia del delitto, prima che si riprenda dall'intontimento e possa discolparsi.
Trova così il modo di addossare ad altri, le guardie appartenevano alle schiere del vassallo ribelle, l'assassinio del signore.
 Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.
Con una anticipazione dello stile che adotterà poi nelle grandi opere degli anni 80, Kagemusha e Ran, Kurosawa rende l'idea delle sanguinose battaglie del Giappone feudale come un alternarsi di onde tempestose che scuotono lo schermo, mosse da venti violenti quanto impossibili da prevedere.
Washizu tenta di liquidare ogni possibile avversario prima che abbiano la possibilità di reagire.
Si scaglia con i suoi uomini contro le truppe di Kunimaru, figlio del signore assassinato, accusandolo allo stesso tempo di essere lui l'autore del delitto.
 Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.
Guidato dal fedele generale Noriyasu (l'immancabile Takashi Shimura) il principe Kunimaru riesce a scampare al disastro del suo esercito e cerca riparo presso il castello presidiato da Miki.
Ma non gli viene aperto.
Anzi, quando i due continuano a gridare di aprire il portone inizia contro di loro un fitto lancio di frecce, costringendoli ad allontarsi.
Washizu, sopraggiunto con un drappello di cavalieri, potrebbe ragiungere i suoi nemici e finalmente finirli.
Eppure, inspiegabilmente, dopo averli rincorsi a briglia sciolta fino lì, ordina di lasciarli andare.
 Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.
Non è ben chiaro da che parte intenda stare Miki; non ha aperto il castello al principe Kunimaru, ma non è detto che voglia aprirlo a Washizu.
Un messaggero raggiunge il condottiero, da parte di Akaji: Miki dovrà aprire le porte al suo signore.
Ecco la soluzione: Washizu riporterà al castello il corpo esanime cui lui stesso ha tolto la vita.
Un lungo coreto di soldati in assetto di guerra scorta la bara, su cui spicca l'elmo di sua signoria.
 Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.
Miki apre lo porte, e lascia entrare Washizu.
Si incontrano, entrambi a cavallo e coperti dalle loro pesanti armature.
Corre tra di loro una muta intesa.
Parlerà solamente Miki ma dopo, mentre i due a cavallo, alla testa del corteo funebre, attraversano il cortile del castello per recarsi al consiglio di guerra.
Miki accetta il responso della maga: inoltre con la morte del signore il feudo verrà immediatamente attaccato e Washizu è l'unico in grado di difenderlo e prenderne il comando.
Miki lo sosterrà.
 Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.
Akaji però non vuole accettare l'alleanza tra Washizu e Miki. Non crede alla bontà degli esseri umani, non accetta l'idea che le azioni di Miki possano essere disinteressate e senza secondi fini.
La coppia non ha figli: è il loro unico cruccio ora che hanno in mano il potere.
Per questo Washizu ha in mente di adottare il figlio di Miki, Yoshiteru, e farne il suo erede e successore. Legherà indissolubilmente l'alleato ai suoi destini, e adempierà anche alla seconda parte della profezia della maga.
Akaji non lo vuole accettare: non si è macchiata di sangue per donare regni ai figli degli altri.
E possiede un'arma che renderà vano ogni tentativo del marito di resistere alla sua inflessibile volontà: ella attende un figlio.
 A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.
A questo punto Miki e il giovane si trasformano in ostacoli. Ostacoli da rimuovere ad ogni costo.
Nemmeno tra Miki e Yoshiteru (Akira Kubo) regna però l'accordo.
Yoshiteru non crede allaprofezia della maga, e non si fida di Washizu.
Vorrebbe rifiutare l'invito al banchetto per quella sera, allarmato da un sinistro presagio: il cavallo di Miki si è imbizzarrito, e nessuno riesce a calmarlo.
 Il presagio non è senza ragione.
Il presagio non è senza ragione.
Nella sala del banchetto il posto riservato a Miki rimane vuoto: lui non arriva.
Il nervosismo di Washizu sembra aumentare progressivamente man mano che si allungano i tempi dell'attesa.
 Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.
Nel frattempo il cavallo di Miki fa ritorno alla stalla, al galoppo sfrenato ed ancora più imbizzarrito di come era apparso poche ore prima.
Da solo.
Nessuna traccia del suo cavaliere.
Nesuna traccia del figlio.
Nessuna traccia della loro scorta.
 E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.
E' Washizu che lo rivedrà, ma solo lui.
Nella sala del banchetto, al posto che gli era riservato, appare improvvisamente Miki.
Vestito di bianco (il colore tradizionale del lutto), con i capelli sciolti, pallido come un fantasma.
Ed è in realtà solamente il fantasma di Miki, e solamente Washizu lo vede.
 Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.
Il fantasma scompare, riappare, sempre seguendo in realtà i fili del pensiero di Washizu.
E' lui stesso che lo evoca, è lui che non riesce a liberarsi dai suoi incubi.
Akaji ha tentato di tranquillizzare gli ospiti sostenendo che il marito ha solo bevuto un po' più del normale, ma quando questi estrae la spada tentando vanamente di uccidere gli spettri generati dalla sua mente, è costretta a congedarli scusandosi per l'infelice conclusione della serata.
 Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.
Quando sono rimasti soli, un guerriero in armatura penetra silenziosamente nella stanza.
I due ne rimangono intimoriti, ma in realtà è stato lo stesso Washizu a dare ordine al soldato di presentarsi a rapporto da llui non appena terminata la sua missione.
Porta con se la testa mozzata di Miki.
Washizu non la vuole vedere: sarebbe un ennesimo ritorno della sua nemesi personale.
Chiede piuttosto che ne è di Yoshiteru. Il soldato confessa di non essere riuscito ad ucciderlo, pur avendolo gravemente ferito, e che gli è sfuggito di mano.
 In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.
In preda all'ira Washizu estra la spada e lo abbatte.
Il soldato, che aveva implorato pietà, ha un motodi ribellione e negli spasimi dell'agonia cerca di aggredirlo.
Washizu, terrorizzato, non tenta nemmeno di reagire ma arrretra in preda al panico fino a che la parete lo arresta.
Ha conquistato il potere, ma ha perso se stesso.
 Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.
Kurosawa introduce l'epilogo della tragedia attraverso le discussioni degli uomini al posto di guardia.
Un vento incessante scuote il castello fin dalle fondamenta, che si dice siano marce, condannando il castello stesso a crollare prima o poi di schianto.
Il malumore tra ii soldati cresce: già due ufficiali sono stati costretti al suicidio dal carattere sospettoso e crudele di Washizu.
E l'alleanza tra i figli di Tsuzuki e di Miki, che radunano truppe alle frontiere, rende non più credibile la tesi che sarebbero ognuno responsabile dei lutti dell'altro.
 Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.
Taketoki Washizu non solo è ancora alle prese con i suoi incubi, ma si deve confrontare con altri ancora, destinati a non lasciargli tregua.
E' in spasmodica attesa nella sua stanza, quando la nutrice viene a chiamarlo.
Il parto del suo erede è stato infelice.
La creatura è nata morta, Washizu ed Akaji sono destinati a rimanere soli.
Soli con il rimorso del loro inutile delitto, soli con un potere che si sta trasformando in una morsa ove verranno schiacciati.
 Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.
Solo nella sua spoglia stanza, ove appaiono solamente come unica decorazione gli inutili simboli del suo potere materiale, la spada e l'elmo da battaglia, Washizu inveisce contro la follia umana.
In defnitiva, cotnro la sua stessa follia.
Solo i richiami degli attendenti lo riportano a stento alla realtà.
E' annunciato l'arrivo di un messaggero.
 Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.
Le truppe dei confinanti, gli Inui, cui si sono uniti il generale Noriyasu, sempre al fianco di Kunimaru Tsuzuki, e Yoshiteru Miki, hanno varcato la frontiera ed assallito il castello numero uno.
Washizu probabilmente non ne è contrariato.
Può tornare ad agire sul campo di battaglia, quello che è a lui più coneniale, dimenticando almeno per il momento ogni altra cosa.
Nel momento dell'azione ogni pensiero svanisce.
Ma non sarà come lui pensa: le sue stesse truppe dslocate ai castelli uno e due non tardano a ribellarsi, passando al nemico per attaccare congiunti il castello numero tre.
 Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.
Armato di nuovo e rivestito della pesante armatura, dopo aver percorso incessantemente con passi sempre più nervosi la sala ove ha riunito il consiglio, senza che nessuno sia stato in grado di proporgli un piano di battaglia, Washizu decide di chiedere di nuovo il responso delle forze ultraterrene.
Si fa sellare il cavallo, spalancare il portale di ingresso, ed esce come furia in mezzo ad una autentica tempesta, che infuria come quel lontanissimo giorno in cui incontrò nel bosco la strega, assieme al fedele Miki, allora suo migliore amico, sua futura vittima.
 Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.
Anche Washizu sembra ora uno spettro, mentre percorre a caso la fitta foresta, al galoppo sfrenato, e sempre sotto una pioggia incessante.
 Infine ritrova la strega.
Infine ritrova la strega.
O forse è la trega a ritrovare lui: non è concesso illudersi di essere padroni del destino.
Washizu, che l'aveva a lungo invocata durante la sua corsa sfrenata, non sa trattenersi e le chiede immediatamente di rivelare quello che più gli preme: riuscirà il nemico ad impadronirsi del Castello del Ragno?
Lo spirito (Chieko Niniwa) non rispnde: si congratula, con voce glaciale e d'oltretomba, col guerriero: ha raggiunto quello che più fortemente voleva.
Ma infine accetta di rivelare quanto sa.
Washizu non può essere sconfitto, a meno che gli alberi di quella stessa foresta non si muovano fino a circondare il castello.
Ma sia determinato fino in fondo: se deve spargere sangue, che ne sparga a fiumi.
Washizu ha ottenuto la risposta che voleva. Forse ogni essere umano - quando si interroga od interroga altri - ottiene solamente la risposta da lui desiderata. Quanto questa sia vera, è un altro tema su cui ora non è il caso di soffermarsi.
 Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.
Noriyasu comanda le truppe alleate che stanno per cingere di assedio il Castello del Ragno.
I reparti dovranno attraversare la foresta maledetta, e il generale li mette in guardia.
Non seguano i sentieri, che li porterebbero inevitabilmente fuori dai loro obiettivi.
Ignorino ogni falso indizio e procedano semplicemente in avanti, senza mai deviare né a destra né a sinistra, fino ad uscire dalla foresta.
 Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.
Washizu osserva i movimenti del nemico dalle feritoie del castello. Si sente sicuro della vittoria, ma si rende conto che i suoi uomini sono invece scossi dal timore.
RIvela allora la profezia dello spirito: non potrà mai essere sconfitto finché non si vedranno gli alberi della foresta muoversi e marciare verso il Castello del Ragno.
Questo basta per riportare in alto il morale dei suoi uomini.
 Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.
Durante la notte tuttavia diversi inquietanti segnali continuano a destare inquietudine negli animi dei difensori del castello.
La sala del consiglio di guerra viene improvvisamente invasa da stormi di corvi che volano per ogni dove all'impazzata.
Washizu non se ne lascia impressionare.
Finché non vedrà gli alberi della foresta stregata in marcia contro di lui, sa di essere invincibile.
Qualunque sia il significato del misterioso volo dei corvi, non può mutare il suo destino vittorioso.
 Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.
Il destino ha deciso di tenere in serbo fino ad allora qualcosa che scuoterà anche lui.
Recatosi negli appartamenti della moglie, non riesce a trovarla nella camera da letto.
La trova infine: si sta affannosamente e compulsivamente lavando le mani, per lavarle da indelebili macchie di sangue che solo lei riesce a vedere, eppure ci sono.
E nessun intervento umano o divino riuscirà mai a cancellare.
L'apparentemente incrollabile volontà di Akaji ha improvvisamente ceduto.
Ha perduto il senno.
Washizu è definitivamente solo, senza più Akaji che condivida le sue folli ambizioni, dopo averle attizzate e fatte divampare, e senza che sia più capace di sopportare il peso dei rimorsi.
 Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.
Altri inquietanti fenomeni si verificano un po' dappertutto all'interno del castello.
Dall'interno del posto di guardia si odono incessanti rumori ritmici provenire dalla foresta.
Sembrano centinaia, migliaia di asce intente ad abbattere alberi.
 Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.
Washizu, che sta ancora tentando invano di far tornare in se Akaji, è improvvisamente richiamato fuori da un improvviso clamore.
Uscito nella corte d'armi scopre che le truppe sono in preda al panico, e i soldati corrono all'impazzata in cerca di una impossibile salvezza.
Mentre la nebbia si addensa di nuovo, simbolo della nebbia che ha avvolto il cuore degli uomini, Washizu arresta la corsa di un ufficiale e gli chiede cosa mai stia succedendo.
La risposta è strabiliante: la foresta si muove.
Gli alberi stanno circondando il Castello del Ragno.
 Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.
Salito sugli spalti, Washizu vuole verificare di persona.
Non riesce a credere a quanto ha appena ascoltato.
 Eppure è così.
Eppure è così.
Avvolti dalla nebbia dell'alba, gli alberi della foresta si stanno muovendo.
Terribili ed inesorabili, si avvicinano sempre più alla cinta muraria del Castello del Ragno.
 Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.
Washizu non sa più cosa fare, cosa dire alle sue truppe.
Tenta invano di richiamarle all'ordine, di giustificare in qualche modo quello che stanno vedendo dinanzi ai loro occhi.
E' sato proprio lui, rivelando la profezia, a vincolarsi indissolubilmente ad essa.
La foresta sta marciando contro di lui: il suo regno, la sua vita, sono arrivati alla fine.
 Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.
Travolto dall'ira non è riuscito a trattenersi dall'inveire contro i suoi uomini, accusandoli di tradimento e di vigliaccheria.
Non era in grado di rendersi conto che quella sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto definitivamente traboccare il vaso.
 Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.
Gli aricieri che hanno rivolto le loro armi contro di lui, lo braccano, non gli danno scampo.
L'agonia di Washizu, scandita dal sinistro sibilo delle innumerevoli frecce e dal loro impatto contro le mura della fortezza o contro il corpo di Washizu, o dalle grida di terrore di questulptimo, dura un tempo che allo spettatore sembra interminabile, ed insopportabile.
 La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.
La freccia che trafigge la gola di Washizu sembra voler finalmente porre termine allo strazio.
Immediatamente chi assiste alla scena si rende conto che quello è il colpo fatale, anche perché simultaneamente, come per un tacito accordo, gli arcieri cessano all'istante i loro tiri.
Non è così: anche se ferito a morte Washizu trova l'estrema energia per scendere dagli spalti, ed avanzare nello spiazzo verso la moltitudine ostile che lo attornia, tentando di impugnare per l'ultima volta la sua spada.
 Non ne avrà il tempo.
Non ne avrà il tempo.
Crolla nella polvere, che si mescola con la nebbia che ha avvolto fin dall'inizio della vicenda il Castello del Ragno.
I soldati assistono immobili, muti, al suo crollo.
 Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.
Alla luce dell'alba l'armata nemica si sta avvicinando alle mura, e quello che sembrava il più inestricabile dei misteri si chiarisce.
Sono stati i guerrieri del'esercito nemico a tagliare gli alberi durante la notte, era quella la ragone degli incessanti ciolpi di ascia che si erano sentiti dai posti di guardia.
Era anche quella la ragione per cui i corvi, cacciati dalla foresta, avevano invaso la fortezza e gettato il disordine nella mente dei difensori, con i loro folli voli senza apparente ragione.
Ed ora, nascondendoi dietro gli alberi, sono arrivati talmente vicino da poter lanciare l'ultimo assalto, senza ancora sapere che sarà inutile perché Washizu è stato ucciso dai suoi stessi uomini.
 Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.
Kurosawa sembra voler lasciare le porte aperte ad una spiegazione razionale degli eventi, pur non rinnegando l'intervento del sovrannaturale.
E' stato il generale Noriyasu, che ha preparato accuratamente il piano di attacco, ad ordinare alle sue truppe di tagliare gli alberi e di proseguire la marcia di avvicinamento alla fortezza facendosi riparo dietro di essi, per non essere avvistati se non all'ultimo e per nascondere la presenza delle macchine da assedio.
 L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.
L'inquadratura riprende ancora una volta il Castello del Ragno, perennemente avvolto dalla nebbia.
 Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.
Lentamente la nebbia torna ad avvolgerlo, fino a farlo scomparire del tutto.
Uno squarcio torna poi a farlo intravvedere, ma sono ormai solamente delle rovine, le stesse rovine che avevamo visto nelle immagini di apertura.
Quelle poche rovine che il tempo inesorabile ha voluto lasciare, marcate da un cippo.
Le parole incise su quella stele vengono cantate dal coro:
Ecco, mirate il desolato luogo
ove si ergeva superbo un castello
in cui le brame ebber selvaggio sfogo,
finché soltanto fu di morte ostello.
Regnò, su questa terra che ora langue,
da un furor di potere fatto insano,
un guerriero il cui trono fu di sangue:
ma il trionfo del male è sempre vano.
Akira Kurosawa: I bassifondi
1957
Toshiro Mifune, Isuzu Yamada, Ganjiro Nakamura, Kyoko Kagawa, Akemi Nigishi e altri
 Se i film jidai di Kurosawa hanno quasi sempre riscosso successo unanime di critica e di pubblico, occorre però dire che le due rare eccezioni sono in qualche modo apparentate tra di loro; sia in Donzoko (I bassifondi) che in Akahige (Barbarossa) del 1965, l'autore tenta di trasportare in epoca remota il tema che di solito affronta nelle opere di ambientazione contemporanea.
Se i film jidai di Kurosawa hanno quasi sempre riscosso successo unanime di critica e di pubblico, occorre però dire che le due rare eccezioni sono in qualche modo apparentate tra di loro; sia in Donzoko (I bassifondi) che in Akahige (Barbarossa) del 1965, l'autore tenta di trasportare in epoca remota il tema che di solito affronta nelle opere di ambientazione contemporanea.
Il degrado della condizione umana, causato dal degrado morale delle istituzioni e della società e materializzato nelle umilianti e degradanti condizioni di vita cui vengono costretti gli elementi più indifesi della società.
Sarebbe arduo tentare di analizzare in dettaglio le ragioni del grande rifiuto da parte degli spettatori e della scarsa attenzione da parte dei critici: alcuni hanno proposto come spiegazione l'eccessivo pessimismo di Kurosawa che rende duro affrontare certe sue opere. Ma non troviamo alcuna traccia di ottimismo nemmeno in opere che hanno lasciato il segno negli spettatori come Rashomon o Il trono di sangue.
Possiamo ipotizzare per grandi capi che le ambientazioni storiche prediligano la trattazione di grandi temi, anche quando ne siano protagonisti pochi personaggi (Rashomon appunto, ove si tratta della assoluta incapacità del genere umano tutto ad essere onesto con se stesso) o si dipanino attraverso episodi di non grande rilevanza (I sette samurai, dove pochi oscuri guerrieri reduci da mille sconfitte difendono a costo della loro vita un oscuro villaggio).
Le trattazioni delle miserie del vivere quotidiano di esseri umani deboli ed indifesi di fronte alle dure regole della "umanità" evidentemente richiedono nella grande massa del pubblico legami più concreti e più attuali con la realtà.
Ma anche qui dobbiamo ricordare quanto disse lo stesso Kurosawa, quando decise di fornire al mondo una chiave autentica di interpretazione del suo pensiero: Io credo che la via più semplice per parlare di me - da quando sono diventato regista - sia di seguire la mia filmografia scorrendo la miia vita film per film.
E' giusto quindi parlare di Donzoko ed inevitabile, necessario, che i tanti ammiratori di Kurosawa ne prendano visione.
 Tratto dall'omonimo romanzo di Maxim Gorkij, ed ambientato in una non precisata epoca del feudalesimo giapponese, I bassifondi tratta le insignificanti eppure tragiche vicende di un gruppo di derelitti, ridotti a vivere in una stamberga gestita da una coppia dedita all'usura.
Tratto dall'omonimo romanzo di Maxim Gorkij, ed ambientato in una non precisata epoca del feudalesimo giapponese, I bassifondi tratta le insignificanti eppure tragiche vicende di un gruppo di derelitti, ridotti a vivere in una stamberga gestita da una coppia dedita all'usura.
Alcune recensioni parlando di un tugurio situato nelle vicinanze di una discarica. Le immagini di apertura non lasciano però alcun margine di dubbio: è proprio dentro la discarica, dove continuamente vengono gettate le immondizie di persone meglio inserite nella società, che è collocata l'azione.
 Come ben sanno tutti coloro che hanno seguito il filone "sociale" delle opere di Kurosawa, spesso mancano protagonisti assoluti sulla scena ed in compenso sono numerosi i componenti del coro.
Come ben sanno tutti coloro che hanno seguito il filone "sociale" delle opere di Kurosawa, spesso mancano protagonisti assoluti sulla scena ed in compenso sono numerosi i componenti del coro.
Talmente numerosi a volta che ogni tentativo di elencarli risulta vano, riuscirebbe solo a causare un gran mal di testa al lettore. Talmente variegati nelle loro piccole - grandi vicissitudini che talora è difficile renderne conto anche quando sono relativamente pochi.
E' questo il caso degli abitanti dei bassifondi evocati da Gorkij e poi portati sullo schermo da Kurosawa.
I padroni della stamberga sono due coniugi di cui è difficile dire qualcosa di buono. Sono attaccati solamente al denaro, in cambio del quale però sono fermamente decisi a dare il meno possibile, senza in alcun modo dare il minimo cenno di umanità e di comprensione per i loro miserabili affittanti.
Questi ultimi compongono un campionario di varia umanità in cui è veramente arduo trovare un personaggio completamente positivo, mentre anche in quelli maggiormente negativi, ad eccezione della coppia di sfruttatori, Kurosawa lascia intravedere se non i sintomi perlomeno il desiderio del riscatto, forse tanto più apprezzabile quanto più irrealistico.
 L'approccio più ragionevole non è quello di attenersi alla trama, talmente si aggrovigliano le varie vicende personali, ma di fare un breve resoconto del campionario di piccola umanità che popola la stamberga e l'opera, e un riassunto anchesso succinto della trama.
L'approccio più ragionevole non è quello di attenersi alla trama, talmente si aggrovigliano le varie vicende personali, ma di fare un breve resoconto del campionario di piccola umanità che popola la stamberga e l'opera, e un riassunto anchesso succinto della trama.
Il resto ognuno dovrà trovarlo dall'esame diretto dell'opera, che rende alla perfezione sia l'universalità del messaggio di Gorkij, che permette senza difficoltà di trasporre la storia in altro ambiente ed altra cultura, e la specificità di ogni humus culturale e sociale, anzi alla resa dei conti di ogni singolo individuo che compone l'umanità.
Kurosawa disse:
Una buona struttura per una sceneggiatura è quella di una sinfonia, con i suoi tre o quattro movimenti e i suoi tempi contrastati. Oppure, si può usare il dramma noh, con le sue tre parti: jo (introduzione), ha (distruzione) e kyu (catastrofe). Se vi dedicate al noh e ne tirate fuori l'essenza, tutto questo emergerà con naturalezza nei vostri film. II noh è una forma d'arte autentica, unica al mondo. Secondo me il kabuki, che lo imita, è un fiore sterile. Ma in una sceneggiatura credo che la struttura sinfonica sia la più facile da capire, per la gente d'oggi.
 Rimane un margine di dubbio: in questo film, che rinuncia agli accorgimenti tecnici e alle innovazioni sparsi a piene mani in quelli precedenti per ricorrere ad una sola tecnica, quella del piano sequenza ossia della macchina da presa fissa che si limita a riprendere quanto accade in un unico ambiente, come avviene in una rappresentazione teatrale, a quale struttura ha inteso fare ricorso Kurosawa?
Rimane un margine di dubbio: in questo film, che rinuncia agli accorgimenti tecnici e alle innovazioni sparsi a piene mani in quelli precedenti per ricorrere ad una sola tecnica, quella del piano sequenza ossia della macchina da presa fissa che si limita a riprendere quanto accade in un unico ambiente, come avviene in una rappresentazione teatrale, a quale struttura ha inteso fare ricorso Kurosawa?
Ci sembra di poter dire che sia più quella del teatro noh che quella dell'opera sinfonica.
 Non possiamo andare oltre senza fare menzione dell'uso intenso che Kurosawa volle fare di ogni singolo attore, rinunciando ad avere un protagonista assoluto.
Non possiamo andare oltre senza fare menzione dell'uso intenso che Kurosawa volle fare di ogni singolo attore, rinunciando ad avere un protagonista assoluto.
Ognuno dei dodici attori impegnati nell'opera - oltre a una manciata di comprimari e non contando Mifune - è chiamato a dare il meglio di sé, rimanendo sia pure per uno spazio di tempo limitato, protagonista unico ed assoluto.
Chi cercasse un filo conduttore, un filone principale cui si collegano le storie e le vicende dei comprimari, si troverebbe a disagio. Sembra non esserci logica nel susseguirsi degli avvenimenti, e se c'è non essere di quelle che gli esseri umani riescono a comprendere, o tanto meno a determinare, o perlomeno influenzare.
Una trama c'è e ne riparleremo, ma Kurosawa, che spesso predilige le opere corali, la rende più ardua da cogliere affidando l'esecuzione delle parti corali ad altrettanti solisti di spicco, che catturano l'attenzione facendo perdere di vista l'assieme. Sono tutti interpreti che Kurosawa conosce bene, che ha utilizzato spesso.
 Fa eccezione Bokuzen Hidari, attore noto fino ad allora per i suoi ruoli comici, ma questo non deve meravigliare: Pierpaolo Pasolini fece di Toto' l'interprete di Uccellacci ed uccellini (e fu l'ultima apparizione sullo schermo del grande artista) e Federico Fellini volle Enrico Benigni e Paolo Villaggio come protagonisti del suo La voce della luna (e fu l'ultima opera diretta da Fellini).
Fa eccezione Bokuzen Hidari, attore noto fino ad allora per i suoi ruoli comici, ma questo non deve meravigliare: Pierpaolo Pasolini fece di Toto' l'interprete di Uccellacci ed uccellini (e fu l'ultima apparizione sullo schermo del grande artista) e Federico Fellini volle Enrico Benigni e Paolo Villaggio come protagonisti del suo La voce della luna (e fu l'ultima opera diretta da Fellini).
Hidari incarna il viandante Kahei, che sembra rappresentare nella vicenda l'unica nota positiva immune da zone d'ombra.
 Toshiro Mifune, nella parte del ladro Sutekichi, replica ancora una volta il ruolo della persona disadattata, scostante e aggressiva ma non priva di sensibilità e di nobiltà d'animo.
Toshiro Mifune, nella parte del ladro Sutekichi, replica ancora una volta il ruolo della persona disadattata, scostante e aggressiva ma non priva di sensibilità e di nobiltà d'animo.
In altre opere il suo personaggio riuscirà a mettere al servizio di buone cause anche la sua aggressività.
In Donzoko l'mpossibile sogno d'amore con Okayo, l'unica componente della famiglia degli affittuari della stamberga che mostri cenni di umanità, rimarrà frustrato e terminerà tragicamente.
 Okayo è impersonata da Kyoko Kagawa, che condivise fino al termine l' avventura di Kurosawa: è l'interpete femminile di Madadayo, ultima opera del maestro.
Okayo è impersonata da Kyoko Kagawa, che condivise fino al termine l' avventura di Kurosawa: è l'interpete femminile di Madadayo, ultima opera del maestro.
E' attratta e allo stesso tempo intimorita dalla personalità irruenta di Sutekichi.
Eppure, nonostante i suoi timori, è l'unica che lo tratti con franchezza e che riesca a tenerlo a bada.
 Tonosama, che tutti chiamano Principe, si dice sia stato un samurai di alto lignaggio.
Tonosama, che tutti chiamano Principe, si dice sia stato un samurai di alto lignaggio.
Adesso subisce passivamente le ingiurie delle vita e degli uomini, si limita al massimo a far presente che non c'è nessun merito a trattarlo male ora che si trova allo stesso infimo livello degli altri.
Per dimostrare di essere qualcuno avrebbero dovuto affrontarlo quando aveva due spade al suo fianco.
Lo interpreta Minoru Chiaki, che il pubblico internazionale ha imparato ad apprezzare fin da quando impersonò il monaco errante di Rashomon e pochi anni dopo Heihachi (I sette samurai), guerriero gentile ed allegro eppure non privo di profondità: fu proprio lui a senitre il bisogno di una bandiera che unisse samurai e contadini ed a disegnarla, ed il destino volle che fosse lui il primo a cadere sotto quella bandiera.
 Rokubei (Ganjiro Nakamura) è il proprietario del tugurio.
Rokubei (Ganjiro Nakamura) è il proprietario del tugurio.
Si rifugia dietro formule stereotipate che non riescono a celare, dietro una cortesia formale e di comodo, un animo gretto.
Quello di un uomo che ha deciso di sfruttare senza alcuna pietà i suoi simili.
 Osugi (Isuzu Yamada) non gli è da meno.
Osugi (Isuzu Yamada) non gli è da meno.
Ogni occasione è buona per pretendere altro denaro dagli occupanti della stamberga, senza fornire loro nulla oltre il minimo indispensabile per sopravvivere.
Solamente il timore di una reazione violenza di Sutekichi impedisce loro di trattare allo stesso modo Okayo, la sorella di Osugi, che sembra un corpo estraneo inserito per errore in ambiente familiare non suo.
 Osen (Akemi Nigishi) è come già accennato una giovane prostituta, che non intende lasciarsi abbattere dal degrado materiale e morale in cui è costretta a vivere, e continua a sognare ad occhi aperti un improbabile riscatto.
Osen (Akemi Nigishi) è come già accennato una giovane prostituta, che non intende lasciarsi abbattere dal degrado materiale e morale in cui è costretta a vivere, e continua a sognare ad occhi aperti un improbabile riscatto.
E' proprio questo a scatenare contro di lei la pesante ironia, l'ostilità e l'aggressività dei suoi compagni di sventura.
 Asa (Eiko Miyoshi) ha un male incurabile, non le rimane molto da vivere. Viene considerata solo come un fastidio, i suoi incessanti colpi di tosse, i lamenti che non riesce a trattenere, infastidiscono i coinquilini.
Asa (Eiko Miyoshi) ha un male incurabile, non le rimane molto da vivere. Viene considerata solo come un fastidio, i suoi incessanti colpi di tosse, i lamenti che non riesce a trattenere, infastidiscono i coinquilini.
Suo marito, il tintore Tomekichi (Eijiro Tono), sta già pensando al dopo, a rifarsi una vita quando si sarà liberato di quel peso.
La dolciaia ambulante Otaki (Nijiko Kiyokawa) invano tenta di rincuorarla dedicandole modeste ma apparentemente sincere attenzioni.
 Kamatari Fujiwara interpreta un attore alcolizzato, che è caduto in rovina quando la memoria lo ha tradito e ha cominciato a non tenere più a memoria la parte.
Kamatari Fujiwara interpreta un attore alcolizzato, che è caduto in rovina quando la memoria lo ha tradito e ha cominciato a non tenere più a memoria la parte.
Ovviamente non ricorda nemmeno il proprio nome, e non lo conoscerà nemmeno lo spettatore.
 Il giocatore Yoshisaburo deve avere conosciuto tempi migliori, e spera di poterli rivedere un giorno.
Il giocatore Yoshisaburo deve avere conosciuto tempi migliori, e spera di poterli rivedere un giorno.
Confesserà poi a Kahei, che ha il potere di tirare fuori da ognuno la verità, di essere stato in prigone per omicidio
Nel frattempo che attende una riabilitazione sociale, ha organizzato una bisca clandestina nella baracca, anche se il denaro delle puntate si riduce a pochi spiccioli.
 Il folle Tatsu (Haruo Tanaka) è forse chi ha meno problemi di tutti.
Il folle Tatsu (Haruo Tanaka) è forse chi ha meno problemi di tutti.
Gli basta un niente per rifugiarsi nel suo mondo immaginario.
 Tra Sutekichi e la proprietaria dello baracca, Osugi, è in atto da tempo una tresca, di cui il marito è all'oscuro.
Tra Sutekichi e la proprietaria dello baracca, Osugi, è in atto da tempo una tresca, di cui il marito è all'oscuro.
Sutekichi è stanco della donna, attraente ma arida e cinica, e da tempo tenta invano di sostituirla con la sorella Okayo.
Osugi le fa un'ultima proposta: fuggire assieme, dopo avere ucciso Rokubei per liberarsi di lui e sottrargli ogni avere.
Rokubei li sorprende nel mezzo della discussione, reagendo furiosamente, e Sutekichi anche lui in preda all'ira, gli mette le mani addosso e forse non si tratterrebbe dallo strangolarlo.
Il solito provvidenziale Kahei ridestandosi "casualmente" dal sonno con un sonoro sbadiglio fa capire a Sutekichi che non è il caso di insistere di fronte a tanti testimoni: l' unico ambiente della baracca non consente intimità, né per scambiarsi amore né per scambiarsi odio.
 E non è nemmeno facile rompere il circolo vizioso che i benpensanti hanno steso sugli abitanti dello squallido rifugio.
E non è nemmeno facile rompere il circolo vizioso che i benpensanti hanno steso sugli abitanti dello squallido rifugio.
Il poliziotto di quartiere Shimazo, che non è altri che lo zio di Osugi, frequenta assiduamente la baracca.
In realtà si interessa soprattutto a godersi le discutibili grazie della dolciaia Otaki o passa le nottti a giocare d'azzardo, assieme al grasso borghese Tsugaru, nella bisca di Yoshisaburo.
 Il saggio Kahei, che ha già accompagnato ad una dolce morte la sventurata Asa, convincendola che sarebbe stata la fine definitiva delle sue sofferenze, ha la soluzione giusta anche per Sutekichi.
Il saggio Kahei, che ha già accompagnato ad una dolce morte la sventurata Asa, convincendola che sarebbe stata la fine definitiva delle sue sofferenze, ha la soluzione giusta anche per Sutekichi.
Abbandoni al più presto quello squallore: dimentichi Osugi e vada a rifarsi una vita altrove.
Purtroppo Sutekichi, così forte ed aggressivo fisicamente, non ha altrettanta fermezza nel carattere.
Non sa decidersi, e la sua indecisione conduce alla tragedia.
 Scoppia una lite tra Okayo ed Osugi, che le tira addosso dell'acqua bollente.
Scoppia una lite tra Okayo ed Osugi, che le tira addosso dell'acqua bollente.
Attirati dalle grida gli occupanti della baracca irrompono nella casa dei proprietari, approfittandone per fare man bassa di tutto quello che trovano e - nella confusione - per malmenare i due avvoltoi.
 Corrono a chiamare Sutekichi, che arriva di furia.
Corrono a chiamare Sutekichi, che arriva di furia.
Con uno spintone allontana Rokubei per andare a soccorrere Okayo.
Rokubei cade in malo modo: sbatte la testa e muore sul colpo.
 Apparentemente sconvolta, Osugi è in realtà trionfante: si libera in un colpo solo dell'incomodo marito e dell'ormai scomodo amante.
Apparentemente sconvolta, Osugi è in realtà trionfante: si libera in un colpo solo dell'incomodo marito e dell'ormai scomodo amante.
Questi non accetta di essere accusato di omicidio assistendo impotemte al trionfo di Osugi.
Confessa di avere agito volontariamente, per quanto sia stato un incidente, ma chiama come correa la donna, che lo ha incitato ripetutamente ad ucidere il marito.
 Okayo, lei veramente sconvolta, pensa di essere stata sempre tradita ed ingannata da Sutekichi.
Okayo, lei veramente sconvolta, pensa di essere stata sempre tradita ed ingannata da Sutekichi.
Lo respinge e lo rinnega.
 E' passato del tempo: Kahei abbandona il tugurio, dove ha invano tentato di portare un raggio di luce, una ventata di ottimismo.
E' passato del tempo: Kahei abbandona il tugurio, dove ha invano tentato di portare un raggio di luce, una ventata di ottimismo.
Ha ancora il tempo di raccogliere le ultime confidenze di Osen, che afferma o forse sogna di essere amata da un uomo per cui anche una prostituta può essere pura, e di Yoshisaburo che per una donna ha ucciso.
Le carte si sono rimescolate per loro come per tutti gli altri, ma senza che in realtà sia cambiato nulla.
 Sutekichi è stato condannato all' esilio, Osugi è in carcere, di Okayo non si hanno notizie.
Sutekichi è stato condannato all' esilio, Osugi è in carcere, di Okayo non si hanno notizie.
Tsugaru, licenziato dalla polizia, è diventato anche lui un inquilino della baracca ed ha sposato Otaki.
Si è unito al gruppo anche il grasso Tsugaru, che assilla tutti con le sue fissazioni religiose.
Sembra che i bassifondi attirino a se irresistibilmente anche le persone relativamente benestanti che pensavano di sfruttarne le miserie.
 Non che questo preoccupi più d tanto chi è rimasto.
Non che questo preoccupi più d tanto chi è rimasto.
Per annegare la noia e la malinconia, improvvisano un grottesco balletto, accompagnandosi con strumenti improvvisati.
Li interrompe Tonosama, che rientra fradicio di pioggia dall'esterno: l'attore alcolizzato si è impiccato ad un albero!
Rimangono tutti pietrificati, passando da scoordinate pose grottesche ad una tragica posa di gruppo.
 E' Yoshisaburo a trarre la cinica morale della favola:
E' Yoshisaburo a trarre la cinica morale della favola:
"Che peccato... Ha interrotto un ballo così belo."
Così termina questa sinfonia macabra, scritta da Maxsim Gorkij, adattata e diretta dal maestro Akira Kurosawa.

Akira Kurosawa: I sette samurai
1954
Takashi Shimura, Toshiro Mifune, Seiji Miyaguchi, Isao Kimura, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Minoru Chiaki
Gli abitanti di un misero villaggio, sottoposto a continui attacchi dei predoni, decidono di assoldare un gruppo di samurai che li difenda. Hanno da offrire solo il vitto, quindi il drappello che riescono ad assemblare è quanto mai eterogeneo e composto soprattutto da samurai senza ambizioni e senza pretese che hanno fatto esperienza “perdendo tutte le battaglie cui hanno partecipato”, come dice il loro capo Kanbei. Fra di loro il silenzioso ed enigmatico Kyuzo, imbattibile con la spada e che per ragioni inspiegabili accetta la modesta proposta pur potendo mirare a ben altro, il giovane ed ingenuo Katsushiro, ed un pittoresco fanfarone: Kikuchiyo, impersonato da Toshiro Mifune nel suo primo ruolo picaresco, che seppe rendere indimenticabile. Aveva fino ad allora recitato in ruoli drammatici e sembrava a quelli confinato, ma come certi samurai hanno sette vite, Mifune sembra aver avuto sette e più personalità nel suo carniere.
Akira Kurosawa: Rashomon
1950
Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Kichijiro Ueda, Daisuke Kato, Toshiro Mifune, Masayuki Mori, Machiko Kyo, Noriko Honma
 Tratto dalla fusione dei due racconti di Ryunosuke Akutagawa Rashomon e Nel bosco, pubblicati nell'omonima raccolta Rashomon, narra la sconcertante vicenda di un misterioso delitto: un samurai viene trovato ucciso nel bosco, e la ricostruzione dei fatti effettuata attraverso interrogatori dei protagonisti porta a diverse versioni non solo contraddittorie ma anche inquietanti.
Tratto dalla fusione dei due racconti di Ryunosuke Akutagawa Rashomon e Nel bosco, pubblicati nell'omonima raccolta Rashomon, narra la sconcertante vicenda di un misterioso delitto: un samurai viene trovato ucciso nel bosco, e la ricostruzione dei fatti effettuata attraverso interrogatori dei protagonisti porta a diverse versioni non solo contraddittorie ma anche inquietanti.
Ognuna infatti comprende sia indubitabili verità che elementi inspiegabili e inaccettabili.
Anche le versioni della vittima, che parla attraverso una veggente, e di un testimone estraneo ai fatti piuttosto che chiarire portano ulteriori elementi di confusione.
E' la prima opera con cui Kurosawa venne conosciuto all'estero, ed è impreziosita da una grande interpretazione di Toshiro Mifune nella parte del brigante Tajomaru.
 Come spesso in altre occasioni Kurosawa, che non esitava ad attingere all'occidente per le sue trame, fu a sua volta fonte di ispirazione.
Come spesso in altre occasioni Kurosawa, che non esitava ad attingere all'occidente per le sue trame, fu a sua volta fonte di ispirazione.
 A Rashomon si ispirano nel 1960 Ingmar Bergman con La fontana della vergine, che definì una miserabile imitazione di Rashomon tuttavia riprende una leggenda svedese del XIV secolo, Töre's dotter i wänge.
A Rashomon si ispirano nel 1960 Ingmar Bergman con La fontana della vergine, che definì una miserabile imitazione di Rashomon tuttavia riprende una leggenda svedese del XIV secolo, Töre's dotter i wänge.
E nel 1964 Martin Ritt in L'oltraggio, con Paul Newman, Lawrence Harvey, Claire Bloom ed Edward G. Robinson, che si spinge fino a riprendere non solo la sceneggiatura di Kurosawa ma anche le ambientazioni e gran parte delle scelte registiche.
La straordinaria tensione della vicenda tende a non lasciar notare la grande semplicità dell'impianto scenico. Solamente otto interpreti appaiono sullo schermo, e ognuno di loro fornisce una prova superba, su cui quella di Mifune spicca ma senza sovrastare le altre.
Fatta menzione del protagonista principale, è difficile stabilire tra gli altri delle priorità o attribuire maggiori o minori meritl, verranno quindi citati in ordine di apparizione.
 Takashi Shimura (1905-1982)
Takashi Shimura (1905-1982)
Apparso per la prima volta sullo schermo nel 1936, fu l'interprete favorito di Akira Kurosawa, ricoprendo già un ruolo in Sugata Sanshiro (1943), sua opera prima.
A 74 anni, poco prima della morte, fu il generale Taguchi in Kagemusha nella sua ultima apparizione sullo schermo. Discendente di una famiglia samurai del clan Tosa, di lui Kurosawa diceva: "Era un leader, e la sua forza consisteva nel non sembrarlo".
Interpreta il ruolo di un boscaiolo che recandosi al lavoro scopre nella foresta il cadavere di un samurai, ucciso da una ferita di spada. Da lì inizia la vicenda, attraverso il racconto che il boscaiolo ed un altro testimone fanno ad una terza persona, che si è rifugiata per ripararsi dalla pioggia torrenziale all'interno delle rovine della porta Rashomon, dove li ha trovati immersi nei loro pensieri.
 Minoru Chiaki (1917-1999)
Minoru Chiaki (1917-1999)
La sua interpretazione più conosciuta è quella del samurai Heihachi (I sette samurai) ma apparve in totale in sette opere di Kurosawa.
In Rashomon interpreta la parte del monaco errante con cui il boscaiolo condividue i suoi dubbi sul delitto.
Turbato dalla constatazione che nessuna delle persone coinvolte nella vicenda può dirsi esente da vizi e colpe, viene tuttavia da lui al termine del film un invito all'ottimismo.
 Kichijiro Ueda (1904-1972)
Kichijiro Ueda (1904-1972)
Appare, ma in ruoli di contorno, anche in altre
opere di Kurosawa (Il trono di sangue e La fortezza nascosta).
Qui è l'uomo che riparandosi dalla pioggia si imbatte per caso nel boscaiolo e nel monaco, e li convince a narrargli la vicenda.
Il suo cinismo e il suo scetticismo lo portano ad intuire un brandello di verità - sfuggito fino ad allora ad ogni indagine - ma anche a commettere atti spregevoli.
 Daisuke Kato (1910-1975)
Daisuke Kato (1910-1975)
Presenza costante nei film di Kurosawa, ove appare qui per la prima volta, il suo ruolo più conosciuto è certamente, pochi anni dopo, quello dell'allegro lanciere Shichiroji (I sette samurai); appare anche in Yojimbo come lo sciocco fratello dell'antagonista Unosuke.
Fu tra gli attori più ricercati del cinema giapponese, nella sua carriera si contano oltre 170 film.
Qui riveste i panni di un poliziotto, che credendo di soccorrere la vittima di un incidente di viaggio si trova invece al cospetto del brigante Tajomaru, ridotto all'impotenza da un avvelenamento, e lo arresta.
 Toshiro Mifune (1920-1997)
Toshiro Mifune (1920-1997)
L'attore più noto del cinema giapponese, che appare quasi sempre come protagonista in circa 200 film, fu anche l'attore prediletto di Akira Kurosawa. Il sodalizio si ruppe al termine delle riprese di Akahige, nel 1965, per insanabili contrasti sorti durante la lavorazione.
Interpreta con animalesca ed incontrollata energia il brigante Tajomaru, capace di ogni nefandezza eppure stranamente trasparente - non possiamo dire certamente innocente - in ogni suo atteggiamento. Un ruolo che ricorda, ma con una luce sinistra, quello interpretato in chiave comica pochi anni dopo nei panni dello stravagante Kikuchiyo (I sette samurai)
Invaghitosi dopo una sola occhiata rubata sotto al velo della moglie di un samurai di passaggio, ammette anzi rivendica di avere ucciso lui in duello e violentato lei, che tuttavia, nonostante le apparenze, non era del tutto riluttante.
 Masayuki Mori (1911-1973)
Masayuki Mori (1911-1973)
Aveva già lavorato agli ordini del maestro in Zoku Sugata Sanshiro e in Tora no ofumu otokotachi, nelle vesti dell'arrogante ufficiale di collegamento che intende arrestare il principe Yoshitsune.
Ora è il samurai vittima dell'assassinio. Evocato attraverso una veggente, il suo spirito espone una versione dei fatti che smentisce totalmente quella dei confessi assassini.
 Machiko Kyo (1924)
Machiko Kyo (1924)
Fu utilizzata, come anche Masayuki Mori, dal grande Kenji Mizoguchi, scomparso prematuramente.
Proprio assieme a Mori è protagonista dell'ultima opera di Mizoguchi, Ugetsu monogatari.
Appare nella parte di una donna esposta come un fuscello alla volontà prevaricatrice degli uomini, che dispongono di lei come un oggetto, eppure capace di ribellarsi e diventare la padrona della situazione, nel bene e nel male.
 Noriko Honma (1910)
Noriko Honma (1910)
Più conosciuta come Furiko Honma, apparve per la prima volta in un film di Kurosawa con Cane randagio, continuando poi una proficua carriera durante la quale collaborò ancora col maestro: I sette samurai, Akahige, ed infine Sogni, nel 1990. La sua ultima interpretazione è del 2006.
E' qui una veggente, che il tribunale ha deciso di convocare per ascoltare, attraverso lei, la testimonianza del samurai assassinato.
 Il tribunale
Il tribunale
E' un importante protagonista di Rashomon, ma non lo vedremo mai.
In realtà non ascolteremo mai nemmeno la voce dei magistrati, per quanto la camera mostri i testimoni dal loro punto di vista, senza quasi mai modificare l'inquadratura (una delle tante innovazioni anticonformiste che Kurosawa adottò nell'opera).
Le loro domande vengono solamente intuite attraverso le risposte dell'imputato Tajomaru e dei cinque testimoni che si susseguono.
La vicenda è ambientata in una località imprecisata nei pressi di Kyoto, e si svolge durante l'epoca Heian (VIII-XII secolo).
Nel mezzo di un temporale che sembra non voler mai cessare, tra le rovine della porta Rashomon si sono rifugiati come detto tre uomini. Un boscaiolo ed un bonzo, testimoni del delitto ed ancora turbati da quanto hanno visto ed ascoltato, ed un uomo di passaggio che incuriosito li invita a narrare quanto successo.
 Della porta Rajomon (questo il nome originario) nulla era rimasto e Kurosawa la fece ricostruire negli studi di posa, ma senza avere alcun elemento concreto cui ispirarsi.
Della porta Rajomon (questo il nome originario) nulla era rimasto e Kurosawa la fece ricostruire negli studi di posa, ma senza avere alcun elemento concreto cui ispirarsi.
Aveva dichiarato ailla casa di produzione, la Daiei, che gli sarebbero serviti solamente due set, quello ed il cortile del tribunale, mentre il resto delle riprese sarebbe stato effettuato nei boschi.
Ci si aspettava quindi un'opera girata in economia, considerato anche il ridotto numero degli attori, ma al termine del film i produttori constatarono sconsolati che la porta Rashomon era costata da sola quanto un centinaio di set normali.
Kurosawa si giustificava alcuni anni dopo, con una punta di ironia, dicendo di non aver avuto all'inizio intenzione di farne qualcosa di tanto monumentale.
 E' il boscaiolo ad iniziare il racconto. Con la sua ascia in spalla, era in cammino in mezzo alla foresta.
E' il boscaiolo ad iniziare il racconto. Con la sua ascia in spalla, era in cammino in mezzo alla foresta.
Per la prima volta una macchina da presa si addentrava deliberatamente all'interno di un bosco, sfidandone le difficilissime condizioni di luce.
Kurosawa aveva già tentato l'esperimento nel corso di Tora no ofumu otokotachii, la sua terza opera (1945) e la prima di ambientazione jidai. Ora lo riprende e lo estende: le riprese non sono più da un punto fisso, le cinecamere si muovono, ricreando nella mente dello spettatore l'impressione di camminare o correre nel fitto di una foresta.
Altra innovazione tecnica, che va al di là di ogni schema di ripresa precedente, è l'inquadratura del sole che filtra tra i rami.
 Nessuno prima di allora aveva ripreso il sole, si diceva addirittura, come racconta Kurosawa nel suo libro Something like an autobiography, che i raggi del sole fossero in grado di danneggiare la pellicole, le apparecchiature e perfino gli spettatori.
Nessuno prima di allora aveva ripreso il sole, si diceva addirittura, come racconta Kurosawa nel suo libro Something like an autobiography, che i raggi del sole fossero in grado di danneggiare la pellicole, le apparecchiature e perfino gli spettatori.
Concentrato nel suo lavoro, aveva perso in comunicativa, finché un giorno Takashi Shimura gli comunicò le preoccupazioni dell'operatore, Kazuo Miyagawa, che temeva di non essere riuscito ad effettuare le riprese come richiestogli.
Kurosawa, che dentro di sé esclamava spesso "Meraviglioso! e aveva in qualche modo la sensazione di averlo detto a tutti, finalmente esclamò enfaticamente: "Al cento per cento! Al cento per cento! Al cento per cento e più!".
Al Festival di Venezia, dove l'opera fu presentata vincendo il Leone d'oro, queste scene destarono sensazione.
Per le riprese nel bosco si girò prima nella foresta di Nara e poi in un bosco di montagna nelle vicinanze del tempio Komyogi,
 Il taglialegna (Takashi Shimura), in cammino per andare ad abbattere dei cipressi, sembra avvertire qualcosa di inquietante nell'atmosfera del bosco.
Il taglialegna (Takashi Shimura), in cammino per andare ad abbattere dei cipressi, sembra avvertire qualcosa di inquietante nell'atmosfera del bosco.
Il sottofondo musicale curato da Fumio Hayasaka, ritmato da un tamburo, già insiste sul tema del Bolero, composto dal compositore francese Maurice Ravel nel 1928: una ossessionante cantilena in continuo crescendo.
 Ad un tratto si imbatte in una serie di oggetti abbandonati per terra o impigliati tra i rami che destano la sua curiosità.
Ad un tratto si imbatte in una serie di oggetti abbandonati per terra o impigliati tra i rami che destano la sua curiosità.
Tra gli altri un cappello da donna, e una corda tagliata, che ha l'aria di essere stata usata prima per legare qualcosa o qualcuno.
E' evidente che qualcosa di strano deve essere accaduto.
 E continuando nelle sue ricerche, seguendo il filo degli oggetti sparsi qua e là, si imbatte infine in una orrenda visione.
E continuando nelle sue ricerche, seguendo il filo degli oggetti sparsi qua e là, si imbatte infine in una orrenda visione.
Il corpo senza vita di un samurai, seminascosto tra le foglie, immobilizzato in una posa atroce nel momento della morte.
Riesce appena a notare che ha una ferita sul corpo, che ne ha evidentemente causato il decesso.
 Il boscaiolo fugge a perdifiato.
Il boscaiolo fugge a perdifiato.
Ci troviamo ora di fronte al giudice; non lo vedremo mai, né mai ascolteremo la sua voce, ma le sue domande vengono immediatamente intuite attraverso le risposte dei testimoni e dell'imputato.
 Sappiamo che si tratta di un giudice monocratico e non di un collegio solamente dalla lettura del racconto originale di Akutagawa, che si apre con le parole "Racconto di un boscaiolo che risponde al giudice".
Sappiamo che si tratta di un giudice monocratico e non di un collegio solamente dalla lettura del racconto originale di Akutagawa, che si apre con le parole "Racconto di un boscaiolo che risponde al giudice".
Ci troviamo non dentro un'aula, ma in un cortile assolutamente spoglio, chiuso da un alto muro.
La testimonianza del boscaiolo non può chiarire molto. Tutto quello che può dire è di avere trovato il cadavere per caso, in un posto solitario ad una certa distanza dalla strada.
Aveva una sola ferita, mortale, al cuore e nei suoi dintorni non c'era alcun oggetto, tranne una corda ed un pettine femminile.
 Nemmeno il bonzo (Minoru Chiaki) può dire molto. Durante il suo percorso senza meta aveva incrociato lungo la strada un samurai, armato della spada e di un arco, con venti frecce.
Nemmeno il bonzo (Minoru Chiaki) può dire molto. Durante il suo percorso senza meta aveva incrociato lungo la strada un samurai, armato della spada e di un arco, con venti frecce.
Era quindi anche lui un viandante, diretto chissà dove.
Conduceva per la briglia un cavallo su cui era una donna completamente velata, di cui quindi era impossibile scorgere le fattezze, nemmeno comprendere l'età.
 Il monaco è scosso dalla caducità dell'essere umano.
Il monaco è scosso dalla caducità dell'essere umano.
Quel samurai così orgoglioso e fiero d'aspetto, poco dopo era nulla più che una misera spoglia.
Sappiamo, sempre dal testo di Akutagawa, che si sarebbe trattato di un giovane samurai della provincia di Wakasa: Takehiro Kanazawa.
Sua moglie, era lei la donna sul cavallo, si chiamava Masako ed aveva solamente 19 anni.
 La successiva testimonianza conduce ad una drammatica svolta nelle indagini.
La successiva testimonianza conduce ad una drammatica svolta nelle indagini.
Un informatore di polizia (Daisuke kato), visibilmente compiaciuto, conduce con sé un uomo saldamente legato.
Come in tutti paesi del mondo l'informatore è solo un piccolo delinquente implicato in lievi reati, rilasciato a condizione di collaborare e tenere informate le autorità di quanto succede nel sottobosco della criminalità.
L'uomo legato è invece un famigerato e fino ad allora inafferrabile brigante: Tajomaru (Toshiro Mifune).
 Kurosawa ce lo presenta assorto ad osservare le nuvole, completamente dimentico della situazione in cui si trova: destinato ad una inevitabile condanna a morte per decine di gravi reati.
Kurosawa ce lo presenta assorto ad osservare le nuvole, completamente dimentico della situazione in cui si trova: destinato ad una inevitabile condanna a morte per decine di gravi reati.
Mifune dé per la prima volta in questo film (un accenno era in L'angelo ubriaco) piena dimostrazione della sua recitazione provocatoria, in cui alterna momenti di assenza dal mondo ad esplosioni di improvvise reazioni, violente ed incontrollate, a fatti di scarsa rilevanza.
I suoi sentimenti non vengono manifestati solamente dalle espressioni del volto o dalle tonalità della voce.
E' con tutto il corpo, attraverso movimenti improvvisi e rabbiosi o minimalistici gesti abitudinari, potremmo dire con tutta la sua personalità, che Mifune contribuisce a rendere manifesto ogni stato d'animo dei personaggi che interpreta.
 Quando Tajomaru ha uno scatto d'ira è per contestare la deposizione dell'informatore.
Quando Tajomaru ha uno scatto d'ira è per contestare la deposizione dell'informatore.
Non è per negare di essere un malvivente: ma per sfuggire all'onta di essersi lasciato catturare da un imbelle.
 Uno strano avvelenamento, aveva bevuto avidamente da una sorgente, lo aveva fatto cadere preda di un malore.
Uno strano avvelenamento, aveva bevuto avidamente da una sorgente, lo aveva fatto cadere preda di un malore.
Solamente per questa ragione era caduto da cavallo, sul bordo del fiume, e non aveva potuto opporre resistenza quando l'informatore l'aveva legato ed arrestato.
Aveva ancora con sé le stesse frecce che il bonzo ha testimonato di avere visto nella faretra del samurai ucciso, ed anche il cavallo che era con lui sembra lo stesso su cui viaggiava la donna sconosciuta.
E' evidente che abbia avuto in qualche modo a che fare col delitto, è il primo indiziato per l'assassinio.
 Tajomaru dichiara sprezzantemente di essere a conoscenza del suo destino: di lì a poco sarà sicuramente impiccato, non ha quindi alcun interesse a mentire per alleviare la sua posizione in quell'ultimo irrilevante delitto.
Tajomaru dichiara sprezzantemente di essere a conoscenza del suo destino: di lì a poco sarà sicuramente impiccato, non ha quindi alcun interesse a mentire per alleviare la sua posizione in quell'ultimo irrilevante delitto.
Ma vuole almeno dire la sua. E la dirà.
 Il brigante stava oziando ai piedi di un grande albero, nei pressi del sentiero.
Il brigante stava oziando ai piedi di un grande albero, nei pressi del sentiero.
Kurosawa ce lo presenta con un aspetto picaresco, vestito di pochi cenci che non celano il corpo, muscoloso e minaccioso.
Nel racconto di Akutagawa si diceva invece che era vestito di un kimono blu (viene ripetuto anche nel film, dalla moglie del samurai: evidentemente una piccola svista in un'opera altrimenti praticamente perfetta).
Tajomaru è la versione drammatica di quello che sarà poi, il buffo Kikuchiyo (I sette samurai); il loro aspetto esteriore è praticamente identico, fatta eccezione per l'arma: Kikuchiyo avrà con sé un gigantesco nodachi (spadone a due mani). Gli straccioni si assomigliano tutti, anche a distanza di secoli.
L'arma di Tajomaru è invece uno tsurugi, una spada a doppio taglio con lama diritta, utilizzata arcaicamente prima dell'avvento del nihonto, la lama giapponese lunga e arcuata, col tagliente nella parte convessa.
 Tajomaru si ridesta all'improvviso dal suo torpore.
Tajomaru si ridesta all'improvviso dal suo torpore.
Ha sicuramente sentito qualcuno avvicinarsi lungo il sentiero, e quando riapre gli occhi vede qualcosa che non dimenticherà mai.
Il samurai appiedato che conduce il cavallo per le briglie riveste per lui solamente un interesse professionale.
E' riccamente vestito e le sue armi sono di indubbio valore: potrebbe essere una ricca preda, per quanto difficile: è un uomo non solo armato, ma anche addestrato alle armi.
E' dopo che Tajomaru viene colpito, quando meno se lo sarebbe aspettato.
 La donna che si trova sul cavallo è completamente nascosta agli sguardi, come d'uso all'epoca per le donne del suo lignaggio si nasconde agli estranei sotto un largo cappello da cui pendono dei veli.
La donna che si trova sul cavallo è completamente nascosta agli sguardi, come d'uso all'epoca per le donne del suo lignaggio si nasconde agli estranei sotto un largo cappello da cui pendono dei veli.
Ma un colpo di vento allontana per un attimo i veli.
In quell'attimo, anche se riesce più ad intuirne il volto che a scorgerlo realmente, Tajomaru sa che non avrà più pace finché non avrà avuto quella donna.
E' la moglie del samurai, come si intuisce dalle sopracciglia rasate che indicano il suo stato di donna sposata.
 Affascinato Tajomaru continua a seguire con lo sguardo la coppia che si allontana lungo il sentiero.
Affascinato Tajomaru continua a seguire con lo sguardo la coppia che si allontana lungo il sentiero.
Li seguirà, e cercherà in tutti i modi di raggiungere il suo scopo: depredarli, ma soprattutto avere la donna.
In una sequenza durata lo spazio di pochi secondi Kurosawa è riuscito a trasmettere una incredibile quantità di messaggi, e ad alzare la tensione emotiva a livelli quasi insopportabili.
Questa fase della vicenda è leggibile nei volti dei protagonisti, e bisogna rendere merito ai magnifici attori che si sono prestati ad essere gli strumenti del maestro.
La voce narrante, in questo caso quella stessa del brigante Tajomaru, potrebbe anche essere soppressa: ogni spettatore sarebbe ugualmente in grado di comprendere.
Non solo quello che sta succedendo ma anche quello che succederà, non solo quali saranno le azioni di ogni singolo protagonista, ma perfino quelli che saranno i loro pensieri, desideri, timori, dubbi.
 Tajomaru segue a lungo la coppia. Giunti al luogo che ha in mente, esce d'improvviso davanti a loro, sbucando dal bosco.
Tajomaru segue a lungo la coppia. Giunti al luogo che ha in mente, esce d'improvviso davanti a loro, sbucando dal bosco.
Il suo aspetto è selvaggio, i suoi modi provocatori e con una punta di follia.
Anche questi modi comportamentali sono un'anticipazione di quelli che Mifune adotterà poi nel ruolo di Kikuchiyo e dopo ancora in quello del giovane Miyamoto Musashi nella trilogia dedicata al grande samurai da Hiroshi Hinagaki.
E' strano pensare che si adattino perfettamente ad un brigante incallito, ad un grezzo fanfarone dal cuore tenero, ed infine ad un invincibile guerriero ancora alla ricerca di sé stesso.
 Quando Tajomaru estrae la spada il samurai è già sull'avviso.
Quando Tajomaru estrae la spada il samurai è già sull'avviso.
Ma una risata derisoria lo accoglie: proprio questa spada sarà lo strumento del tranello ordito dal brigante.
La mostra con orgoglio, la offre per un esame. Quella spada, di antica fattura, proviene da un tumulo che ha scoperto, là nella foresta. Ne ha trovate altre, assieme a degli specchi, ed è pronto a venderle a buon prezzo.
La spada e lo specchio - assieme ad un magico gioiello - sono come sapranno molti i simboli divini del Giappone. Quelli appartenuti secondo la leggenda alla dea Amaterasu, come narrato nel Kojiki, fanno parte del tesoro imperiale e lla loro visione è riservata alla famgilia regnante.
Quindi tutto indicherebbe che quei tumuli contenevano i tesori di una famgilia di nobili.
 Il samurai (Masayuki Mori) non riesce a resistere alla tentazione, forse nemmeno tenta.
Il samurai (Masayuki Mori) non riesce a resistere alla tentazione, forse nemmeno tenta.
Seguirà Tajomaru nel bosco, là dove si troverebbe il tesoro sotterrato. La sua donna attenderà là, il cavallo non può avventurarsi nel fitto della boscaglia.
 Là giunti cade facilmente nel tranello. Tajomaru l'assale alle spalle quando si deconcentra credendo di essere arrivato sul luogo del tesoro, riesce a sopraffarlo e lo immobilizza con una corda.
Là giunti cade facilmente nel tranello. Tajomaru l'assale alle spalle quando si deconcentra credendo di essere arrivato sul luogo del tesoro, riesce a sopraffarlo e lo immobilizza con una corda.
Quella stessa corda, tagliata di netto, che il boscaiolo avrebbe ritrovato poi.
Kurosawa non precisa lo stacco temporale che passa tra i fatti ed il processo, Akutagawa nel suo raccontro era invece stato esplicito: tutto si sussegue in uno spazio di tempo molto breve.
Il giorno dopo l'assassinio Tajomaru già si trova davanti al giudice, e questa volta sarà lui ad essere saldamente legato.
La donna è rimasta sola in mezzo ad una radura, accanto al suo cavallo, ancora ammantata e celata dai veli.

Tajomaru ha già immobilizzato il samurai, sta già correndo a perdifiato nella foresta per poi gettarsi su di lei.
La sequenza è analoga a quella iniziale del boscaiolo che fugge dall'orrore della morte.
Due sequenze simili per illustrare due situazioni opposte.
Una fuga, ed una corsa affannosa verso un obiettivo ferocemente voluto.
Il tentativo di dimenticare, o perlomeno di allontanare da sé, e l'attesa frenetica di un momento di voluttà.
 Al termine della folle corsa, Tajomaru non è ancora pronto a cogliere il frutto della sua attesa, del suo complotto, della sua lotta.
Al termine della folle corsa, Tajomaru non è ancora pronto a cogliere il frutto della sua attesa, del suo complotto, della sua lotta.
Si attarda ancora celato dietro ai cespugli a guardare la donna, non visto.
 Per la prima volta vediamo in volto Masako (Machiko Kyo): è giovanissima, terrorizzata.
Per la prima volta vediamo in volto Masako (Machiko Kyo): è giovanissima, terrorizzata.
Ma l'apparente fragilità della donna cela una grande forza di volontà
Tajomaru è comparso all'improvviso, dicendole che il marito è stato morso da un serpe velenosa, occorre andarlo a soccorrere.
La donna, nei ricordi del bandito, appariva come una statua di ghiaccio, pallida per l'angoscia.
Tajomaru era stato colto da una folle invidia, da una assurda gelosia, e l'aveva trascinata di corsa fino al luogo dove aveva lasciato saldamente legato il samurai.
Qui, di fronte a lui, dove ha voluto andare in segno di spregio, diventano finalmente manifeste le sue intenzioni
 Masako estrae il kwaiken, il pugnale che ogni donna samurai porta con sé, celato nelle vesti, e si difende strenuamente.
Masako estrae il kwaiken, il pugnale che ogni donna samurai porta con sé, celato nelle vesti, e si difende strenuamente.
Tajomaru inizialmente è in difficoltà: la donna sa maneggiare l'arma, lo ferisce.
Questo paradossalmente non ha altro effetto che aumentare la sua determinazione ed il suo desiderio.
La lotta non è solo fisica, è soprattutto psicologica, e alla lunga non può che avere un esito scontato.
Dapprima le parti imprevedibilmente si capovolgono: è Masako che dà la caccia al bandito, tentando di ucciderlo.
Ma Tajomaru si sottrae facilmente agli attacchi rinunciando all'assalto frontale.
Logorerà la sua vittima sia fisicamente che mentalmente, lasciandole comprendere che nulla e nessuno potrà sottrarla al suo detino, che ogni resistenza è inutile.
Giocando in definitiva con lei come il gatto col topo.
Durante i suoi disperati assalti Masako piange ininterrrottamente.
 Alla fine dovrà desistere, spossata, senza più alcuna energia, capacità o volontà di resistere, lasciandosi cadere al suolo.
Alla fine dovrà desistere, spossata, senza più alcuna energia, capacità o volontà di resistere, lasciandosi cadere al suolo.
Tajomaru è su di lei.
La macchina da presa inquadra ancora una volta il disco solare, che appare tra il fogliame.
 Masako ha un ultimo disperato guizzo di resistenza.
Masako ha un ultimo disperato guizzo di resistenza.
Non ha abbandonato il pugnale, ha continuato a tenerlo spasmodicamente stretto nella mano.
Ora lo alza, sta per vibrare un colpo mortale. Ma la mano di Tajomaru le afferra il polso, lo blocca, lo stringe con forza.
Lentamente, il pugnale scivola dalla mano e cade al suolo.
 La mano di Masako, oramai priva di ogni arma, simbolo della sua mente oramai incapace di opporsi alla violenza, avvinghia la schiena di Tajomaru.
La mano di Masako, oramai priva di ogni arma, simbolo della sua mente oramai incapace di opporsi alla violenza, avvinghia la schiena di Tajomaru.
 Tutto si è compiuto.
Tutto si è compiuto.
Il bandito sta per andarsene, soddisfatto di sé, dopo aver portato a termine con pieno successo tutto quello che si era prefisso.
Masako si aggrappa ancora a lui: non può andar via così, lasciandola nel disonore.
La sua richiesta è terribile, ma terribilmente logica, e non è nemmeno lei ad avanzare la richiesta, ma il destino.
Uno dei due uomini deve morire.
 Morirà il bandito, unico testimone oltre che autore dell'oltraggio, o morirà il samurai.
Morirà il bandito, unico testimone oltre che autore dell'oltraggio, o morirà il samurai.
Masako seguirà allora le sorti del bandito, diventando la sua donna.
Tajomaru esita a lungo.
Il samurai, impotente, legato, si limita ad osservare, impenetrabile. Anche lui sembra tramutato in una statua di ghiaccio.
Dopo una lunga esitazine, Tajomaru gli si avvicina, estraendo lo tsurugi.
Senza dire nulla, taglia i legami e rende al samurai il suo lungo tachi.
 Lo scontro è violento, inzialmente senza alcuna tattica, senza alcun tentativo di dilazionarne l'esito, senza riguardo per la propria vita.
Lo scontro è violento, inzialmente senza alcuna tattica, senza alcun tentativo di dilazionarne l'esito, senza riguardo per la propria vita.
I due uomini vogliono ferocemente uccidersi l'un l'altro, ed in questo momento è una loro faccenda che nulla ha più a che fare con la donna.
E' solo la volontà selvaggia di due animali che lottano per la supremazia.
Gradualmente la personalità selvaggia ed imprevedibile di Tajomaru, come già successo nei confronti della donna, prevale sulla fredda tecnica e sulla dissennata rabbia del samura.
Entrando in un insanabile conflitto interno, renderà sé stesso una facile preda.
 Al termine della cruenta lotta, Tajomaru infine lo abbatte, là dove poi lo troverà il boscaiolo.
Al termine della cruenta lotta, Tajomaru infine lo abbatte, là dove poi lo troverà il boscaiolo.
La rappresentazione del duello appare realistica alla stragrande maggioranza degli spettatori, ma glli esperti di spada la troveranno poco verosimile.
Agli effetti artistici non ha eccessiva importanza, sulla scena è sufficiente apparire realistici allo spettatore medio, e già questa scena è molto più attendibile di quelle visibili nelle opere coeve. Inoltre va ricordato che l'azione si svolge intorno al XIII secolo, almeno 300 anni prima delle scuole di spada che si sono tramandate fino ad oggi.
Non poteva però ugualmente essere del tutto soddisfatto Akira Kuroswawa. Sappiamo dalla sua biografia che era stato un appassionato praticante di kendo, arte che lo stesso Mifune ha continuato a praticare per tutta la vita.
Nella sua successiva opera jidai, I sette samurai, Kurosawa chiese al Ministero della Pubblica istruzione che gli fossero indicati dei consulenti in grado di guidare sceneggiatori ed attori nelle scene di combattimento. Vennero designati come tateshi i maestri Yunzo Sasamori (Hana ha Itto ryu) e Yoshio Sugino (Katori Shinto ryu ed Aikido). Questultimo continuò poi per molti anni la collaborazione con Kurosawa.
 Concludendo il suo racconto Tajomaru rivendica con orgoglio l'epicità del combattimento.
Concludendo il suo racconto Tajomaru rivendica con orgoglio l'epicità del combattimento.
Solo dopo 23 assalti è riuscito ad avere ragione del suo avversario: non aveva mai rovato alcuno in vita sua che riuscisse ad opporgli tanta ostinata resistenza.
Quanto alla donna, poco gliene importa.
Terminato il duello, si era improvvisamente reso conto che lei non era più là. Era come scomparsa nel nulla.
Ma quell'insano e folle desiderio che lo aveva portato al delitto, così improvvisamente come era venuto, improvvisamente era scomparso.
Scomparso nel nulla come era scomparsa la donna.
 Qualcosa non torna al giudice: sulla scena del delitto non è stato ritrovato il pugnale. Tajomaru ne sa qualcosa?
Qualcosa non torna al giudice: sulla scena del delitto non è stato ritrovato il pugnale. Tajomaru ne sa qualcosa?
No. Solo in quel momento se ne ricorda. La spada l'ha prontamente venduta, ricavandone una bella cifra.
Del pugnale se ne era completamente dimenticato, lasciandolo sul posto. Eppure doveva essere anche quello un oggetto di grande valore.
Tajomaru è molto divertito di questa sua inspiegabile dimenticanza, ma non può risolvere il mistero della sparizione.
 Continua a piovere ininterrottamente sulle rovine della porta Rashomon. Il racconto dei due testimoni sembra ormai terminato.
Continua a piovere ininterrottamente sulle rovine della porta Rashomon. Il racconto dei due testimoni sembra ormai terminato.
Il loro occasionale compagno è già pronto a trarre una cinica morale dalla vicenda, ma viene avvisato dagli altri due di attendere.
La storia non è ancora conclusa.
Anzi: non solo è appena agli inizi, ma la parte più complicata deve ancora arrivare
 L'inquadratura successiva ancora una volta è ripresa da dove idealmente si trova il giudice incaricato di indagare ed emettere la sentenza. Non cambierà mai nel corso del film, se non per mostrare occasionali primi piani dei protagonisti, nei momenti topici.
L'inquadratura successiva ancora una volta è ripresa da dove idealmente si trova il giudice incaricato di indagare ed emettere la sentenza. Non cambierà mai nel corso del film, se non per mostrare occasionali primi piani dei protagonisti, nei momenti topici.
Masako è stata rintracciata e condotta in tribunale.
Sappiamo dal racconto di Akutagawa che è stata ritrovata dentro al convento dove si era rifugiata.
E' in evidente stato di prostrazione, ma accetta di fare la sua testimonianza e di rispondere alle domande.
La prima parte del suo racconto, scandito ancora dal tema del Bolero, coincide con quello di Tajomaru, ma la donna comprensibilmente sorvola su ogni particolare. Comunque sia veramente andata, non può essere facile per lei ritornare su quell'episodio.
 Dopo avere compiuto tutto quello che aveva in mente, il bandito abbandona le sue vittime senza nemmeno più degnarle di uno sguardo.
Dopo avere compiuto tutto quello che aveva in mente, il bandito abbandona le sue vittime senza nemmeno più degnarle di uno sguardo.
La donna giace in lagrime ai bordi del sentiero. L'uomo, ancora legato, è apparentemente impassibile.
Ma a testa bassa.
 La donna gli si avvicina. Cerca conforto.
La donna gli si avvicina. Cerca conforto.
Ma trova come risposta solo un muto sguardo, pieno di rancore e di disprezzo.
Il samurai considera sua moglie responsabile o perlomeno partecipe di quanto accaduto.
La condanna senza appello.
 A lungo Masako ne chiede la ragione, a lungo implora.
A lungo Masako ne chiede la ragione, a lungo implora.
 Poi, a lungo, minaccia.
Poi, a lungo, minaccia.
Ha raccolto da terra il suo pugnale con l'intenzione di liberare il marito dalla fune.
Ma si ferma, dapprima esita, poi intima all'uomo di non guardarla più in quel modo.
 Lui, impassibile, non muta minimamente espressione, mentre lei sempre più lentamente si avvicina.
Lui, impassibile, non muta minimamente espressione, mentre lei sempre più lentamente si avvicina.
Con il pugnale nella mano.
Da quel punto Masako dichiara di non ricordare più nulla.
 E' svenuta, e quando è rinvenuta si deve essere allontanata, fino a ritrovarsi senza sapere come sulle rive di un piccolo lago tranquillo.
E' svenuta, e quando è rinvenuta si deve essere allontanata, fino a ritrovarsi senza sapere come sulle rive di un piccolo lago tranquillo.
E' rimasta a lungo a contemplare le acque, irresistibilmente attratta. Sembravano l'unica soluzione possibile alla sua tragedia.
Ma non ha trovato il coraggio di porre fine ai suoi giorni.
Ed ora è lei a fare domande, a chiedere: cosa deve fare, cosa può fare, una donna in situazioni del genere?
E' solo un oggetto di desiderio e di preda, senza che alcuno mostri la minima pietà, la minima comprensione, senza che nessuno la difenda.
 Piove ancora incessantemente alla porta di Rashomon. I tre uomini non potrebbero in ogni caso uscirne, ma non ci pensano affatto.
Piove ancora incessantemente alla porta di Rashomon. I tre uomini non potrebbero in ogni caso uscirne, ma non ci pensano affatto.
Sono legati al racconto come se delle catene li tenessero saldamente.
Lo sconosciuto viandante (molti dei personaggi di Kurosawa non hanno nome) ha già fatto ricorso ad una delle sue sbrigative e conformistiche morali: non si può credere alle donne, sono capaci di ingannare perfino sé stesse, e di far credere agli uomini qualunque cosa.
Il boscaiolo, in qualche modo conferma. La verità non è quella. Ma si rifiuta di dire nulla di più.
 Il monaco acconsente, pensieroso: oltretutto la ricostruzione della donna non è compatibile con quella del morto.
Il monaco acconsente, pensieroso: oltretutto la ricostruzione della donna non è compatibile con quella del morto.
Lo sconosciuto trasecola: la versione del morto? Come è possibile che il morto abbia parlato?
 Il giudice ha convocato una veggente (Noriko Honma), per ascoltare attraverso di lei il racconto della vittima.
Il giudice ha convocato una veggente (Noriko Honma), per ascoltare attraverso di lei il racconto della vittima.
Il cortile giaceva fino ad allora in una calma morbosa, senza che nulla si muovesse oltre ai gesti del personaggio chiamato di volta in volta davanti allo scranno del tribunale.
Sia il boscaiolo che il monaco sullo sfondo rimangono inorriditi ma affascinati ad ascoltare, senza muoversi mai dalla loro posizione defilata.
 Al termine di lunghi preparativi, finalizzati a provocare lo stato di trance, lo spirito del defunto si impossessa del corpo della veggente.
Al termine di lunghi preparativi, finalizzati a provocare lo stato di trance, lo spirito del defunto si impossessa del corpo della veggente.
Inizia a parlare.
Con una agghiacciante voce che proviene dall'oltretomba.
 Anche la versione di Takehiro inizialmente concorda con le altre.
Anche la versione di Takehiro inizialmente concorda con le altre.
E' solo quando il racconto sta per terminare che emergono le differenze: enormi. Incompatibili le lune con le altre.
Allo stesso tempo autolesionistiche ed orgogliose.
Masako dopo la violenza chiede a Tajomaru di portarla via con se.
Ma prima... Prima deve fare qualcosa.
 Il samurai li vede parlare a lungo.
Il samurai li vede parlare a lungo.
Non può ascoltare quello che si dicono, ma già è allarmato, inquieto
 Ancora una volta, l'ultima nella sua vita, osserva attentamente il volto di quella che fu la sua moglie.
Ancora una volta, l'ultima nella sua vita, osserva attentamente il volto di quella che fu la sua moglie.
E la sua ombra ricorda di non averla mai trovata così bella come in quel momento.
 Nel ripetere incessantemente la sua richiesta la donna si avvinghia a Tajomaru.
Nel ripetere incessantemente la sua richiesta la donna si avvinghia a Tajomaru.
Si rifugia letterlamente dietro di lui, se ne fa schermo.
Come, nel racconto di Tajomaru, gli si era improvvisamente avvinghiata durante la violenza divenuta amplesso, nel momento in cui maggiormente desiderava ucciderlo.
 Ora, dice a Tajomaru, deve uccidere Takehiro.
Ora, dice a Tajomaru, deve uccidere Takehiro.
Solo così lei potrà essere libera.
Libera da un rapporto che già da tempo le pesava, libera dall'infamia di avere abbandonato il legittimo consorte per seguire un brigante.
Prima che lei possa seguire Tajomaru, l'unico testimone di quanto è successo deve morire.
 La reazione del bandito è per lei assolutamente imprevedibile.
La reazione del bandito è per lei assolutamente imprevedibile.
Se la scrolla di dosso, la getta per terra e le pone un piede sopra, come ad un preda abbattuta.
E senza più nemmeno rivolgerle la parola chiede direttamente al samurai cosa farne, se "devono" ucciderla immediatamente o lasciarla vivere.
Solamente per queste sue parole, commenta lo spirito di Takehiro con la sua voce cavernosa, in cui appare tuttavia un rimpianto di umanità, posso perdonare al brigante.
 Mentre i due discutevano la donna è fuggita a perdifiato. Tajomaru l'ha a lungo inseguita, ma invano: è scomparsa nella foresta.
Mentre i due discutevano la donna è fuggita a perdifiato. Tajomaru l'ha a lungo inseguita, ma invano: è scomparsa nella foresta.
Takehiro è rimasto ancora a lungo immobilizzato, legato alla fune e a i suoi pensieri. Tajomaru quando torna a mani vuote lo fissa a lungo.
I prolungati primi piani, apparentemente simili, mostrano sentimenti opposti dei personaggi, soprattutto nelle differenti ricostruzioni ma perfino nei diferenti momenti di ognuna di esse: rabbia, orgoglio, tristezza...
Tajomaru taglia con la spada i legami del suo prigioniero, e si allontana.
 Restato finalmente solo, Takehiro rimane per lunghissimo tempo immobile, senza nemmeno muoversi dalla posizione in cui l'aveva immobilizzato il brigante.
Restato finalmente solo, Takehiro rimane per lunghissimo tempo immobile, senza nemmeno muoversi dalla posizione in cui l'aveva immobilizzato il brigante.
Sente qualcuno che piange, e solo lentamente, incredulo, capisce che quel pianto è il suo.
Ora Takehiro ritorna in piedi. Alza gli occhi al cielo.
Vede per l'ultima volta il cielo, e la luce del sole.
 Ha raccolto il pugnale. Con quello pone fine ai suoi giorni.
Ha raccolto il pugnale. Con quello pone fine ai suoi giorni.
 E' terminato il racconto.
E' terminato il racconto.
La veggente, spossata, si accascia al suolo, come poco prima si era accasciata al termine della sua sofferta deposizione anche Masako.
Ma si rialza: lo spirito di Takehiro ha ancora qualcosa da aggiungere.
Nell'agonia, mentre scendeva un grande silenzio e le ombre si allungavano, qualcuno, non si sa chi, si è avvicinato con passo leggero e ha sfilato il pugnale dal suo petto sanguinante, per poi allontanarsi con quello.
 Siamo ancora alla porta di Rashomon. Ed ancora piove: sembra non debba smettere mai.
Siamo ancora alla porta di Rashomon. Ed ancora piove: sembra non debba smettere mai.
Il boscaiolo è inquieto: ha chiaramente qualcosa da dire, ma non trova il coraggio.
Infine, non riesce più a trattenersi: nemmeno il racconto della vittima può essere creduto: il cadavere aveva una ferita da spada, non da pugnale.
 Lo sconosciuto gli si avvicina, insinuante, insistente. Ha intuito che c'è ancora qualcosa, che il boscaiolo nasconde un segreto.
Lo sconosciuto gli si avvicina, insinuante, insistente. Ha intuito che c'è ancora qualcosa, che il boscaiolo nasconde un segreto.
Ebbene: il boscaiolo confessa.
Ha assistito, non visto, a tutta la sequenza dei fatti. Ha taciuto perché non voleva essere coinvolto, sia con la polizia che con il giudice.
Ma ora acconsente a rivelare ai due occasionali compagni quello che ha visto. E' un segreto troppo pesante per continuare a tenerlo dentro.
 Attratto da un pianto di donna che sentiva provenire da poco vicino, il boscaiolo si era avvicinato con cautela, mantenendosi non visto al riparo della boscaglia, e aveva potuto osservare tutto quanto.
Attratto da un pianto di donna che sentiva provenire da poco vicino, il boscaiolo si era avvicinato con cautela, mantenendosi non visto al riparo della boscaglia, e aveva potuto osservare tutto quanto.
Tajomaru, in ginocchio, stava chiedendo perdono alla donna, che singhiozzava sdraiata al suolo.
La stava rassicurando che le sue intenzioni erano serie, le chiedeva di diventare la sua sposa.
Sullo sfondo, l'orgoglioso samurai legato e ridotto all'impotenza.
Tajomaru è disposto a qualunque cosa pur di averla: rinunciare al brigantaggio, ha ormai messo da parte abbastanza per garantire il benessere a sé e a chi gli è vicino, perfino lavorare se necessario.
Ma ogni sua insistenza è vana: la donna continua a piangere ininterrottamente, senza alcun cenno di risposta e nemmeno di reazione.
 Infine Masako ha un sussulto di orgoglio, si drizza sul busto e finalmente risponde: cosa mai può contare lei, misera donna sballottata qua e là dal volere e dalla forza bruta degli uomini?
Infine Masako ha un sussulto di orgoglio, si drizza sul busto e finalmente risponde: cosa mai può contare lei, misera donna sballottata qua e là dal volere e dalla forza bruta degli uomini?
Si getta addosso al marito, e prima che Tajomaru se ne renda conto, col pugnale lo libera dalle corde.
 E' evidente che il suo volere è che siano loro, gli uomini, a decidere.
E' evidente che il suo volere è che siano loro, gli uomini, a decidere.
Ma Takehiro non è d'accordo: non intende rischiare la vita per una donna che per lui non rappresenta più niente.
Una donna disonorata, che farebbe meglio ad uccidersi! E' peggio pedere un cavallo che una donna come lei.
Trascorrono lunghi, interminabili attimi prima che qualcuno parli di nuovo.
Tajomaru volge le spalle, sembra volersene andare, e Masako gli grida di aspettare.
Tajomaru la scaccia. Non la vuole più nessuno, come sarcasticamente fa osservare Takehiro.
 Una osservazione apparentemente benevola di Tajomaru, che invita l'altro a non maltrattare la donna, le donne sono come dei bambini, ha il potere di far ribellare Masako.
Una osservazione apparentemente benevola di Tajomaru, che invita l'altro a non maltrattare la donna, le donne sono come dei bambini, ha il potere di far ribellare Masako.
Il suo pianto isterico si tramuta in una risata altrettanto isterica, interminabile.
Sono loro i bambini: non sono dei veri uomini. Un marito che rifiuta di vendicare l'onore oltraggiato della moglie. Ed il famoso bandito Tajomaru, terrore dei luoghi, è in realtà un imbelle incapace.
Avrebbe fatto qualunque cosa per un vero uomo, ma si accorge di avere a che fare con degli inetti.
Le parti si sono imprevedibilmente quanto improvvisamente rovesciate: è ora Masako a dominare la situazione. Afferra per la gola Tajomaru, lo strattona, gli sputa sul volto in segno di disprezzo.
 Mentre continuano alternandosi alle crisi di pianto le allucinate risate di Masako, i due uomini sguainano le spade e decidono d affrontarsi pur di sottrarsi a quella vergognosa situazione.
Mentre continuano alternandosi alle crisi di pianto le allucinate risate di Masako, i due uomini sguainano le spade e decidono d affrontarsi pur di sottrarsi a quella vergognosa situazione.
Il loro duello è una tragica parodia. Sono entrambi in preda al terrore della morte, solo il caso e non il merito od il valore può decidere il vincitore.
Cadutagli al suolo la spada, Tajomaru sembra in balia dell'avversario, e si dibatte come un animale selvaggio per sfuggire al colpo fatale, che non arriva: Takehiro non è più lucido né più coraggioso.
 Infine, la spada di Takehiro si pianta sul troncone di un albero, senza che lui riesca a recuperarla. E' ora il samurai ad essere in balia dell'avversario, che nel frattempo ha recuperato la sua arma.
Infine, la spada di Takehiro si pianta sul troncone di un albero, senza che lui riesca a recuperarla. E' ora il samurai ad essere in balia dell'avversario, che nel frattempo ha recuperato la sua arma.
E' incapace perfino di fuggire.
Continua a guardare ammaiato la lama che gli toglie la vita.
Riesce solo a chiedere invano di non essere ucciso: non vuole morire.
 A questo punto Tajomaru torna dalla donna, ma piuttosto si trascina perché è uscito annientato dalla animalesca contesa, e tenta di condurla con sé.
A questo punto Tajomaru torna dalla donna, ma piuttosto si trascina perché è uscito annientato dalla animalesca contesa, e tenta di condurla con sé.
Ma lei gli sfugge.
Tajomaru allora svelle dal tronco la spada di Takehiro, e tenta con quella di ucciderla: di uccidere quella stessa donna per cui pochi minuti prima si dichiarava disposto a tutto.
 La donna riesce a sfuggirgli, correndo a perdifiato fino a riuscire ad imboccare il sentiero, lungo il quale sparisce.
La donna riesce a sfuggirgli, correndo a perdifiato fino a riuscire ad imboccare il sentiero, lungo il quale sparisce.
 Anche Tajomaru, incerto sulle gambe, ancora in preda ad un terrore inspiegabile, abbandona il luogo del delitto.
Anche Tajomaru, incerto sulle gambe, ancora in preda ad un terrore inspiegabile, abbandona il luogo del delitto.
Il cadavere di Takehiro rimane abbandonato là dove la spada di Tajomaru gli ha tolto la vita.
 E' terminato anche il racconto del boscaiolo. Sembra che non ci sia, non ci possa essere, nullaltro da sapere.
E' terminato anche il racconto del boscaiolo. Sembra che non ci sia, non ci possa essere, nullaltro da sapere.
Ma ancora non riescono a liberarsi da quella storia. Il terzo uomo non crede che tutta la verità sia ancora uscita fuori. Il suo pessimismo nei confronti della natura umana non glielo consente.
Sappiamo da Akutagawa che il terzo uomo è un servo, reso amaro dagli eventi:
L'autore poco fa ha scritto «un servo aspettava che la pioggia cessasse», ma il servo non aveva un'idea precisa di cosa fare dopo che la pioggia fosse cessata. In una situazione normale certamente sarebbe tornato nella casa del padrone. Ma dal suo padrone era stato mandato via quattro o cinque giorni prima. In quell'epoca, dunque, la città di Kyoto era caduta molto in basso. Adesso questo servo, che aveva lavorato per lungo tempo presso il suo padrone, in verità era stato licenziato anche per colpa di questa decadenza generale.
Il monaco si rifiuta di adeguarsi a questa filosofia realistica quanto cinica: vuole continuare a credere negli esseri umani.
 La discussione continua tra il servo ed il boscaiolo. Il cinismo del primo lo porta a pensare sempre male, ed il più delle volte ad indovinare.
La discussione continua tra il servo ed il boscaiolo. Il cinismo del primo lo porta a pensare sempre male, ed il più delle volte ad indovinare.
Cosa ne è stato del prezioso pugnale di Masako? Il boscaiolo non può che confessare: sì, è stato lui a rubarlo.
Nemmeno lui ha detto la verità fino in fondo. Ogni essere umano quando vede messo in gioco il suo tornaconto è pronto ad ingannare anche se stesso.
 L'alterco si interrompe quasi subito, un fatto nuovo attira l'attenzione dei tre.
L'alterco si interrompe quasi subito, un fatto nuovo attira l'attenzione dei tre.
All'interno dell'immenso androne di Rashomon si ode distintamente il pianto di un bambino.
Iniziano le ricerche, finché in una stanza scoprono un bimbo abbandonato dentro una culla, corredata di lussuosi panni.
 Il servo è il primo a trovarlo e ad accorrere. Ma non è per portare soccorso.
Il servo è il primo a trovarlo e ad accorrere. Ma non è per portare soccorso.
E' solo per impossessarsi dei panni e fuggire col suo bottino.
I suoi occasionali compagni sono inorriditi, ma lui ribatte colpo su colpo: chi ha il diritto di rimproverarlo? Chi è esente da ogni colpa?
Forse i genitori di quel bambino, che hanno pensato solamente al loro piacere e poi l'hanno abbandonato?
 Raccolto quello che voleva, affronta la pioggia battente per allontanarsi.
Raccolto quello che voleva, affronta la pioggia battente per allontanarsi.
Il cielo stesso sembra voler infierire su lui e sugli uomini.
 Partito il servo, sembra che gli elementi riescano finalmente a placarsi: la pioggia cessa.
Partito il servo, sembra che gli elementi riescano finalmente a placarsi: la pioggia cessa.
Il monaco stringe ancora spasmodicamente tra le braccia il bimbo in fasce.
 Il boscaiolo accenna a prenderglielo: il monaco arretra, inorridito.
Il boscaiolo accenna a prenderglielo: il monaco arretra, inorridito.
Quale altra nefandezza gli toccherà di vedere?
 No: il boscaiolo bonariamente gli dice che ha già sei figli. Non sarà un grande problema in più allevarne un settimo.
No: il boscaiolo bonariamente gli dice che ha già sei figli. Non sarà un grande problema in più allevarne un settimo.
Vuole adottare il trovatello, e già lo prende amorevolmente tra le braccia.
Il monaco lo ringrazia: per merito suo è riuscito a non perdere la sua fiducia nel genere umano.
Guarda allontanarsi il boscaiolo, che forse già dimentico, con la semplicità delle persone umili, della cattiveria umana che ha visto in prima persona, sta pensando solo a come dare amore al nuovo piccolo arrivato.
 Alle spalle del monaco le rovine della porta Rashomon si stagliano contro il cielo, dal lato ove sta tornando il sereno, e sembrano indicare un cammino.
Alle spalle del monaco le rovine della porta Rashomon si stagliano contro il cielo, dal lato ove sta tornando il sereno, e sembrano indicare un cammino.
Spesso le opere di Kurosawa terminano con la visione di una finestra, di una porta, di un nuovo cammino.
Talvolta verso il male, e dobbiamo accettare anche queste opere, forse addirittura più importanti delle altre seppure più sofferte, talvolta verso il bene.
 Akira Kurosawa: Tora no o fumu otokotachi
Akira Kurosawa: Tora no o fumu otokotachi
1945
Denjiro Okochi, Susumu Fujita, Keniichi Enomoto
Girato nel 1945 con mezzi di fortuna, dura infatti meno di un’ora a causa della difficoltà di reperire pellicola, il film è tuttavia estremamente denso e “pieno di ki”. Lo disse il maestro Hideo Kobayashi dopo averlo visto per la prima volta nel 1981 all'Istituto di Cultura Giapponese in Roma: all’epoca ne esisteva in occidente una sola copia, a Parigi, ma anche in Giappone l'opera aveva avuto scarsa diffusione. Narra la fuga attraverso le montagne del principe Miyamoto no Yoshitsune accompagnato da sei fedeli samurai, per sfuggire alla persecuzione del potente shogun Minamoto no Yoritomo: suo fratello, cui fa ombra con la sua fama di invincibile guerriero.
Akira Kurosawa: Sugata Sanshiro, Parte II (Zoku Sugata Sanshiro)
1945
Denjiro Okochi, Susumu Fujita, Ryunosuke Tsukigata, Kokuden Kodo, Yukiko Todoroki
 Sugata Sanshiro fu un successo, così lo studio mi chiese di prepararne un seguito. Questo è uno dei punti negativi della mentalità commerciale: sembra che le sezioni intrattenimento delle case cinematografiche giapponesi non abbiano mai ascoltato il proverbio del pesce nel ruscello, sotto il salice piangente: il fatto di averlo preso una volta non significa poterlo prendere sempre. Questa gente rifa sempre i film che hanno avuto successo in passato.
Sugata Sanshiro fu un successo, così lo studio mi chiese di prepararne un seguito. Questo è uno dei punti negativi della mentalità commerciale: sembra che le sezioni intrattenimento delle case cinematografiche giapponesi non abbiano mai ascoltato il proverbio del pesce nel ruscello, sotto il salice piangente: il fatto di averlo preso una volta non significa poterlo prendere sempre. Questa gente rifa sempre i film che hanno avuto successo in passato.
Loro non tentanto di sognare nuovi sogni; vogliono solamente ripetere quelli vecchi.
Per quanto sia stato provato che un rifacimento non supera mai l'originale, insistono in questa follia. La definirei folia di primo grado. Un regista che dirige un rifacimento lo fa con tale deferenza verso il lavoro originale che è come se cucinasse qualcosa di strano con gli avanzi, ed il pubblico che deve mangiarsi questo intruglio si trova in una posizione poco invidiabile.
...
Sugata Sanshiro, Parte II, non fu un film molto buono. Tra le critiche ve ne fu una che diceva "Kurosawa sembra essere in qualche modo pieno di se". Al contrario, sento di essere stato incapace di metterci tutta la mia forza.
Akira Kurosawa, Something like an autobiography, p. 135 e 137
Citate queste parole di Akira Kurosawa, dobbiamo ricordare però che alla fine si lasciò convincere ed il seguito di Sugata Sanshiro ci fu, comprenderne le ragioni ed infine passare alla visione per farcene una nostra propria idea.
Kurosawa sostiene di essere rimasto particolarmente intrigato dalla possibilità di esplorare i sentimenti di Gennosuke Higaki, maturato dalla sconfitta subita contro Sanshiro ma costretto a riviverla una seconda volta attraverso l'impetuoso fatello Tesshin, più giovane e forse bisognoso di rivivere in prima persona le stesse esperienze, anche quando avvertito da chi già ci è passato che rimarranno inutili e negative.
 Sanshiro verrà quindi sfidato ad un nuovo duello ad oltranza, per vendicare la sconfitta precedente. Fu questo interessante motivo psicologico che in definitiva spinse Kurosawa ad accettare la richiesta di dare un seguito alla sua fortunata opera di esordio.
Sanshiro verrà quindi sfidato ad un nuovo duello ad oltranza, per vendicare la sconfitta precedente. Fu questo interessante motivo psicologico che in definitiva spinse Kurosawa ad accettare la richiesta di dare un seguito alla sua fortunata opera di esordio.
Il duello finale si svolge ancora una volta in una impervia località di montagna, questa volta non sferzata dal vento ma sotto una coltre di neve, e Sanshiro deve ora affrontare l'arte del karate, con una piccola forzatura storica: il karate iniziò infatti a diffondersi in Giappone solamente a partire dal 1922 quando il maestro Gichin Funakoshi vi si trasferì dalla nativa Okinawa per insegnare seguendo il suo metodo, che venne chiamato Shotokan. La vicenda di Sugata Sanshiro II è ambientata nel 1887, questo confronto tra la scuola Shudokan (Kodokan nella realtà) e una scuola di karate pre-Shotokan è di conseguenza perlomeno improbabile.
Il leitmotif sul quale Kurosawa decise di impostare la nuova opera fu il brusco cambiamento nella società giapponese imposto dalla forzata convivenza con le forze di occupazione straniere.
 Agli albori dell'epoca Meiji infatti, in cui è ambientata la vicenda di Sugata Sanshiro, ed esattamente nel 1853, il secolare isolamento del Giappone era stato forzato dall'arrivo di navi militari statunitensi, al comando dell'ammiraglio Perry, che imposero praticamente con la forza l'apertura delle frontiere. Negli anni successivi le maggiori potenze occidentali stabilirono numerose stazioni commerciali sul suolo giapponese. In passato una sola stazione era stata consentita, quella concordata con l'Olanda e basata sull'isola artificiale di Deshima in Osaka, con diritti di scambio molto limitati: in pratica una sola nave all'anno.
Agli albori dell'epoca Meiji infatti, in cui è ambientata la vicenda di Sugata Sanshiro, ed esattamente nel 1853, il secolare isolamento del Giappone era stato forzato dall'arrivo di navi militari statunitensi, al comando dell'ammiraglio Perry, che imposero praticamente con la forza l'apertura delle frontiere. Negli anni successivi le maggiori potenze occidentali stabilirono numerose stazioni commerciali sul suolo giapponese. In passato una sola stazione era stata consentita, quella concordata con l'Olanda e basata sull'isola artificiale di Deshima in Osaka, con diritti di scambio molto limitati: in pratica una sola nave all'anno.
Inziiò quindi in epoca Meiji una forzata convivenza con gli stranieri e con i loro usi e costumi, essendo il Giappone dilaniato da un lungo periodo di guerre civili che vide dapprima le forze progressiste legate al governo dello shogun contro quelle tradizionaliste che appoggiavano l'imperatore (Meiji appunto) e quindi diviso ed impotente. In seguito lo stesso governo imperiale vennealle prese con i tradizionalisti intransigenti che a vittoria avvenuta si ribellarono anche contro il regime da loro sostenuto, reo di avere concesso troppo alle pretese degli stranieri violando il tacito patto con i suoi seguaci. In questa situazione confusa ebbero buon gioco le potenze straniere: munirono i loro insediamenti di forze militari e ne fecero delle enclavi in cui le leggi e le usanze giapponesi venivano stravolte. Inevitabilmente il 'contagio' si estendeva anche alle zone circostanti, poiché gli stranieri tendevano ad esportarvi le loro regole assumendo un atteggiamento di colonialistica sufficienza verso i 'nativi' e le loro 'primitive' usanze.
 Nelle sequenze iniziali vediamo infatti arrivare un marinaio occidentale sopra un jinrikisha - leggero calessino a trazione umana introdotto a partire dal 1870 e da noi conosciuto come ricsiò e su cui avevamo già visto in Sugata Sanshiro il maestro Shogoro Yano.
Nelle sequenze iniziali vediamo infatti arrivare un marinaio occidentale sopra un jinrikisha - leggero calessino a trazione umana introdotto a partire dal 1870 e da noi conosciuto come ricsiò e su cui avevamo già visto in Sugata Sanshiro il maestro Shogoro Yano.
Furente perché non riesce a farsi comprendere dal jinriki ha un arrivo traumatico e burlesco, agitandosi al punto da far ribaltare il calessino sotto il suo peso essendo il conducente di taglia molto più leggera, come la maggior parte dei giapponesi a confronto con l'occidentale medio.
Una trasparente metafora della seconda occupazione militare, che seguì la seconda guerra mondiale, e su cui Kurosawa tornerà regolarmente ad infierire nel corso del film. La vicenda inizia a Yokohama nel 1887, ossia circa 2 anni dopo le vicende narrate nel primo Sugata Sanshiro.
 Va da se che i richiami alla 'prima puntata' sono molti e molto evidenti, ma Kurosawa pur ancora inesperto - era solamente al suo terzo film e aveva all'epoca appena 35 anni - già sapeva il fatto suo.
Va da se che i richiami alla 'prima puntata' sono molti e molto evidenti, ma Kurosawa pur ancora inesperto - era solamente al suo terzo film e aveva all'epoca appena 35 anni - già sapeva il fatto suo.
Le citazioni non sono solamente sciocche ripetizioni di situazioni già viste, ma guidano lo spettatore a comprendere che la storia, per quanto sia il seguito di quella precedente (nei titoli di testa si afferma che anche questa seconda parte è ricavata dal romanzo Sugata Sanshiro di Tsuneo Tomita), non è la stessa.
Il marinaio, irritato, è ben deciso a dare una sonora lezione all'innocente jinriki, e sembrerebbe poterlo fare senza difficoltà in quanto è d statura gigantesca e pronto a menare le mani.
Però la sua mano viene improvvisamente arrestata da un'altra, che possiede una energia superiore alla sua: è la mano di Sugata Sanshiro.
 Non è più il Sanshiro irruento ed impaziente che conoscevamo.
Non è più il Sanshiro irruento ed impaziente che conoscevamo.
Accetta di liquidare la questione per le spicce, il marinaio non aspetta altro e non cessa di invitarlo a battersi, ma sembra voler prendere tempo, tergiversare.
In realtà si guarda attorno e fa cenno di aspettare perché sta semplicemente cercando il luogo adatto per la 'discussione' col marinaio. Infine lo trova.
Se non è lo stesso luogo dove anni prima incontrò per la prima volta il maestro Yano, poco ci manca. E' sul bordo di un corso d'acqua dove potrà tranquillamente proiettare l'avversario con la sicurezza di non fargli troppo male, e il regista farà così ricordare allo spettatore la scena con cui Sanshiro iniziò la sua avventura nel mondo del judo.
 Sempre seguito dal furente marinaio Sanshiro arriva sul bordo del molo, e attende che il suo avversario la raggiunga. Questi mostra nei movimenti di conoscere almeno i rudimenti del pugilato, ma le sue mosse sono lente e prevedibili. Sanshiro non ha alcuna difficoltà ad afferrarlo non appena si porta alla corta distanza, e proiettarlo in acqua con quello che sembra essere un classico kata guruma.
Sempre seguito dal furente marinaio Sanshiro arriva sul bordo del molo, e attende che il suo avversario la raggiunga. Questi mostra nei movimenti di conoscere almeno i rudimenti del pugilato, ma le sue mosse sono lente e prevedibili. Sanshiro non ha alcuna difficoltà ad afferrarlo non appena si porta alla corta distanza, e proiettarlo in acqua con quello che sembra essere un classico kata guruma.
Dai titoli di testa leggiamo il nome del consigliere per il judo Kinnosuke Sato. Fu membro di diversi comitati negli anni 1920 e 30 e lo troviamo citato nelle memorie del maestro Kenshiro Abe: fu capitano della squadra dell'est in un torneo del 1936. Aveva all'epoca 39 anni ed il grado di 7. dan. Fu dopo la guerra protagonista di una famosa dimostrazione di judo organizzata dal Kodokan, probabilmente la prima ad essere autorizzata dopo il periodo bellico.
Viene riportato come consigliere per il karate Yasusuke (Yasuhiro) Konishi che si era unito ai corsi tenuti da Gichin Funakoshi nel 1924 alla Università di Keio ed è noto sopratutto per essere stato tra i primi ad adottare un metodo di allenamento che comprendesse anche il kumite (combattimento), oltre ai tradizionali kata (forme a solo).
 Il jinriki si avvicina timidamente, pesto e malconcio, per ringraziare il provvidenziale soccorritore.
Il jinriki si avvicina timidamente, pesto e malconcio, per ringraziare il provvidenziale soccorritore.
Il ragazzo rimane a bocca aperta sentendone il nome: Sugata. Sugata Sanshiro?!?....
Kurosawa ci informa così che il protagonista di questo seguito è ormai divenuto una persona ben nota, e sicuramente ben temuta.
Tutti ricordano della sua vittoria al torneo indetto dalla polizia, e tutti sanno che la sua tecnica favorita è lo yama arashi (tempesta sulla montagna) che gli diede la vittoria nel combattimento col maestro Murai (l'epilogo del primo film, Sanshiro Sugata)..
Essere riconosciuto ed ammirato non sembra destare grande piacere in Sanshiro.
Immediatamente prende congedo e si allontana, pensieroso.
 Ne apprenderemo le ragioni subito dopo, in una conversazione a Tokyo tra Sayo, la ragazza che sembrava a lui destinata, ed il saggio prete Osho.
Ne apprenderemo le ragioni subito dopo, in una conversazione a Tokyo tra Sayo, la ragazza che sembrava a lui destinata, ed il saggio prete Osho.
Murai, il padre di Sayo, non si è mai riavuto dalle conseguenze di quel combattimento, e poco tempo dopo è morto.
Sanshiro è da allora scomparso, senza lasciare alcuna notizia di se.
Il vecchio sapiente trova che la personalità di sanshiro per quanto complessa sia apprezzabile: la sua sincerità è assoluta pur confinando con la naïveté: non è capace di andare contro la sua stessa volontà.
Ed è per questo che lui lo ama sopra ogni altro.
 All'udire queste parole Sayo sorride.
All'udire queste parole Sayo sorride.
 In quello stesso momento, almeno questo lascia intendere Kurosawa, Sanshiro è invece pensieroso.
In quello stesso momento, almeno questo lascia intendere Kurosawa, Sanshiro è invece pensieroso.
Il ragazzo lo ha seguito, e vuole diventare suo discepolo, per quanto stupito dalle parole di Sanshiro, che ricorda come la via del judo sia quella della flessibilità e dell'adattabilità, contando ben poco la forza.
Certamente: anche per campioni forti ed affermati come lui.
E anche la vittoria a volte può essere velata di tristezza. In ogni modo il judo non è un'arte che ammetta le mezze misure, e lui essendo un semplice discepolo non è in grado di insegnarla.
 La conversazione viene interrotta dall'arrivo di un visitatore che manda in avanscoperta, come usano i giapponesi, il suo biglietto da visita: Kozo Nunobiki, traduttore preso il Consolato degli Stati Uniti.
La conversazione viene interrotta dall'arrivo di un visitatore che manda in avanscoperta, come usano i giapponesi, il suo biglietto da visita: Kozo Nunobiki, traduttore preso il Consolato degli Stati Uniti.
E' un buffo ometto, per quanto vestito inappuntabilmente all'occidentale, e porta a Sanshiro alcune informazioni. Si trova in in Giappone per una tournée uno dei più famosi e rinomati pugli americani: William Lister.
Al pugile è arrivata la voce dell'episodio del jinrikisha e si rammarica che il marinaio non fosse ben addestrato nell'arte del pugilato.
Sanshiro non comprende dove voglia arrivare l'ometto, che deve fargli esplicitamente la sua proposta: un confronto tra il judo giapponese, rappresentato da Sanshiro, e il pugilato all'occidentale di cui Lister è campione indiscusso.
 Nunobiki pensa che l'evento porterebbe senzaltro ad un incremento dei sentimenti di amicizia tra il Giappone e gli Stati Uniti.
Nunobiki pensa che l'evento porterebbe senzaltro ad un incremento dei sentimenti di amicizia tra il Giappone e gli Stati Uniti.
Sanshiro però non ha alcuna idea di cosa sia il pugilato e rimane molto sulle sue.
Nonobiki non prende l'occasione per dimostrargli ipso facto, a spese della malcapitata inserviente, che cosa sia il pugilato. Un'arte di combattimento in cui si adoperano i pugni, fasciati da guantoni di cuoio, in cui vengono portati colpi terribili e i contendenti sanguinano copiosamente.
L'impressione che ne riporta Sanshiro non è positiva: uno spettacolo insomma: roba quindi che non fa per lui.
Le insistenze dell'altro non servono a smuoverlo dal suo proposito, il massimo che gli si riesce a strappare è di accettare l'invito alla dimostrazione che si terrà presso il Consolato.
 Kurosawa indugia impietosamente sugli aspetti più deteriori della nobile arte.
Kurosawa indugia impietosamente sugli aspetti più deteriori della nobile arte.
La brutalità del combattimento.
Il volto devastato dai colpi del pugile sconfitto ed atterrato.
Quello deformato dallo sforzo, ma anche contagiato dalla brutalità dei gesti che compie abitudinariamente, del vincitore.
 Ma anche e soprattutto, visto che Sugata si trova in mezzo al pubblico e vi assiste attonito, la brutale esternazione di sentimenti assolutamente non nobili da parte del pubblico.
Ma anche e soprattutto, visto che Sugata si trova in mezzo al pubblico e vi assiste attonito, la brutale esternazione di sentimenti assolutamente non nobili da parte del pubblico.
Le loro espressioni non hanno nulla di edificante, e la loro plateale soddisfazione nel vedere un uomo giacere a terra privo di sensi, abbattuto dai colpi di un altro uomo, sconcerta visibilmente Sanshiro Sugata.
Sta già per andarsene senza attendere il combattimento principale, e Nunobiki cerca di trattenerlo.
Sugata non vorrebbe sentire ragioni: lo spettacolo lo disgusta, si meraviglia anzi che venga offerto pubblicamente e impunemente ai cittadini americani, e domanda di porvi fine.
 Rimarrà, suo malgrado.
Rimarrà, suo malgrado.
Nel combattimento successivo vede infatti che i contendenti sono un occidentale di imponente corporatura sul cui accappatoio campeggia la scritta KILLER, William Lister, e un giapponese che indossa un logoro keikogi da allenamento.
 Si presenta quando Sanshiro gli rivolge la parola: è Kahei Sekine, adepto della scuola Isshin ryu.
Si presenta quando Sanshiro gli rivolge la parola: è Kahei Sekine, adepto della scuola Isshin ryu.
Invano Sanshiro lo prega di rinunciare al combattimento, il suo interlocutore non è in grado di comprenderne le ragioni.
Pensa infatti che Sanshiro sia preoccupato per una sua eventuale sconfitta e lo rassicura: non ha intenzione di essere vinto.
Non è il risultato che conta: per Sanshiro cimentarsi contro quella che non è e non sarà mai una arte marziale è un disonnore per il ju jutsu, a prescindere dall'esito del combattimento.
Presentatosi a sua volta, Sanshiro riceve una ulteriore spiegazione che lo getta in crisi: la vera ragione per cui Sekine accetta di battersi, è la mera sopravvivenza.
Il ju jutsu è stato sorpassato dal judo, anzi lui stesso è stato sorpassato da Sanshiro Sugata in persona. E gli adepti delle scuole vinte, come lui, non hanno più modo di guadagnarsi la vita.
 Sanshiro si allontana pensieroso, risalendo con infinita lentezza la scala che sale verso l'uscita, immerso nei suoi pensieri.
Sanshiro si allontana pensieroso, risalendo con infinita lentezza la scala che sale verso l'uscita, immerso nei suoi pensieri.
E' arrivato alla porta, ne sta aprendo i battenti per uscire.
In quel momento ode il suono della campana che annuncia l'inizio del combattimento.
 Sanshiro è tornato allo Shudokan.
Sanshiro è tornato allo Shudokan.
In realtà il dojo di Jigoro Kano si chiamava Kodokan, sala (o edificio) per la pratica della via.
Il Kodokan esiste tuttora in Tokyo ma è diventato un grande complesso con una dojô di circa 1000 tatami. Il primo Kodokan era situato presso il tempio di Eisho-ji e contava solamente 12 tatami.
 ll discepolo è ancora una volta di fronte al maestro: Shagoro Yano (Denjiro Okochi).
ll discepolo è ancora una volta di fronte al maestro: Shagoro Yano (Denjiro Okochi).
Un nome di fantasia che non tenta nemmeno di celare il personaggio storico: Jigoro Kano, fondatore del judo e grande innovatore, che trascinò col suo esempio le antiche scuole ancestrali e diede origine alle discipline marziali moderne.
Sanshiro Sugata è alle prese con una crisi di coscienza che sembra irreversibile. Ha accettato di essere detestato non solo dagli avversari ma anche dai loro discepoli, amici e parenti, per l'ideale dell'arte marziale.
Tuttavia le sue vittorie, se hanno accresciuto la fama del judo, hanno avuto effetti negativi sulle persone e le scuole sconfitte. Desidera quindi ritirarsi e dare le proprie dimissioni dal Kodokan.
Le fasi successive della vicenda tentano probabilmente di ipotizzare le ragioni del misterioso abbandono della pratica da parte di Shiro Saigo, il leggendario campione del Kodokan cui la saga di Sugata Sanshiro è ispirata.
 Le vicende successive di Saigo, che abbandonò il Kodokan nel 1890, all'età di 24 anni, e scomparve nel 1922, ci sono sconosciute. Non sembrano trovare fondamento le ipotesi che abbia praticato in seguito l'arte del daito-ryu apprendendola dal maestro Sokaku Takeda, che fu anche maestro di Morihei Ueshiba, fondatore dell'aikido. E' verosimile che Tsuneo Tomita nel romanzo che ha ispirato le due opere di Kurosawa abbia utilizzato informazioni di prima mano, ma il suo racconto si arresta prima.
Le vicende successive di Saigo, che abbandonò il Kodokan nel 1890, all'età di 24 anni, e scomparve nel 1922, ci sono sconosciute. Non sembrano trovare fondamento le ipotesi che abbia praticato in seguito l'arte del daito-ryu apprendendola dal maestro Sokaku Takeda, che fu anche maestro di Morihei Ueshiba, fondatore dell'aikido. E' verosimile che Tsuneo Tomita nel romanzo che ha ispirato le due opere di Kurosawa abbia utilizzato informazioni di prima mano, ma il suo racconto si arresta prima.
Yano chiede al suo discepolo se questi tormenti sono tutto quello che ha riportato con se dal suo viaggio, durato due anni. E' tutto.
Il maestro confessa di aver nutrito anche lui i dubbi che tormentano Sugata, e di avvertire tuttora gli stessi sentimenti, ma di averli fondamentalmente metabolizzati: solo il combattimento può portare ad una vera pace, il compromesso non porta a nulla. Per questo ha fede nel judo, e nel combattimento, dove non sono in gioco i prestigi personali di Sugata o dello stesso Yano, e nemmeno del judo. Ma l'onore dell'arte marziale del Giappone.
 Sugata rimane perplesso dopo il colloquio. Il nuovo Sanshiro ha ancora gli stessi problemi.
Sugata rimane perplesso dopo il colloquio. Il nuovo Sanshiro ha ancora gli stessi problemi.
L'arrivo di una inserviente che gli chiede ove intende pranzare gli riporta momentanea serenità.
La donna si meraviglia che il famoso Sanshiro, le cui gesta sono oramai celebrate anche dai cantastorie, non abbia l'aspetto formidabile e i vistosi baffi che lei immaginava.
Le descrizioni dell'aspetto di Sanshiro terrorizzavano puntualmente il suo nipotino...
 Incontra immediatamente dopo, mentre i discepoli si ammucchiano esterefatti a sbirciare dall'apertura dello shoji, la parete scorrevole, i suoi vecchi amici: gli altri guardiani dello Shudokan.
Incontra immediatamente dopo, mentre i discepoli si ammucchiano esterefatti a sbirciare dall'apertura dello shoji, la parete scorrevole, i suoi vecchi amici: gli altri guardiani dello Shudokan.
I cosidetti quattro guardiani del Kodokan erano Shiro Saigo, Yamashita Yoshiaki, Yokoyama Sakujiro, e Tsunejiro Tomita il cui figlio Tsuneo scrisse il romanzo che ispirò Kurosawa.
 L'incontro con Sayo (Yukiko Todoroki) è inevitabilmente più teso.
L'incontro con Sayo (Yukiko Todoroki) è inevitabilmente più teso.
Sanshiro è venuto a pregare sulla tomba del padre di lei, Hansuke Murai, che avevamo lasciato sconfitto da Sanshiro e costretto a letto dai postumi del combattimento.
Era però quasi sollevato di avere trovato un degno vincitore e benevolo nei confronti del nascente legame tra Sanshiro e Sayo.
Questo legame sembrava doversi consolidare nella scena conclusiva del primo film in cui partivano assieme per un viaggio in treno, invece è rimasto in bilico nei due anni successivi.
 Anche il saggio monaco Osho (Kokuten Kodo) trova, come Yano, che Sanshiro non sia minimamente cambiato.
Anche il saggio monaco Osho (Kokuten Kodo) trova, come Yano, che Sanshiro non sia minimamente cambiato.
Ed è indubbiamente una critica: i viaggi servono per fare esperienza e crescere, ad ogni viaggio materiale deve corrispondere un viaggio interiore.
Sanshiro invece, lo ammette lui stesso, è ancora avvolto da dubbi e timori, senza sapere dove indirizzare i suoi passi.
Le sue esperienze non lo hanno portato da nessuna parte.
Se il judo è una via, Sanshiro ancora non l'ha imboccata con decisione e coerenza.
 Osho, nella tradizione dell'impietoso quanto salutare metodo zen, non è diplomatico: Sanshiro non è capace nemmeno di innamorarsi sul serio. Non andrà lontano con questa sua pigrizia mentale.
Osho, nella tradizione dell'impietoso quanto salutare metodo zen, non è diplomatico: Sanshiro non è capace nemmeno di innamorarsi sul serio. Non andrà lontano con questa sua pigrizia mentale.
E' disponibile tuttavia a fare un ultimo tentativo: il vestito di Sanshiro merita da tempo di andare in pensione, e Sayo ha intenzione di regalargliene uno nuovo.
Troncando brutalmente ogni obiezione di Sanshiro, Osho gli impone di accettarlo.
Dovrà accettare assieme a quel dono anche l'obbligo di guardarsi dentro, senza timore, e di accettarsi.
O correggersi.
 L'intervento di Osho previene di un filo la prova che attende Sanshiro. Sono alla porta del dojo due strani visitatori.
L'intervento di Osho previene di un filo la prova che attende Sanshiro. Sono alla porta del dojo due strani visitatori.
Tesshin Higaki , dall'aspetto minaccioso ed aggressivo, è il fratello di Gennosuke Higaki, l'acerrimo avversario di Sanshiro nel primo episodio della saga, ed è interpretato dallo stesso attore, Ryûnosuke Tsukigata.
Lo accompagna il terzo fratello Genzaburo (Akitake Kôno), dal comportamento bizzarro ed inquietante e sul cui personaggio dovremo soffermarci.
Spesso nelle rappresentazioni giapponesi appaiono figure enigmatiche di adolescenti androgini dai capelli incolti e dal comportamento imprevedibile, in cui si incarnano le tensioni della vicenda. Ne costituiscono a volte il catalizzatore, a volte ne divengono la vittima sacrificale ed incolpevole. Un analogo personaggio, il flautista cieco Tsurumaru, lo troviamo in un'opera di Kurosawa molto più tarda, Ran (1985).
 Il comportamento dei due, invitati a visitare liberamente il dojo, è arrogante e scortese; entrano senza soffermarsi nel saluto formale, violando apertamente regole tramandate e consolidate nei secoli.
Il comportamento dei due, invitati a visitare liberamente il dojo, è arrogante e scortese; entrano senza soffermarsi nel saluto formale, violando apertamente regole tramandate e consolidate nei secoli.
Gli insegnanti presenti ordinano di lasciar correre, presumendo che vengano da un dojo straniero ove vigono usanze diverse, ma anche per non venire meno alla propria etichetta che conformemente all'uso giapponese prescrive di non mettere a disagio il visitatore facendogli notare le sue mancanze o la sua ignoranza.
I visitatori sfrontatamente leggono ad alta voce dai nafuda kake appesi alla parete i nomi dei discepoli del dojo. L'ultimo in quanto più alto in grado è Sugata Sanshiro. E individuatolo si dirigono immediatamente verso di lui, con aria minacciosa.
 Kurosawa aveva voluto Genzaburo apparisse sullo schermo con un ramo di bambu nella mano, il segnale che indica nel teatro noh i personaggi affetti da follia.
Kurosawa aveva voluto Genzaburo apparisse sullo schermo con un ramo di bambu nella mano, il segnale che indica nel teatro noh i personaggi affetti da follia.
Ora dopo avere provocato Sanshiro con un atteggiamento intimidatorio, di aperta sfida, viene colto da una crisi, probabilmente di natura epilettica.
Prende ad aggirarsi senza pace per il dojo, come un lupo in trappola, strappando poi una tavola di legno dalla parete, dopo un urlo disperato e raggelante.
 Gli uomini dello Shudokan lo attorniano, giudicando di avere sopportato fin troppo, eTesshin si mette in posizione di guardia a sua difesa.
Gli uomini dello Shudokan lo attorniano, giudicando di avere sopportato fin troppo, eTesshin si mette in posizione di guardia a sua difesa.
Il sopraggiunto Yano cerca di calmare gli animi.
Chiede se l'arte praticata dagli Higaki è il karate. Sì, il karate della scuola Higaki, ribatte Tesshin presentandosi e scusandosi per il comportamento del fratello, che soffre di una misteriosa malattia.
Il loro fratello più anziano, Gennosuke, sconfitto da Sanshiro Sugata, era un debole. E ora sono lì, dopo un lungo viaggio dalla lontana Kyushu (Okinawa, da dove il karate venne introdotto in Giappone solo nel XX secolo, diversi decenni dopo le vicende narrate).
Il loro scopo è sfidare Sanshiro e dimostrare la superiorità della loro scuola.
 Sanshiro tuttavia rifiuta.
Sanshiro tuttavia rifiuta.
Yano concorda: il karate praticato dagli Higaki non è, secondo lui, un'arte marziale.
Lo prova il fatto che non salutino entrando nel dojo. Nel Giappone di una volta chi si comportava così non avrebbe potuto essere guerriero né samurai.
Yano rifiuta quindi di concedere l'autorizzazione al combattimento, e invita a non insistere: Sugata è un discepolo, il suo parere rimarrà sempre allineato a quello della scuola.
Tuttavia Higaki è certo che Sugata ami le sfide: gli è bastato vederlo.
Gli sarà sufficiente attendere per ottenere quanto vuole.
 Il regolamento (okite) dello Shudokan vieta i confronti con le altre scuole, le partecipazioni agli spettacoli, e ogni attività che possa imbrattare il dojo, ed in particolare bervi o mangiarvi.
Il regolamento (okite) dello Shudokan vieta i confronti con le altre scuole, le partecipazioni agli spettacoli, e ogni attività che possa imbrattare il dojo, ed in particolare bervi o mangiarvi.
Vediremo invece Sanshiro, solitario, abbandonarsi al sake nella sala di allenamento.
 Il sake gli è necessario per dormire, e per non chiedersi in continuazione perchè abbia tanti nemici.
Il sake gli è necessario per dormire, e per non chiedersi in continuazione perchè abbia tanti nemici.
L'amico Dan, che lo ha raggiunto, lo conforta: è normale e non dipende da lui, chi è forte ha automaticamente nemici.
 Neanche Yano dorme, e sorprende i due nel bel mezzo della discussione
Neanche Yano dorme, e sorprende i due nel bel mezzo della discussione
Invano Dan cerca di nascondere la fiasca di sake prima che la veda.
Il maestro anzi raccoglie e la utilizza, senza alcun commento, per mostrare gli squilibri che intende studiare il giorno seguente assieme ai discepoli.
E al termine, senza dar mostra di avere notato la grave trasgressione, augura la buonanotte e va via.
 Allo Shudokan si presenta qualche tempo dopo Daisaburo (Ko Ishida) il ragazzo che involontariamente aveva provocato la 'esibizione' di Sanshiro all'inizio del film.
Allo Shudokan si presenta qualche tempo dopo Daisaburo (Ko Ishida) il ragazzo che involontariamente aveva provocato la 'esibizione' di Sanshiro all'inizio del film.
Ha ancora intenzione di praticare judo e chiede al suo eroe di accettarlo come allievo.
Alle spalle di Sanshiro appaiono, appesi alla parete, i keikogi dei praticanti avvolti nella cintura.
Era un uso comune fino al 1960 circa lasciarli in questo modo all'interno del dojo, al termine della pratica.
Sanshiro ha già detto di non sentirsi pronto per avere discepoli, in più sta attraversando una grave crisi.
E' chiaro che non vorrebbe accettare l giovane, ma infine prende un keikogi, presumibilmente il suo, e glielo porge. Il ragazzo è ammesso allo Shudokan: ma dovrà prepararsi a soffrire.
 Kurosawa segue, naturalmente a suo modo, con chiari prodromi dello spirito innovativo e della maestria narrativa, già in embrione nel primo Sugata Sanshiro (1942) e che avrebbe sviluppato di lì a poco con i suoi capolavori, la crescita di Daisaburo.
Kurosawa segue, naturalmente a suo modo, con chiari prodromi dello spirito innovativo e della maestria narrativa, già in embrione nel primo Sugata Sanshiro (1942) e che avrebbe sviluppato di lì a poco con i suoi capolavori, la crescita di Daisaburo.
La tavoletta che riporta il suo nome avanza nella gerarchia dei praticanti, dopo avere iniziato dall'ultimo posto disponibile.
L'inflessibile allenamento che veniva imposto ai principianti di ogni arte marziale fino a pochi decenni orsono trasforma la persona stessa, nel corpo e nel carattere.
Ogni volta che Kurosawa ci mostra Daisaburo entrare nel dojo eseguendo il saluto zarei il suo keikogi inizialmente immacolato è più logoro, la sua figura si fa più vigorosa, il suo atteggiamento più sicuro e più rilassato.
 Lo spettatore sa quindi che diverso tempo è già passato, quando Daisaburo ritorna dal suo abituale lavoro trainando il jinrikisha vuoto e trova al suolo un praticante dello Shudokan privo di sensi.
Lo spettatore sa quindi che diverso tempo è già passato, quando Daisaburo ritorna dal suo abituale lavoro trainando il jinrikisha vuoto e trova al suolo un praticante dello Shudokan privo di sensi.
E' stato aggredito da alcuni uomini, che dopo avergli chiesto se appartenesse allo Shudokan immediatamente lo hanno malmenato. Da quello che ha compreso non appartenevano ad una scuola di ju jutsu.
Gli attacchi allo Shudokan continuano, lo stesso Daisaburo cade in un ennesimo agguato. Ogni giorno qualcuno viene aggredito, e i discepoli hanno timore di ammetterlo con Yano, che ne sembra tuttavia divertito. Ha già compreso che gli aggressori provengono dalla scuola del karate.
 Con sua grande sorpresa a Sanshiro viene chiesto un colloquio da Gennosuke Higaki, il suo acerrimo nemico.
Con sua grande sorpresa a Sanshiro viene chiesto un colloquio da Gennosuke Higaki, il suo acerrimo nemico.
Non ha intenzioni aggressive e non è più nemmeno lo stesso uomo violento e privo di scrupoli e sentimenti che lui aveva affrontato due anni prima: riconosce che il judo lo ha vinto, e sa di essere malato senza speranza, ma ritiene di avere raggiunto la vera luce.
Ha invano supplicato i fratelli di abbandonare i piani di vendetta e ritornare nella loro isola. Gli è stato solo rinfacciato di essere rimasto codardamente passivo di fronte a chi gli ha portato via l'onore e la donna.
Si sono ora ritirati in montagna per allenarsi intensamente, in attesa di un confronto con Sanshiro. Lui non può odiarli, ma si rende conto che non hanno alcun sentimento umano.
Soprattutto Tesshin, il 'serpente', che dal suo esempio ha preso solamente la parte peggiore. In quanto a Genzaburo, la sua malattia lo porta a momenti di violenza incontrollata. Sanshiro deve evitarli, non raccogliere la loro sfida. Non per salvare loro, ma per salvare se stesso e l'onore delle arti marziali del Giappone.
Al termine del colloquio Gennosuke consegna a Sanshiro come segno della sua stima il mokuroku, il rotolo contenente i segreti dell'arte del karate.
 Sarà Sanshiro, memore della sua antica dimestichezza con il jinrikisha, a riaccompagnare Gennosuke con il calessino dell'infortunato Daisaburo.
Sarà Sanshiro, memore della sua antica dimestichezza con il jinrikisha, a riaccompagnare Gennosuke con il calessino dell'infortunato Daisaburo.
Vorrebbe proteggerlo con la copertura a soffietto, fa freddo, ma Gennosuke lo prega di lasciargli vedere le strade per l'ultima volta. Mentre si preparano alla partenza Kurosawa ci fa udire le ingenue strofe popolari che celebrano la forza di Sanshiro, cantate da voci infantili.
Il fato vuole però che in quel momento i due incontrino Sayo: il suo sguardo incrocia quello del sofferente Gennosuke, che chiederà infine di chiudere il jinrikisha.
Non può sopportare il dolore di vederla davanti ai suoi occhi e nemmeno vuole mostrare questo suo dolore.
 La notte, alla fioca luce di una lampada, Sanshiro si allena solitario nel dojo. Attirati dal rumore arrivano i suoi compagni. Viene loro mostrata in silenzio una missiva.
La notte, alla fioca luce di una lampada, Sanshiro si allena solitario nel dojo. Attirati dal rumore arrivano i suoi compagni. Viene loro mostrata in silenzio una missiva.
E' la sfida da parte dei fratelli Higaki, che attengono Sanshiro il 15 dicembre, sul monte Tengu, per una lotta senza quartiere.
Sanshiro accetterà, pur sapendo che verrà espulso dal dojo avendone violato le tre regole.
Non esita a dare chiarimenti: vi ha bevuto sake infrangendo la prima regola, e accettando la sfida infrangerà la seconda.
Ed è il momento di confessare che ha partecipato ad uno spettacolo, infrangendo anche la terza.
 Aveva infatti accettato infine il combattimento con il pugile americano William Lister (l'attore Roy James, in realtà appartenente ad una famiglia russa in esilio residente in Giappone, che in diversi film giapponesi rivestì i panni dello 'straniero').
Aveva infatti accettato infine il combattimento con il pugile americano William Lister (l'attore Roy James, in realtà appartenente ad una famiglia russa in esilio residente in Giappone, che in diversi film giapponesi rivestì i panni dello 'straniero').
Presentato con toni da imbonitore dall'intrigante Nunobiki, Sanshiro viene descritto come un personaggio misterioso il cui nome non può essere rivelato. Ma il pubblico giapponese lo riconosce immediatamente come il celebre Sugata Sanshiro, e lo elegge a suo paladino, nella speranza che vendichi la sconfitta ingloriosa subita dal maestro di ju jutsu.
Per contro i numerosi marinai stranieri presenti parteggiano calorosamente per Lister. Non è solo uno scontro tra due uomini, ma tra due culture che non hanno ancora imparato a rispettarsi.
 Sanshiro non ha molti problemi per avere ragione del suo avversario: afferrato il braccio che tentava di sferrargli un pugno lo mantiene in presa evitando che l'americano possa usare l'altra mano, e attende l'occasione propizia per atterrarlo.
Sanshiro non ha molti problemi per avere ragione del suo avversario: afferrato il braccio che tentava di sferrargli un pugno lo mantiene in presa evitando che l'americano possa usare l'altra mano, e attende l'occasione propizia per atterrarlo.
La proiezione è violenta e spettacolare ed il pugile sembra destinato a non rialzarsi.
Facendo appello a tutte le sue forze ritorna tuttavia in piedi e cerca di riprendere il combattimento.
Sanshiro lo attende impassibile senza muovere ciglio e senza nemmeno accennare a rimettersi in guardia.
Il suo avversario infatti ha preteso troppo dalle sue forze, e piomberà definitivamente al suolo privo di sensi, senza essere stato nemmeno sfiorato.
 Sanshiro rifiuta la generosa borsa dell'incontro, scosta con decisione Nunobiki che tentava di trattenerlo, sollevandolo di peso, e va via incurante degli applausi del pubblico incredulo.
Sanshiro rifiuta la generosa borsa dell'incontro, scosta con decisione Nunobiki che tentava di trattenerlo, sollevandolo di peso, e va via incurante degli applausi del pubblico incredulo.
Il compenso migliore per lui è la commozione di Sahei, l'uomo sconfitto in precedenza da Lister, che non riesce a trattenere le lagrime.
E' infine a lui che Sanshiro consegnerà la somma vinta, andandola a riprendere dal corpo esanime di Lester dove l'aveva gettata con disprezzo.
 Sanshiro si trova ora di nuovo a colloquio con il saggio Osho: gli annuncia il suo ritiro dallo Shudokan.
Sanshiro si trova ora di nuovo a colloquio con il saggio Osho: gli annuncia il suo ritiro dallo Shudokan.
Non sopporterebbe di essere escluso dal maestro Yano per avere infranto le regole, ha quindi spontaneamente ritirato la tavoletta con il suo nome.
 Naturalmente Osho non è affatto d'accordo.
Naturalmente Osho non è affatto d'accordo.
Non si abbandona la via per un puro formalismo o a proprio arbitrio e le regole hanno lo scopo di facilitare il percorso, ma non sono il percorso.
Che sia tra un giorno o tra venti anni Sanshiro sentirà prima o poi il dovere di rimettere al suo posto quella tavoletta, riprendendo il percorso che gli è destinato, che si è scelto e che gli è stato prescritto.
 Sanshiro non ha il coraggio di cedere ai suoi consigli.
Sanshiro non ha il coraggio di cedere ai suoi consigli.
Chiede il permesso di restare ancora una notte nel dojo per meditare prima del suo prossimo combattimento con gli Higaki.
Si è allenato coscienziosamente, ma ha anche pulito il dojo, portato l'acqua, lavato i corridoi. Nulla è servito a dargli la serenità.
Osho acconsente: e resterà a meditare con lui. Il suo intervento è deciso: Sanshiro sta probabilmente tentando di dimenticare i suoi tormenti ed il suo avversario, Osho gli impone al contrario di concentrarsi su di essi.
Sanshiro tenta. Ma fallisce.
 In maniera imprevista Osho gli viene ancora una volta in soccorso. Dopo averlo messo in guardia dal pericolo di addormentarsi, ed essere statp al suo fianco per evitarlo, il venerando Osho è piombato di colpo nel sonno!
In maniera imprevista Osho gli viene ancora una volta in soccorso. Dopo averlo messo in guardia dal pericolo di addormentarsi, ed essere statp al suo fianco per evitarlo, il venerando Osho è piombato di colpo nel sonno!
Il divertente episodio libera la mente di Sanshiro.
Finalmente è sereno.
 Il giorno dopo prende commiato da Sayo. Non sa quanto durerà la separazione, che la ragazza vorrebbe immediatamente quantificare. Parte per un combattimento senza pietà e dall'esito incerto. Non è incerto per Sayo: lui vincerà, ne è certa.
Il giorno dopo prende commiato da Sayo. Non sa quanto durerà la separazione, che la ragazza vorrebbe immediatamente quantificare. Parte per un combattimento senza pietà e dall'esito incerto. Non è incerto per Sayo: lui vincerà, ne è certa.
Il legame che si sta riannodando tra i due viene reso da Kurosawa con una serie di formali e rispettosi saluti, ripetuti più volte, a distanze sempre maggiori perché nessuno dei due vorrebbe separarsi dall'altro e continuano a volgersi indietro.
La loro sorte ci rimarrà sconosciuta: il film si chiude senza che i due si rivedano.
Sono probabilmente queste ripetute indecisioni nella trama che fanno concludere a Kurosawa che Zoku Sugata Sanshiro è un'opera non completamente riuscita.
Viene però da chiedersi se questi dubbi non siano piuttosto una certificazione del momento particolare in cui si trovavano Kurosawa ed il Giappone stesso.
Tuttora alla ricerca di una sua via, personale e professionale, in una nazione traumatizzata e sconvolta dalle tragiche conseguenze della guerra, non poteva essere Kurosawa a sciogliere sullo schermo grandi nodi esistenziali. Non ancora.
 Sanshiro si trova infine di fronte a Tesshin: è solo. Genzaburo, in preda ad una delle sue crisi, non verrà.
Sanshiro si trova infine di fronte a Tesshin: è solo. Genzaburo, in preda ad una delle sue crisi, non verrà.
Ad accrescere la drammaticità delle scene Kurosawa ha scelto per le riprese un desolato altopiano ricoperto di neve, presso la località termale di Hoppo.
Nelle sue memorie ricorda che Tsutsumu Fujita, che avrebbe potuto anche essere più comprensivo visto che grazie alla sua interpretazione di Sanshiro era arrivato alla fama , gli rinfacciò per molti anni il freddo che aveva patito girando quelle scene a piedi nudi sulla neve, indossando solo il keikogi.
 Il combattimento viene scandito dai selvaggi kiai di Higaki, cui rispondono empaticamente le grida belluine del folle Genzaburo che attende impotente fuori della sua capanna.
Il combattimento viene scandito dai selvaggi kiai di Higaki, cui rispondono empaticamente le grida belluine del folle Genzaburo che attende impotente fuori della sua capanna.
Sanshiro preferisce invece trattenere la sua energia per la liberarla nel momento di eseguire un'azione.
La lotta è logicamente incentrata ancora una volta sulla ricerca del colpo risolutore da parte dell'assalitore, il karateka.
Il judoka si limita ad evitare i colpi attendendo l'occasione per una presa, o perlomeno per arrivare a distanza di corpo a corpo.
 Finalmente, nel tentativo di vibrare un colpo Higaki si avvicina troppo.
Finalmente, nel tentativo di vibrare un colpo Higaki si avvicina troppo.
Sanshiro si abbassa e con una tecnica che sembra essere, ma è inquadrata molto da lontano, una replica di quella già vista nelle scene di apertura, abbassandosi di colpo lo fa ruotare sopra le proprie spalle e lo proietta nella scarpata sottostante.
 Con la scena successiva Kurosawa ha deciso di sorprendere lo spettatore.
Con la scena successiva Kurosawa ha deciso di sorprendere lo spettatore.
Nella capanna dove si erano preparati al combattimento gli Higaki, Sanshiro ha acceso il fuoco e cerca di far riprendere le forze allo sconfitto Tesshin.
Genzaburo assiste muto.
Rifiuta di accettare il cibo offertogli da Sanshiro, e continua a fissarlo senza mai distogliere lo sguardo.
 Esausto dal combattimento, e dalle continue cure che deve prestare a Tesshin, Sanshiro cede al sonno. Solo allora Genzaburo, con estrema cautela, si muove.
Esausto dal combattimento, e dalle continue cure che deve prestare a Tesshin, Sanshiro cede al sonno. Solo allora Genzaburo, con estrema cautela, si muove.
Afferra un coltellaccio celato sotto la paglia del pavimento, e si avvicina al dormiente Sanshiro. Ha già alzato la mano per uccidere, ma è lui ad essere colpito sul tempo, e in modo imprevisto.
Nel sonno Sanshiro sorride, un sorriso ingenuo come quello di un bambino.
Vinto da quel sorriso Genzaburo lascia cadere l'arma dalla mano, si ritira nel suo angolo e piange.
 All'alba Sanhsiro si risveglia.
All'alba Sanhsiro si risveglia.
Genzaburo sta mangiando il cibo che lui gli aveva preparato, Tesshin si sta riprendendo dalla forte febbre che lo aveva assalito.
Mentre Genzaburo, scusandosi che il cibo sia ormai freddo, riaccende il fuoco, Sanshiro va a prendere dell'acqua per Tesshin.
Rimasti soli, i due fratelli accettano con un sorriso la sconfitta.
 Al di fuori, anche Sanshiro sorride.
Al di fuori, anche Sanshiro sorride.
Akira Kurosawa: Sugata Sanshiro
1943
Susumu Fujita, Denjiro Okochi, Yukiko Todoroki, Takashi Shimura, Ryunosuke Tsukigata
 Sul finire del 1800 varie scuole di jujutsu si confrontano per avere la supremazia, inviando i loro migliori esponenti ai tornei che selezioneranno gli istruttori di esercito e polizia.
Sul finire del 1800 varie scuole di jujutsu si confrontano per avere la supremazia, inviando i loro migliori esponenti ai tornei che selezioneranno gli istruttori di esercito e polizia.
Il migliore allievo della scuola Kodokan di Jigoro Kano otterrà la vittoria aprendo la strada allo straordinario successo del judo.
Commissionato per esaltare in tempo di guerra le virtù tradizionali del popolo giapponese il film, che narra di queste vicende, venne poi seguito da un secondo episodio iniziato a girare poco prima della fine della guerra ma terminato dopo.
Infatti in alcuni confronti oriente-occidente introdotti ad arte vi si tenterà tra le righe una critica all’arroganza delle truppe di occupazione; ad esempio mostrando un confronto tra il judoka ed un pugile statunitense, che aveva brutalizzato i precedenti avversari.
 Si tratta delle prime prove in assoluto di Akira Kurosawa, allora poco più che trentenne e reduce da travagliate vicende familiari che non gli avevano ancora consentito di trovare una sua via.
Si tratta delle prime prove in assoluto di Akira Kurosawa, allora poco più che trentenne e reduce da travagliate vicende familiari che non gli avevano ancora consentito di trovare una sua via.
Sugata Sanshiro, questo è anche il nome del protagonista, è la sua prima prova in assoluto come direttore, dopo il tirocinio sotto il suo maestro Kanjiro Yamamoto: fu un'opera tormentata dalla censura bellica, per ragioni che non hanno ancora trovato una spiegazione convincente.
La lunghezza originaria era di 97 minuti, ma l'anno successivo l'intervento della censura obbligò ad eliminarne circa 17 e la versione rimaneggiata - l'unica rimasta fino al ritrovamento in Russia molti anni dopo di una copia con alcune scene tagliate - ne conta 72 circa. Va ricordato, forse è semplicemente questa la ragione principale, che una legge del 1944 limitava la lunghezza delle opere cinematografiche, e dopo il rimaneggiamento Sugata Sanshiro rientrava di giustezza nei limiti.
 Si è tentato di ricostruire le parti mancanti attraverso un esame della sceneggiatura originale e una attenta osservazione delle scene in cui appaiono dei salti logici, ma come abbiamo detto senza arrivare a risultati definitivi. Particolarmente presa di mira dalla censura fu la discussione tra il maestro Yano (Denjiro Okochi) e il discepolo Sugata (Susumu Fujita) che precede il ravvedimento di questultimo.
Si è tentato di ricostruire le parti mancanti attraverso un esame della sceneggiatura originale e una attenta osservazione delle scene in cui appaiono dei salti logici, ma come abbiamo detto senza arrivare a risultati definitivi. Particolarmente presa di mira dalla censura fu la discussione tra il maestro Yano (Denjiro Okochi) e il discepolo Sugata (Susumu Fujita) che precede il ravvedimento di questultimo.
Ma sembra che la versione eliminata parlasse della necessità di obbedire ad ordini superiori mentre quella post censura parla di generica opportunità di comportarsi rettamente. Non è chiaro quindi perché la censura bellica avrebbe dovuto tagliare una frase che poteva semmai essere di supporto alla propaganda militarista.
Lo stesso Kurosawa, che scrisse la sceneggiatura di un'opera omonima uscita nel 1965, diretta da Seichiro Yuchikawa, rinunciò a ritornare alla versione originaria né ha mai spiegato quali fossero le parti tagliate, pur ricordando nella sua autobiografia che si era trattenuto a stento dall'aggredire i componenti della commissione di censura e venne portato via da un provvidenziale intervento di Ozu e Taasaka, i due soli registi membri della commissione, che elogiarono anche il suo lavoro. Durante l'interminabile attesa due anonimi impiegati dell'ufficio discutevano animatamente tra di loro, ed uno dei due esclamando "Yama arashi!" (la tecnica di judo con cui il protagonista vinceva i suoi incontri) scagliò l'altro al solo. Kurosawa ebbe così conferma che il suo film nonostante tutto avrebbe incontrato il favore del pubblico.
I personaggi dell'opera provengono dalla vita reale. Sugata Sanshiro è tratto dall'omonimo romanzo - mai pubblicato per quanto ne sappiamo in occidente - di Tsuneo Tomita, legato per motivi familiari all'ambiente del Kodokan. Kurosawa ebbe una sorta di premonizione: tormentò incessanemente Nobuyoshi Morita, capo divisione della casa di produzione per acquistare i diritti del romanzo, ma dovette confessare non solo di non averlo letto, ma che nemmeno era stato ancora pubblicato. Finalmente si presentò di notte alla casa di Morita, avvolta nel buio, e bussò alla porta con la prima copia del libro chiedendo di leggerlo immediatamente.
 La scuola Kodokan venne fondata nel 1882 da Jigoro Kano (1860-1938) che nel film viene chiamato Shagoro Yano, fino allora praticante di varie scuole di ju jutsu. Il suo metodo venne chiamato judo e si affermò in breve tempo, anche vincendo numerosi tornei interstile organizzati dalle forze dell'ordine e dall'esercito per selezionare gli istruttori.
La scuola Kodokan venne fondata nel 1882 da Jigoro Kano (1860-1938) che nel film viene chiamato Shagoro Yano, fino allora praticante di varie scuole di ju jutsu. Il suo metodo venne chiamato judo e si affermò in breve tempo, anche vincendo numerosi tornei interstile organizzati dalle forze dell'ordine e dall'esercito per selezionare gli istruttori.
I campioni più rappresentativi del Kodokan, chiamati Shitenno (Quattro Guardiani) furono Shiro Saigo (1866-1922), che è il personaggio principale del film con il nome di Sanshiro Sugata, Sakujiro Yokohama, Yoshiaki Yamashita e Tsunejiro Tomita (1865-1937). Tsuneo Tomita, l'autore del romanzo, era figlio di quest'ultimo.
 Il film inizia con l'arrivo di Sanshiro al dojo Monma jujutsu, in Tokyo, presso cui intende praticare. E' l'anno 1882.
Il film inizia con l'arrivo di Sanshiro al dojo Monma jujutsu, in Tokyo, presso cui intende praticare. E' l'anno 1882.
Non ne riceve una buona impressione: sono persone volgari e dedite al bere, ma gli promettono di dar mostra a breve della loro arte.
Hanno intenzione infatti di dare una lezione a Shagoro Yano, che ha da poco fondato una nuova scuola, permettendosi anche la sfrontatezza di darle un nome del tutto nuovo, in rottura con la tradizione: il judo.
 Gli tenderanno un agguato per strada, di sera. Yano arriva a bordo di un ricsciò (jinrikisha), una carrozzina a ruote introdotta da poco, tirata da un uomo: in precedenza l'utilizzo di ogni veicolo a ruote era interdetto dalla legge, per regolamentare le comunicazioni e impedire il rapido spostamento di truppe, e si utilizzavano delle portantine.
Gli tenderanno un agguato per strada, di sera. Yano arriva a bordo di un ricsciò (jinrikisha), una carrozzina a ruote introdotta da poco, tirata da un uomo: in precedenza l'utilizzo di ogni veicolo a ruote era interdetto dalla legge, per regolamentare le comunicazioni e impedire il rapido spostamento di truppe, e si utilizzavano delle portantine.
Un tocco realistico che Kurosawa utilizza - assieme ad altri introdotti senza farli troppo notare - per rendere l'idea di un Giappone in rapido ed irreversibile mutamento.
Sul bordo di un canale, Yano viene affrontato dai malintenzionati; ha l'abbigliamento tradizionale della classe samurai, per quanto sia disarmato. E' di pochi anni prima (1876) la proibizione del porto delle due spade.
 Ci viene presentato da Kurosawa come una persona matura, l'interprete come detto è Denjiro Okochi. Saigo (Susumu Fujita) ha invece un aspetto decisamente giovanile, per rimarcare la distanza che intercorre tra maestro e discepolo.
Ci viene presentato da Kurosawa come una persona matura, l'interprete come detto è Denjiro Okochi. Saigo (Susumu Fujita) ha invece un aspetto decisamente giovanile, per rimarcare la distanza che intercorre tra maestro e discepolo.
In realtà questa distanza è più culturale che fisica. Al momento del loro primo incontro Saigo/Sugata aveva 16 anni, ma Yano/Kano non era di molto più anziano.
Aveva 24 anni solamente, e possiamo vedere il suo vero aspetto da questa foto che risale proprio al 1882, dove appare in abiti e con acconciatura occidentali.
Non si hanno indizi che l'episodio dell'aggressione da parte della scuola Monma si sia effettivamente verificato ed in quei termini, è tuttavia sostanzialmente plausibile.
 Il primo campione del Monma ryu affronta aggressivvamente Yano, e riesce a spingerlo fin sull'orlo del canale.
Il primo campione del Monma ryu affronta aggressivvamente Yano, e riesce a spingerlo fin sull'orlo del canale.
Yano riesce ad arrestarsi proprio sull'orlo, poi cedendo alla pressione dell'avversario si lascia cadere sulla schiena e lo proietta sopra di se nel canale, con una spettacolare tecnica che ogni praticante di judo conosce: tomoe nage.
Il brutto ceffo affonda nell'acqua melmosa, sollevando una marea di spruzzi. Kurosawa non si occupa più della sua sorte, e così faremo anche noi.
 Il secondo attaccante non ha sorte migliore, ma Kurosawa preferisce mostrare una tecnica che sembra attingere al bagaglio tecnico dell'aikido.
Il secondo attaccante non ha sorte migliore, ma Kurosawa preferisce mostrare una tecnica che sembra attingere al bagaglio tecnico dell'aikido.
Non è inverosimile: proprio nel 1942 la fondazione Aikikai veniva ufficialmente riconosciuta dal governo giapponese, e sappiamo che fin dagli inizi degli anni 30 il maestro Morihei Ueshiba aveva il suo dojo, allora chiamato Kobukan, a Tokyo.
Non conosciamo il nome del maestro d'armi che prestò la propria consulenza a Kurosawa, ma anche se si fosse trattato di un esperto di judo una sua conoscenza di base dell'aikido sarebbe la norma. Kano aveva inviato i suoi migliori allievi presso il Kobukan, ed alcuni di loro come ad esempio Minoru Mochizuki continuarono a studiarlo per tutta la vita.
Jigoro Kano aveva infatti conosciuto Ueshiba, elogiandolo pubblicamente ed accarezzando per qualche tempo l'idea di chiedegli un suo trasferimento al Kodokan.
 Kano approfittava volentieri delle competenze altrui: dopo le iniziali vittorie nei tornei interstile, il Kodokan patì ad inizio 900 una sconfitta ad opera della scuola Fusen ryu, specializzata nella lotta a terra. Kano lungi dall'irritarsi invitò i rappresentanti del Fusen ryu a trasmettere le loro conoscenze al Kodokan, modificandone l'impostazione in modo da tenere in maggior conto i punti dimostratisi deboli.
Kano approfittava volentieri delle competenze altrui: dopo le iniziali vittorie nei tornei interstile, il Kodokan patì ad inizio 900 una sconfitta ad opera della scuola Fusen ryu, specializzata nella lotta a terra. Kano lungi dall'irritarsi invitò i rappresentanti del Fusen ryu a trasmettere le loro conoscenze al Kodokan, modificandone l'impostazione in modo da tenere in maggior conto i punti dimostratisi deboli.
Ad ogni modo, la tecnica con cui Yano manda a rinfrescarsi il secondo aggressore nelle acque del canale è indiscutibilmente un kotegaeshi eseguito con piena aderenza ai canoni dell'aikido.
Gli altri aggressori vengono liquidati con disinvoltura man mano che azzardano un attacco, con classiche proiezioni o con immobilizzazioni a terra, sempre provenienti dal bagaglio tecnico del judo.
 Sanshiro Sugata è rimasto a bocca aperta.
Sanshiro Sugata è rimasto a bocca aperta.
 Sanshiro non rimane per molto a guardare: ha capito subito che quello sarà, deve essere il suo maestro.
Sanshiro non rimane per molto a guardare: ha capito subito che quello sarà, deve essere il suo maestro.
Il conducente del ricsciò si è dileguato, Sanshiro non ha esitazione a chiedere di prendere il suo posto e mettersi alle stanghe.
Porterà a destinazione il maestro Yano, e rimarrà con lui divenendone discepolo.
 Ha un attimo di impaccio quando si rende conto che non può correre con gli alti eta, gli zoccoli di legno che venivano utilizzati per evitare pozzanghere, fango e neve.
Ha un attimo di impaccio quando si rende conto che non può correre con gli alti eta, gli zoccoli di legno che venivano utilizzati per evitare pozzanghere, fango e neve.
Li lascia sul posto, così abbandonando simbolicamente anche la sua vita anteriore.
 La cinepresa di Kurosawa indugia su quegli zoccoli: trasportati qua e là dal vento, sferzati dalla pioggia, in bocca ad un cagnolino, infilzati sopra una cancellata di tipo occidentale, indizio dei cambiamenti traumatici che sconvolgono il Giappone in quegli anni.
La cinepresa di Kurosawa indugia su quegli zoccoli: trasportati qua e là dal vento, sferzati dalla pioggia, in bocca ad un cagnolino, infilzati sopra una cancellata di tipo occidentale, indizio dei cambiamenti traumatici che sconvolgono il Giappone in quegli anni.
Ed infine trasportati via dalle acque del canale.
Lo spettatore comprende immediatamente che sta trascorrendo diverso tempo: la sequenza successiva forse non renderà conto di quanto successo nel frattempo, sicuramente ci porterà molto avanti, in una situazione completamente diversa.
 Shiro Saigo fu l'ottavo discepolo ad essere iscritto nei registri del Kodokan. Uno dei primi dell'epoca, uno degli ultimi di quell'anno: il registro riporta solamente pochi nomi - nove - eppure il dojo doveva essere ben affollato: i tatami a disposizione erano solamente dodici.
Shiro Saigo fu l'ottavo discepolo ad essere iscritto nei registri del Kodokan. Uno dei primi dell'epoca, uno degli ultimi di quell'anno: il registro riporta solamente pochi nomi - nove - eppure il dojo doveva essere ben affollato: i tatami a disposizione erano solamente dodici.
Già l'anno seguente Shiro Saigo fu uno dei due discepoli a ricevere l'importante nomina a yudansha. Fu Kano per primo, in quell'occasione, ad istituire questo sistema di graduazione, e ad adottare una cintura di colore nero per tutti i diplomati a livello dan.
Kurosawa non ha però l'intenzione di mostrarci la rapida ascesa di Sanshiro, vuole piuttosto farci capire che la sua abilità tecnica e la sua forza fisica non ne fanno necessariamente un maestro, anzi probabilmente nemmeno un uomo maturo: è ancora, anche lui, un cucciolo che gioca.
 Siamo ora presumibilmente in Yoshiwara, il quartiere dei piaceri di Tokyo.
Siamo ora presumibilmente in Yoshiwara, il quartiere dei piaceri di Tokyo.
E' chiaramente in atto una rissa, e il protagonista è Sanshiro, in preda ad una folle esaltazione ma non dimentico delle tecniche apprese da Yano.
Tra le sue mani gli avversari volano come fuscelli. Fin quando inavvertitamente attacca briga con un gigantesco sumotori.
Impassibile, divertito, costui lo fissa: accetta volentieri il confronto, ma senza animosità, senza aggressiviità.
Non sapremo come andrà a finire. Kurosawa si contenta di averci mostrato l'esaltazione giovanile di cui ancora è preda Sanshiro, e immediatamente sposta l'azione nella dimora di Yano.
 La reprimenda di Yano al suo discepolo, che si presenta mortificato e con la veste strappata, è senza pietà: non è quella la strada che intende indicare ai suoi allievi e non sa che farsene di chi dimostra di non essere pronta a seguirla.
La reprimenda di Yano al suo discepolo, che si presenta mortificato e con la veste strappata, è senza pietà: non è quella la strada che intende indicare ai suoi allievi e non sa che farsene di chi dimostra di non essere pronta a seguirla.
Come già detto non è facile ricostruire cosa effettivamente Kurosawa intendesse mettere in bocca al maestro.
Questa è sicuramente la scena che la censura ha maggiormente preso di mira, al punto tale da non poterne ragionevolmente tentare una ricostruzione sicura.
Rispettiamo quindi la volontà dello stesso Kurosawa, che ha rinunciato nel prosieguo della sua vita a chiarire il mistero.
 Il senso generale non lascia però adito ad alcun dubbio.
Il senso generale non lascia però adito ad alcun dubbio.
Sugata Sanshiro non inizierà a seguire veramente la via del judo e non potrà essere un vero combattente se non quando avrà rinunciato alla sua giovanile ed inutile aggressività e al suo orgoglio.
Dovrà raggiungere attraverso il satori lo stato di reale armonia con se stesso, con gli altri e con l'energia dell'universo.
 Disperato Sanshiro si alza, esce nella veranda - è una fredda ed inquieta giornata d'inverno - e si getta nello stagno sottostante, spezzandone la coltre di ghiaccio ed aggrappandosi ad un palo per non andare a fondo.
Disperato Sanshiro si alza, esce nella veranda - è una fredda ed inquieta giornata d'inverno - e si getta nello stagno sottostante, spezzandone la coltre di ghiaccio ed aggrappandosi ad un palo per non andare a fondo.
Giura di essere pronto a morire, e che non abbandonerà a nessun costo il suo proposito e la sua scomoda posizione.
Yano non ha alcun cedimento, gli augura anzi provocatoriamente di andare all'inferno.
 Durante la notte interviene anche Osho (Kokuten Kodo), un saggio prete che frequenta il dojo e la casa di Yano.
Durante la notte interviene anche Osho (Kokuten Kodo), un saggio prete che frequenta il dojo e la casa di Yano.
Anche lui cerca di scuotere con aspre critiche il giovane presuntuoso, ma invano: non è ancora pronto a capire.
La notte di veglia nello stagno ghiacciato gli porterà però una luce, assieme a quella dell'alba che sta sorgendo.
 Accanto a lui, un fiore di loto sboccia maestosamente.
Accanto a lui, un fiore di loto sboccia maestosamente.
In quel momento Sanshiro raggiunge il satori, la completa armonia con le forze della natura.
Comprende i suoi errori, e chiedendo scusa al maestro Yano per la sua arroganza, decide di iniziare una nuova vita.
Quello che Kurosawa non perdona sono gli errori di certi critici: si è detto e ridetto che i fiori di loto non sbocciano di notte, e Kurosawa commentava sconsolato che non saprebbe cosa altro aggiungere alla scena per far capire che è l'alba (si ode perfino il canto del gallo).
E lo schiudersi del fiore, accompagnato da un accordo musicale, e nella riedizione negli anni 60 da un percebile suono, sarebbe assurdo: i fiori non emettono alcun suono all'aprirsi. Kurosawa assicura nella sua non-autobiografia di essersene invece accertato di persona recandosi ad osservare l'apertura dei fiori nello stagno di Shinobazu.
Ma, soprattutto, osserva che chi confonde un fenomeno materiale con una espressione poetica non ha speranza di essere curato, e mai potrà comprendere, considerandolo una ovvietà, il celeberrimo haiku di Basshô:
Un vecchio stagno
Una rana vi si getta.
Il suono dell'acqua.
 Una sfida attende immediatamente il nuovo Sanshiro. Ma non è più quello di prima, e dovrà rendersi conto che non ha ancora il diritto di accettarla.
Una sfida attende immediatamente il nuovo Sanshiro. Ma non è più quello di prima, e dovrà rendersi conto che non ha ancora il diritto di accettarla.
Sta tranquillamente lavando i suoi panni come era uso in ogni parte del mondo prima che venisse introdotta l'acqua corrente nelle case, ossia pestandoli con i piedi in un rigagnolo.
Qualcuno gli si avvicina alle spalle, e lo tocca col manico dell'ombrello per farlo voltare.
 E' uno strano personaggio.
E' uno strano personaggio.
Impeccabilmente vestito all'occidentale, dai modi freddi ed arroganti.
Si chiama Gennosuke Higaki (interpretato da Ryunosuke Tsukigata) ed è un campione di una scuola avversaria.
E' venuto a chiedere un confronto con il maestro della scuola del judo.
 Shagoro Yano è però assente, e l'ospite viene ricevuto dal dojocho - responsabile della scuola - Saburo Kodama sensei (Yoshio Kosugi).
Shagoro Yano è però assente, e l'ospite viene ricevuto dal dojocho - responsabile della scuola - Saburo Kodama sensei (Yoshio Kosugi).
Questi acconsente solamente ad un incontro con uno degli allievi, vietando a Sanshiro di accettare la sfida
 Igaki batte con facilità irrisoria il rappresentante del Kodokan.
Igaki batte con facilità irrisoria il rappresentante del Kodokan.
Il suo modo di combattere è violento, ma efficace.
Il malcapitato avversario è ridotto a mal partito e lo si deve soccorrere.
 Gennosuke Igaki ha fatto quello che era venuto a fare, ma non sembra soddisfatto. Ha istintivamente identificato in Sanshiro un nemico mortale, e lo fissa con aria di sfida.
Gennosuke Igaki ha fatto quello che era venuto a fare, ma non sembra soddisfatto. Ha istintivamente identificato in Sanshiro un nemico mortale, e lo fissa con aria di sfida.
Sanshiro Sugata rimane impassibile.
Sa già probabilmente che verrà il momento di dover accettare questa sfida, ma si rende anche conto che il momento deve ancora arrivare, e non potrà essere lui a giudicare quando sia arrivato.
O, perlomeno, dovrà essere un altro Sanshiro, ben più consapevole di quello attuale.
 Poco tempo dopo arriva il momento di una tenzone importante, ma su un altro piano.
Poco tempo dopo arriva il momento di una tenzone importante, ma su un altro piano.
Gli allievi del Kodokan, in abiti civili, sono formalmente schierati all'interno del dojo, in posizione di seiza.
Attendono comunicazioni da parte del maestro.
 Yano sensei ha tra le mani una lettera sigillata.
Yano sensei ha tra le mani una lettera sigillata.
La apre e la legge ad alta voce, riservandosi di comunicare dopo la lettura la sua decisione.
Si tratta di una sfida ufficiale al Kodokan.
E ha deciso di accettarla.
 Il campione designato per affrontarla sarà Sanshiro Sugata.
Il campione designato per affrontarla sarà Sanshiro Sugata.
In realtà l'esito di queste sfide veniva stabilito attraverso lo svolgimento di un torneo a cui partecipavano 15 rappresentanti per scuola.
 Naturalmente era la scuola che riportava il maggior numero di affermazioni individuali ad essere dichiarata vincitrice della sfida.
Naturalmente era la scuola che riportava il maggior numero di affermazioni individuali ad essere dichiarata vincitrice della sfida.
Per accentuare la drammaticità della vicenda Kurosawa decide però non solo di farne un duello uomo contro uomo, ma anche di scindere in due episodi distinti quanto si dice sia successo nel torneo.
Non fu tra l'altro causato da una sfida, si trattava di una manifestazione ufficiale organizzata dal Dipartimento di Polizia Metropolitana di Tokyio.
Ma torniamo a questo - immaginario - scontro sostenuto da Sanshiro Sugata.
Il suo antagonista ha un aspetto temibile.
 Sul volto di Sanshiro traspare invece la tensione agonistica, ma senza alcuna traccia del furore e della mancanza di controllo che lo caratterizzavano fino a poco tempo prima.
Sul volto di Sanshiro traspare invece la tensione agonistica, ma senza alcuna traccia del furore e della mancanza di controllo che lo caratterizzavano fino a poco tempo prima.
E' veramente un altro Sanshito quello che si trova in quel momento sul tatami, ma dovrà imparare che anche nel momento del successo si può essere sconfitti nel modo più imprevisto e più assoluto, senza che si presenti alcuna possibilità di scampo.
 Il regista si sofferma su uno degli spettatori.
Il regista si sofferma su uno degli spettatori.
E' un volto relativamente poco noto all'epoca, ma che verrà immediatamente riconosciuto da chiunque ami il cinema di Kurosawa e quello giapponese in genere.
Takashi Shimura, qui nei panni del maestro di jujutsu Hansuke Murai, appare già in questa opera prima di Kurosawa. Non lo lascerà praticamente più fino alla morte, apparendo per l'ultima volta in Kagemusha.
Attore impareggiabile, capace di ricoprire ogni ruolo, dal protagonista assoluto alla "spalla" fino al personaggio di contorno, in grado di assumere l'aspetto di ogni fascia di età, di ogni fascia sociale, di simulare ogni carattere umano.
Ci viene qui presentato come un uomo abbastanza maturo, sebbene abbia all'epoca solamente 37 anni.
Tornerà presto nella vicenda, in un ruolo catartico.
 I due contendenti si affrontano senza darsi respiro. I combattimenti non prevedevano all'epoca limiti di tempo né interruzioni, tantomeno categorie di peso.
I due contendenti si affrontano senza darsi respiro. I combattimenti non prevedevano all'epoca limiti di tempo né interruzioni, tantomeno categorie di peso.
Sanshiro, più agile, si mantiene costantemente sulla difensiva ed elude i costanti attacchi dell'avversario.
Viene qui, nel combattimento immaginario, anticipato quanto le fonti storiche riportano avvenuto nel torneo della Polizia, la cui posta era l'appalto per l'addestramento alla difesa personale delle forze dell'ordine metropolitane.
 Tra il pubblico appare anche l'enigmatico damerino Igaki, seduto a fianco di Murai sensei.
Tra il pubblico appare anche l'enigmatico damerino Igaki, seduto a fianco di Murai sensei.
Il pubblico si agita, si alza in piedi.
Sanshiro improvvisamente ha preso l'iniziativa, è entrato nella guardia dell'avversario e sta per proiettarlo al suolo.
Kurosawa rinuncia a mostrare dettagliatamente le tecniche, le lascia solamente immaginare.
 L'attacco di Sanshiro è andato a segno.
L'attacco di Sanshiro è andato a segno.
Il suo avversario è stato proiettato a grande distanza, urtando rovinosamente contro il muro del dojo e rimanendo a terra esanime.
 Una folla muta è assiepata fuori dal dojo, dove hanno trovato posto solamente le autorità e gli addetti ai lavori.
Una folla muta è assiepata fuori dal dojo, dove hanno trovato posto solamente le autorità e gli addetti ai lavori.
Lo stupore è dipinto sugli occhi di tutti.
L'occhio dello spettatore cade invece inevitabilmente sulla donna è al centro del gruppo.
Apparentemente impassibile, quella donna ha la morte negli occhi e nel cuore.
 E' la figlia del campione sconfitto, e ha compreso immediatamente che la caduta è stata fatale: suo padre è morto nel combattimento.
E' la figlia del campione sconfitto, e ha compreso immediatamente che la caduta è stata fatale: suo padre è morto nel combattimento.
Sanshiro Sugata, anche senza averne minimamente avuto l'intenzione, anche mantenendo il suo sangue freddo e la sua serenità, ha ugualmente ucciso il suo avversario.
Si tratta in realtà di una diceria totalmente infondata, eppure a distanza di oltre un secolo dagli avvenimenti, il torneo si svolse nel 1886, continua a trovare credito in molti esperti.
Che Kurosawa l'abbia utilizzata per fini drammatici non deve però stupire né scandalizzare.
 Nel 1886 come già detto il Dipartimento di Polizia di Tokyo organizzò un torneo per selezionare la scuola di arti marziali destinata alla formazione dei poliziotti.
Nel 1886 come già detto il Dipartimento di Polizia di Tokyo organizzò un torneo per selezionare la scuola di arti marziali destinata alla formazione dei poliziotti.
Il prestigioso incarico avrebbe fatto la fortuna di qualunque scuola, e probabilmente furono molti i pretendenti e si dovette ricorrere a delle preselezioni.
La finale, al meglio di 15 combattimenti, si svolse tra il Kodokan, scuola centrale del nascente judo, e la branca -ha - Totsuka dello Yoshin ryu.
Jigoro Kano così parla del caposcuola:
Totsuka Hikosuke era considerato il più forte jujutsuka del periodo Bakumatsu [termine dello shogunato, che ebbe fine 18 anni prima del torneo]. Dopo Hirosuke, fu suo figlio Eimi a portare avanti il nome della scuola, formando numerosi jujutsuka di valore. Menzionando il nome Totsuka, ci si riferisce al più grande maestro di jujutsu dell'epoca. Gli stessi miei maestri delle scuole Tenshin Shinyo ryu e Kito ryu vivevano con tensione ogni confronto con i maestri del Totsuka jujutsu presso il dojo Komusho dello Shogunato.
Il nome esatto della scuola sembra sia stato Totsuka ha Yoshin koryu (antica scuola). Le origini del ramo principale si fanno risalire infatti al XVII secolo.
 E' presumibile che nel 1886 Hirosuke Totsuka avesse tra i 50 ed i 60 anni, e la partecipazione del caposcuola ad un torneo è inoltre estremamente improbabile, dobbiamo quindi concludere che Kurosawa abbia anche in questo caso forzato la realtà per adattarla alle necessità del racconto.
E' presumibile che nel 1886 Hirosuke Totsuka avesse tra i 50 ed i 60 anni, e la partecipazione del caposcuola ad un torneo è inoltre estremamente improbabile, dobbiamo quindi concludere che Kurosawa abbia anche in questo caso forzato la realtà per adattarla alle necessità del racconto.
In questa foto, risalente al 1906, vediamo Jigoro Kano (al centro, con il bastone) durante una riunione con i rappresentanti delle maggiori scuole di jujutsu.
Alla sua sinistra Hidemi Totsuka (trascritto come Eimi nel racconto di Kano), figlio di Hirosuke, che è chiaramente in età già avanzata.
 Prima di narrarci dell'epico scontro tra Sanshiro ed il maestro Hansuke Murai, il regista vuole darcene un breve ritratto.
Prima di narrarci dell'epico scontro tra Sanshiro ed il maestro Hansuke Murai, il regista vuole darcene un breve ritratto.
Tratteggerà poi anche le figure degi altri protagonisti della vicenda, sul tatami e fuori.
Murai è una persona amabile, per quanto sia temuto e rispettato sul tatami, e vive apparentemente solo con la figlia Sayo.
 Il suo migliore allievo è l'inappuntabile, gelido e violento Gennosuke Higaki.
Il suo migliore allievo è l'inappuntabile, gelido e violento Gennosuke Higaki.
Egli ha già deciso che impalmerà Sayo, senza soffermarsi a interpretare i reali desideri e le aspettative della ragazza, ritenendolo praticamente un atto dovuto.
Diventera così anche il successore di Murai alla testa della scuola.
 Il suo carattere viene efficacemente tratteggiiato da Kurosawa con un'unica sequenza, particolarmente efficace proprio in grazie della sua brevità e della sua apparente ininfluenza.
Il suo carattere viene efficacemente tratteggiiato da Kurosawa con un'unica sequenza, particolarmente efficace proprio in grazie della sua brevità e della sua apparente ininfluenza.
Mollemente adagiato in casa di Murai, Higaki getta con noncuranza la cenere della sigaretta sopra il magnifico fiore sistemato ad arte accanto a lui da Sayo.
 Sanshiro nel frattempo non trova pace al suo tormento interiore.
Sanshiro nel frattempo non trova pace al suo tormento interiore.
Si aggira senza una meta precisa per i quartieri di Tokyo, deserti e polverosi.
 Un cartello rotto dal vento, affisso ad un muro, acuisce il suo dolore.
Un cartello rotto dal vento, affisso ad un muro, acuisce il suo dolore.
E' la casa dove risiedeva l'uomo da lui ucciso in combattimento, ed il cartello informa che la casa è in affitto.
La figlia, il cui volto pietrificato continua a riaffacciarsi agli occhi di Sanshiro, vede spezzata la sua vita sia negli affetti che nella quotidianità.
 Sayo e Sanshiro sono destinati ad incontrarsi presto, in circostanze drammatiche.
Sayo e Sanshiro sono destinati ad incontrarsi presto, in circostanze drammatiche.
La ragazza si aggira nei precinti di un tempio, evidentemente vicino al Kodokan visto che il prete Osho ed uno dei discepoli si trovano là, e con l'aria di chi è di casa.
Sayo ha un'aria strana, e chiede incessantemente di Sanshiro: insospettiti i due la perquisiscono.
Ha un pugnale nascosto tra le vesti, intendeva uccidere Sanshiro per evitare al padre il pericoloso combattimento contro un uomo che ha già ucciso.
 Poco dopo arriverà lo stesso Sanshiro, accompagnando il maestro Yano.
Poco dopo arriverà lo stesso Sanshiro, accompagnando il maestro Yano.
Questa sequenza, apparentemente senza particolare importanza, è una pietra miliare nella storia del cinema: è infatti la prima in assoluto girata da Akira Kurosawa come regista.
Racconta di essersi sentito osservato con stupore dall'intero staff quando, con voce che tentava di rendere normale, gridò "Yoi, staato!" (Pronti, start!). La sua tensione traspariva, ma era già scomparsa nel girare la seconda scena.
 E' quella in cui Sayo, evidentemente redarguita ma senza prendere alcun provvedimento concreto contro di lei, è ancora al tempio e sta pregando per la salvezza di suo padre.
E' quella in cui Sayo, evidentemente redarguita ma senza prendere alcun provvedimento concreto contro di lei, è ancora al tempio e sta pregando per la salvezza di suo padre.
L'attrice, Yukiko Todoroki, chiese a Kurosawa se dovesse semplicemente pregare per la vittoria del padre. Si sentì rispondere di pregare anche, già che c'era, per la riuscita del film.
 Ignari dell'antefatto Yano e Sanshiro ammirano la classica e composta bellezza di Sayo, ma non si avvicinano per non disturbarne il raccoglimento.
Ignari dell'antefatto Yano e Sanshiro ammirano la classica e composta bellezza di Sayo, ma non si avvicinano per non disturbarne il raccoglimento.
 I due giovani si incontreranno qualche giorno dopo lungo la scalinata di accesso.
I due giovani si incontreranno qualche giorno dopo lungo la scalinata di accesso.
Sayo ha avuto un piccolo incidente, uno dei suoi zoccoli si è rotto e Sanshiro interviene gentilmente per una riparazione di emergenza.
 E' un incontro fortuito che sembra destinato a non avere seguito, nessuno dei due pensa a presentarsi.
E' un incontro fortuito che sembra destinato a non avere seguito, nessuno dei due pensa a presentarsi.
Eppure tra di loro nasce spontaneamente una naturale attrazione, e prendono l'abitudine di incontrarsi spesso lungo la scalinata, sempre ignorando ogni cosa l'uno dell'altra.
E' Sayo in un momento in cui desidera aprirsi a rivelare che le sue frequenti visite al tempio sono motivate dall'apprensione per la sorte del padre: lei viene per implorare la vittoria per lui, e la sconfitta per Sanshiro Sugata.
 Improvvisamente la distanza tra i due, che sembrava doversi annullare, diventa siderale.
Improvvisamente la distanza tra i due, che sembrava doversi annullare, diventa siderale.
Sanshiro, con la morte nel cuore, rivela la sua identità.
 Lascia su quella scalinata, assieme all'ombrello da lui dimenticato, i suoi sogni infranti prima ancora di cominciare a sbocciare.
Lascia su quella scalinata, assieme all'ombrello da lui dimenticato, i suoi sogni infranti prima ancora di cominciare a sbocciare.
La sequenza, definita sbrigativamente "scena d'amore", fu una di quelle più bersagliate dalla commissione di censura, che imputò a Kurosawa di avervi seguito una ispirazione smaccatamente "anglo-americana".
Per la verità sembra una scena, oltre che delicata, ispirata ad allusioni culturali squisitamente giapponesi, come il sottile gioco degli ombrelli dietro cui ci celano e si rivelano i due protagonisti.
 Nella caldissima estate del 1886, a 20 anni, Sugata Sanshiro è il campione designato dal maestro Yano per affrontare l'importante prova che potrebbe cambiare il destino della giovane scuola, nata da appena 4 anni.
Nella caldissima estate del 1886, a 20 anni, Sugata Sanshiro è il campione designato dal maestro Yano per affrontare l'importante prova che potrebbe cambiare il destino della giovane scuola, nata da appena 4 anni.
La vigilia è tormentata, densa di dubbi.
Con il suo modo burbero ma diretto il monaco Osho affronta Sanshiro e lo incita ad abbandonare ogni esitazione, dimostrandosi degno della fiducia accordatagli ed uomo maturo capace di dominare non solo la propria forza fisica ma anche i suoi sentimenti.
 Il momento è arrivato: al'interno della sala - affollata da importanti personaggi - si respira a fatica per la calura.
Il momento è arrivato: al'interno della sala - affollata da importanti personaggi - si respira a fatica per la calura.
Un ufficiale della polizia dirige l'incontro.
L'ambiente e la tensione sono tali da intimorire chiunque.
 Tutti tranne Shagoro Yano.
Tutti tranne Shagoro Yano.
Imperturbabile, sembra che stia attendendo l'inizio di una noiosa conferenza invece che l'esito di un confronto dal quale dipendono le sorti di due scuole di arti marziali.
Una antichissima, contando 2 secoli di storia, una ancora nascente.
 La tensione di Sanshiro viene fortunatamente allentata da un buffo incidente.
La tensione di Sanshiro viene fortunatamente allentata da un buffo incidente.
Mentre si sta mettendo in posizione di seiza per salutare il suo antagonista, il suo keikogi, già lacero dopo anni ed anni di intenso allenamento, cede.
Un vistoso strappo si apre all'altezza del ginocchio sinistro.
 Hansuke Murai, persona come abbiamo detto amabile e tendente al sorriso, ne è divertito.
Hansuke Murai, persona come abbiamo detto amabile e tendente al sorriso, ne è divertito.
 Anche Sanshiro Sugata è contagiato da quell'imprevisto momento di allegria e spensieratezza.
Anche Sanshiro Sugata è contagiato da quell'imprevisto momento di allegria e spensieratezza.
Improvvisa, inattesa, una forte corrente di simpatia si sprigiona e corre tra i due irriducibili avversari.
 Non per questo il combattimento è meno intenso. Le cronache, non si sa fino a che punto influenzate dal romanzo di Tsuneo Tomita, raccontano di un atteggiamento difensivo da parte di Shiro Saigo, che prevalse infine con la sua tecnica favorita, lo yamarashi (tempesta sulla montagna).
Non per questo il combattimento è meno intenso. Le cronache, non si sa fino a che punto influenzate dal romanzo di Tsuneo Tomita, raccontano di un atteggiamento difensivo da parte di Shiro Saigo, che prevalse infine con la sua tecnica favorita, lo yamarashi (tempesta sulla montagna).
E' un tecnica presente nel primo gokyo (gruppo di 5 tecniche di base) del Kodokan pubblicato a fine 800, e sembra analoga a questa che vediamo tentare nella finzione da Hansuke Murai.
Forse una deliberata citazione di Kurosawa.
Col tempo lo yamarashi divenne nella fantasia di molti una tecnica leggendaria perduta nel tempo.
Alcuni la ricostruirono immaginandola come una sorta di koshinage di aikido, mentre altri sostennero trattarsi di una variazione di shihonage, proveniente dal bagaglio del Daito ryu aikijujutsu di Aizu (regione da cui proveniva Shiro Saigo), cui ha attinto anche l'aikido.
Non esiste alcuna prova in proposito, e i più autorevoli studiosi negano concordi tale ipotesi. Sembra accertato comunque che nel metodo Kodokan il maestro Jigoro Kano privilegiò lo studio delle tecniche dimostratesi maggiormente efficaci e che preservassero i praticanti dagli infortuni. Una eccessiva varietà di scelta rallentava infatti i processi decisionali del combattente e "annacquava" la pratica ostacolando l'approfondimento intensivo, mentre i numerosi infortuni mettevano spesso i praticanti nell'obbligo di interrompere gli allenamenti.
 Hansuke Murai conduce l'incontro tentando in continuazione di atterrare Sanshiro (ci si perdonino questi continui passaggi dai personaggi reali a quelli immaginari).
Hansuke Murai conduce l'incontro tentando in continuazione di atterrare Sanshiro (ci si perdonino questi continui passaggi dai personaggi reali a quelli immaginari).
La leggenda, il romanzo ed il film vogliono che Sanshiro sia rimasto sulla difensiva, atterrando miracolosamente in piedi - agile come un gatto - anche quando la proiezione sembrava inevitabilmente riuscita facendo marcare a Murai ippon (un punto).
 Come già detto gli incontri non prevedevano intervalli.
Come già detto gli incontri non prevedevano intervalli.
Dopo numerosi minuti di corpo a corpo entrambi i contendenti, in un ambiente surriscaldato dove boccheggia anche il pubblico, sembrano quasi allo stremo.
Entrambi hanno bisogno di rifiatare.
 Ed è proprio in quel momento che Sanshiro trova dentro di sé la volontà di superare ogni limite, e passa all'attacco con grande determinazione.
Ed è proprio in quel momento che Sanshiro trova dentro di sé la volontà di superare ogni limite, e passa all'attacco con grande determinazione.
Murai viene più volte atterrato e proiettato a grande distanza. Kurosawa come di consueto accenna solamente a mostrare le tecniche, lasciando immaginare allo spettatore quanto non visibile.
 Murai si rialza ogni volta, finché un'ultima energica proiezione lo lascia al suolo senza che possa più rialzarsi.
Murai si rialza ogni volta, finché un'ultima energica proiezione lo lascia al suolo senza che possa più rialzarsi.
 Il pubblico comprende che è finita.
Il pubblico comprende che è finita.
Finiva con quella sfida, ripetiamo che si trattò di un torneo a squadre e non di un duello individuale, anche un'epoca: quella del jujutsu.
Iniziava l'epoca del judo e delle nuove arti marziali, più sistemi di formazione dell'individuo, nelle sue componenti mentali e fisiche, che metodi di combattimento.
Eppure per affermarsi dovettero dimostrare la loro superiorità anche sul campo.
Non si pensi tuttavia ad una frattura inconciliabile tra i due mondi; lo dimostra anche la foto già motrata, scattata a 20 anni di distanza, in cui Jigoro Kano e Hidemi Totsuka sono fianco a fianco, nella commissione incaricata di stabilire i kata di approfondimento da introdurre nel judo.
 Sono Yano e Sanshiro i primi a correre in soccorso di Murai, che anche dopo essersi dichiarato sconfitto non sembra in grado di riprendersi
Sono Yano e Sanshiro i primi a correre in soccorso di Murai, che anche dopo essersi dichiarato sconfitto non sembra in grado di riprendersi
 La folla festante attornia Sanshiro.
La folla festante attornia Sanshiro.
Ma lui non riesce a gioire, lo tormenta il pensiero che un'altra donna, e verso la quale prova dei sentimenti ancora indecifrabili ma forti, deve ancora soffrire a causa sua.
 Siamo ora nella dimora di Hansuke Murai.
Siamo ora nella dimora di Hansuke Murai.
Non si è ancora ripreso del tutto dopo il combattimento, ma sembra sereno.
Si sta concendo una tirata con la pipa, che gli viene porta accesa da qualcuno accanto a lui.
 E' Sanshiro Sugata.
E' Sanshiro Sugata.
Ha chiesto il permesso di rendere visita al suo ex avversario, ed è stato ricevuto con grande cortesia, anzi addirittura con una punta di affetto.
 Anche Sayo partecipa all'accoglienza di Sanshiro.
Anche Sayo partecipa all'accoglienza di Sanshiro.
La scena è idilliaca e sembra preludere ad un necessario lieto fine convenzionale.
 Che non ci sarà: non ora almeno. Gennosuke Higaki si presenta come suo solito, senza preavviso, nella casa del maestro.
Che non ci sarà: non ora almeno. Gennosuke Higaki si presenta come suo solito, senza preavviso, nella casa del maestro.
Una sola occhiata gli è sufficiente per comprendere quanto sta succedendo: è irrimediabilmente sconfitto in modo umiliante, davanti al suo maestro e a quella che considerava già la sua donna.
 La sua lettera di sfida a Sanshiro non tarderà.
La sua lettera di sfida a Sanshiro non tarderà.
E dovrà essere un combattimento senza alcun limite.
 La sfida si svolge in una brughiera di montagna squassata dal vento.
La sfida si svolge in una brughiera di montagna squassata dal vento.
Il sole sta cedendo a nuvole minacciose: anche la natura sembra volersi adeguare alla tempestosità degli uomini.
Ottenuto il permesso di girare all'aperto invece che in uno studio di produzione, Kurosawa aveva ricercato a lungo un luogo adatto, scegliendo infine l'altopiano di Sengokuhara, ma era inaspettamente capitato in un periodo di mancanza di vento.
La produzione aveva posto la condizione di terminare le riprese entro tre giorni, ma solo sul finire del terzo si levò il vento. Kurosawa e il suo gruppo lavorarono come ossessi per sfruttare l'irripetibile occasione.
La ricerca come scenario dei fenomeni della natura fu una costante nella produzione successiva di Kurosawa, delizia per gli spettatori e croce per i produttori, che dovettero spesso sopportare la dilatazione dei tempi di lavorazione - la natura ha i suoi tempi - e di conseguenza delle spese di produzione.
 E' il maestro Saburo Kodama ad arbitrare l'incontro, cui assiste un testimone per parte.
E' il maestro Saburo Kodama ad arbitrare l'incontro, cui assiste un testimone per parte.
 Sono di fronte due antagonisti che erano destinati in un modo o nell'altro a doversi affrontare, rappresentanti di due modi diversi di intendere il mondo e l'arte.
Sono di fronte due antagonisti che erano destinati in un modo o nell'altro a doversi affrontare, rappresentanti di due modi diversi di intendere il mondo e l'arte.
Non vi può essere, non vi potrà mai essere spazio per entrambi.
Sugata Sanshiro e Gennosuke Higaki sono l' uno di fronte all'altro nel momento della verità.
 Higaki è animato da una furia cieca, ha bisogno di sfogare ogni sua frustazione, e la causa di ogni suo male è lì, di fronte a lui.
Higaki è animato da una furia cieca, ha bisogno di sfogare ogni sua frustazione, e la causa di ogni suo male è lì, di fronte a lui.
E' difficile resistergli, certamente la vittoria gli è necessaria, molto più di quanto.possa esserlo per Sugata.
Paradossalmente quello che è stato un punto di arrivo faticosamente conquistato dopo averlo a lungo cercato, si rivela per Sanshiro un pericoloso punto debole.
Higaki afferra la gola di Sanshiro stringendolo in una morsa, tentando un kubishime (strangolamento)
 Sanshiro sta per soccombere, per lasciarsi andare.
Sanshiro sta per soccombere, per lasciarsi andare.
L'ultima visione che rimarrebbe nelle sue pupille è quella del cielo tempestoso in cui si svolge il duello.
 Improvvisamente, in quel momento, gli torna l'immagine della ninfea che si schiude di fronte a lui in quel gelido mattino, nello stagno del dojo in cui era immerso.
Improvvisamente, in quel momento, gli torna l'immagine della ninfea che si schiude di fronte a lui in quel gelido mattino, nello stagno del dojo in cui era immerso.
Ritrova di nuovo il satori, l'armonia con l'universo, e con quello la forza di combattere ancora.
 Sottrattosi alla morsa di Higaki, lo afferra a sua volta e lo proietta a grande distanza.
Sottrattosi alla morsa di Higaki, lo afferra a sua volta e lo proietta a grande distanza.
Il corpo di Higaki scivola giù per la scarpata, mentre lui è annientato, incapace di ogni reazione.
Invano implora di ucciderlo.
 Oramai tutto è finito.
Oramai tutto è finito.
Sono riuniti nel dojo Shagoro Yano, Saburo Kodama ed il reverendo Osho, visibilmente soddisfatti.
La vita di Sanshiro sembra aver preso la piega da tutti auspicata.
E' solo un lontano ricordo quella notte di tempesta nel cielo e nell'animo di Sanshiro, immerso in quello stagno che vedono fuori della veranda.
Sanshiro non c'è: è in viaggio.
 Non ne vengono precisate le ragioni, ma intuiamo che si tratta di un viaggio abbastanza lungo, che lo porterà lontano per qualche tempo e darà inizio ad una nuova fase della sua vita.
Non ne vengono precisate le ragioni, ma intuiamo che si tratta di un viaggio abbastanza lungo, che lo porterà lontano per qualche tempo e darà inizio ad una nuova fase della sua vita.
Lo accompagna per un tratto Sayo.
Sanshiro rimane sulle sue, non sa bene cosa dirle e come.
 Viene in suo soccorso un altro provvidenziale piccolo incidente.
Viene in suo soccorso un altro provvidenziale piccolo incidente.
O è forse una innocente malizia di Sayo.
Una di quelle malizie di cui fortunatamente ogni donna sa fare buon uso.
Qualcosa le è entrato nell'occhio: potrebbe Sanshiro essere così gentile da aiutarla?
 L'ultima inquadratura di Kurosawa è dedicata alla buffa piccola locomotiva che porta i due giovani verso il percorso della vita.
L'ultima inquadratura di Kurosawa è dedicata alla buffa piccola locomotiva che porta i due giovani verso il percorso della vita.
Si chiude qui l'opera prima di Akira Kurosawa.
Non sappiamo in realtà come abbia condotto la sua vita Shiro Saigo, il personaggio storico cui si ispira Sanshiro Sugata.
Sappiamo che 4 anni dopo il torneo contro il Totsuka Yoshin ryu, nel 1890, mentre era all'apice della fama e nel pieno delle forze, abbandonò il Kodokan per non farvi più ritorno. Le cause sono ignote, e apparentemente sconosciute allo stesso Jigoro Kano che in quel momento si trovava in viaggio.
Shiro Saigo si spense nel 1922 nella terra di Aizu dove era nato. Jigoro Kano scomparve a bordo della nave che lo riportava in Giappone nel 1938. Tornava dall'avere ottenuto l'inserimento del judo nel programma dei Giochi Olimpici, ma la guerra rimandò al 1964 la realizzazione di questo suo sogno.
Perseguì per tutta la vita lo scopo di realizzare il wako yosaii, il principale obiettivo delle menti più illuminate del Giappone durante l'epoca Meiji: accettare la tecnologia occidentale, ma mantenere integro lo spirito del Giappone.
 Nagisa Oshima: Gohatto
Nagisa Oshima: Gohatto
1999
Takeshi Kitano, Ryuhei Matsuda, Asano Tadanobu, Shinji Takeda
Nagisa Oshima (1932-2013) è conosciuto in occidente soprattutto, se non esclusivamente per tre opere: L'impero dei sensi (1975), Furyo (1983), e infine Gohatto (1999) conosciuto anche con il titolo di Tabu e che fu il suo canto del cigno. Certamente non a caso, sono quelle che hanno maggiore fama di opere erotiche. Ma non sempre a ragione. In realtà la sua produzione è stata imponente, anche come documentarista, ma di questo poco o nulla ci è pervenuto finora. Cresciuto all'ombra dei maestri del dopoguerra - fu assistente di Masaki Kobayashi - scelse tuttavia di prendere una strada diversa da tutte le altre, abbandonando molti stilemi per lasciare una sua impronta personale, ben riconoscibile in ogni opera.
La sua attenzione ai temi ed ai problemi della sessualità è esplicita in L'impero dei sensi - che lo fece conoscere in Europa ammantandolo però di una fama immeritata di voyeur - e nell'altra opera L'impero della passione (1978) che ne è in un certo senso il contrappeso. Mentre la prima opera è ambientata nell'anteguerra quindi in epoca Showa ed appartiene di conseguenza al genere gendai, l'altra ha una collocazione jidai, nell'epoca anteriore Meiji. E' rimasta praticamente sconosciuta fuori dal Giappone, forse perché tratta di una società ignota al mondo occidentale, che del Giappone classico conosce - crede di conoscere - solo le figure del "samurai" e della "geisha".
Sul finire del secolo XX Oshima, dopo un lungo silenzio, ha trattato in Gohatto il tema dell'attrazione omosessuale, che era rimasto latente nell'altra opera Furyo, risalente al 1983 e ad ambientazione moderna. Preceduto da intense discussioni anche questo film è apparso ai più un ennesimo ritorno del regista ai suoi temi fissi. Le fonti di ispirazione di Oshima andrebbero in realtà approfondite. Nel caso dell'Impero dei sensi ad esempio si è molto discusso sulla morbosità della trama, attribuendogliene le responsabilità. Si trattava invece della messa in scena di un fatto realmente verificatosi, e che aveva fatto scalpore in Giappone.
Anche la trama di Gohatto, derivata da un romanzo di Ryōtarō Shiba (1923-1996), ha origini e motivazioni che devono essere conosciute. L'attrazione verso la figura dell'adolescente ha radici remote nella cultura giapponese, con vaste risonanze anche nella cultura popolare d'oggi. Il bishōnen è infatti un personaggio maschile cui vengono attribuite fattezze androgine ed un fascino che ha presa indifferentemente su uomini e donne, anche se non necessariamente con risvolti di attrazione sessuale.
 Tra i personaggi storici che vengono tradizionalmente raffigurati come bishōnen ricordiamo il principe Minamoto no Yoshitsune (1159 - 1189), intrepido guerriero e vincitore dei Taira nella grande battaglia navale di Dannoura, e il ribelle cristiano Amakusa Shiro Tokisada (1621-1638), protagonista durante la "Rivolta di Shimabara" della strenua difesa del castello di Hara, situato nell'estremo sud del Giappone nell'isola di Kyushu, e giustiziato immediatamente dopo la caduta della fortezza.
Tra i personaggi storici che vengono tradizionalmente raffigurati come bishōnen ricordiamo il principe Minamoto no Yoshitsune (1159 - 1189), intrepido guerriero e vincitore dei Taira nella grande battaglia navale di Dannoura, e il ribelle cristiano Amakusa Shiro Tokisada (1621-1638), protagonista durante la "Rivolta di Shimabara" della strenua difesa del castello di Hara, situato nell'estremo sud del Giappone nell'isola di Kyushu, e giustiziato immediatamente dopo la caduta della fortezza.
Lo stesso AKira Kurosawa ha apparentato alcuni suoi personaggi alla figura del bishōnen: erano visibilmente tali sia il principe Yoshitsune - appunto - in Tora no ofumu otokotachi che lo sventurato Tsurumaru in Ran.
 A parte questi personaggi leggendari o letterari, raffigurati un tempo nelle stampe e al giorno d'oggi nei manga (a lato una rappresentazione moderna di Amakusa Shiro), è esistita in Giappone come in altre società antiche - basti citare quella dell'antica Grecia - una tradizione omosessuale formale.
A parte questi personaggi leggendari o letterari, raffigurati un tempo nelle stampe e al giorno d'oggi nei manga (a lato una rappresentazione moderna di Amakusa Shiro), è esistita in Giappone come in altre società antiche - basti citare quella dell'antica Grecia - una tradizione omosessuale formale.
Veniva definita wakashūdo (via dell'attrazione per il giovane), spesso abbreviata in shūdo la particolare simbiosi omosessuale esistente in deteminati ambienti marziali tra una figura dominante di guerriero ed il suo adepto in età pre adulta, verso il quale adempiva a compiti di formazione e di introduzione al passaggio tra gli adulti. Oltrepassata la soglia il wakashu di norma considerava chiusa questa parentesi della sua vita e le regole sociali gli imponevano di assumere a sua volta, eventualmente, la parte del nenja, la figura dominante.
Le prime avvisaglie di un mutamento nei confronti di queste tradizioni si ha solamente in epoca Meiji, quando venne emanato nel 1873 un provvedimento di legge che colpiva l'omosessualità, ritirato tuttavia nel 1880 quando venne emanato il Codice Penale definitivo ispirato a quello napoleonico. Oshima ambienta l'opera in epoca immediatamente precedente, ossia nel 1865. I protagonisti sono membri o aspiranti tali della Shinsengumi, la milizia irregolare fedele allo Shogun (Governatore militare) che agiva a Kyoto con tattiche di guerriglia contro gli analoghi gruppi fedeli al Tenno (Imperatore). Ne abbiamo già parlato altrove. Il titolo Gohatto allude alle 5 leggi fondamentali del codice di comportamento Shinsengumi.
 Oshima ricorre ad Asano Tadanobu per la parte del rozzo Tashiro Hyozo e a Ryûhei Matsuda per quella del giovanissimo, ambiguo ed inquietante Sozaburo Kano.
Oshima ricorre ad Asano Tadanobu per la parte del rozzo Tashiro Hyozo e a Ryûhei Matsuda per quella del giovanissimo, ambiguo ed inquietante Sozaburo Kano.
Era la prima interpretazione di Matsuda, divenuto in seguito apprezzato attore, ed era ancora più giovane del suo personaggio, dichiarato diciottenne. Al momento delle riprese Matsuda aveva invece solamente 15 anni.
Deus ex macchina e voce narrante nella vicenda è l'ufficiale Toshizo Hijikata , impersonato da Takeshi Kitano. Le musiche sono di Ryuichi Sakamoto, che fu interprete principale di Furyo come antagonista di David Bowie.
 I film o i romanzi che trattano della breve quanto sanguinosa epopea dello Shinsengumi iniziano spesso in medias res, con il reclutamento dei miliziani mediante prove di combattimento alla spada.
I film o i romanzi che trattano della breve quanto sanguinosa epopea dello Shinsengumi iniziano spesso in medias res, con il reclutamento dei miliziani mediante prove di combattimento alla spada.
Oshima non si sottrae a questa regola: all'interno del dojô il comandante Isami Kondo ed il suo luogotenente Toshizō Hijikata (Takeshi Kitano) assistono impassibili.
Si tratta di due personaggi storici. Lo Shinsengumi (Nuovo Gruppo Scelto) nacque come corpo irregolare al servizio dello shogun nel 1863 dalle ceneri di un precedente gruppo denominato Rōshigumi, e si divise ben presto in diverse fazioni. La maggiore, che prese poi il sopravvento sulle altre, era quella comandata da Isami Kondo. ll loro scopo era soprattutto quello di contrastare le azioni di analoghi gruppi irregolari al servizio dell'imperatore, che avevano portato a compimento numerosi attentati. Dopo la sconfitta definitiva delle forze fedeli allo shogun Kondo venne catturato e condannato a morte per l'omicidio del leggendario riformista Ryoma Sakamoto. E' anche questo un indicatore delle contraddizioni di quell'epoca travagliata: formalmente lo Shinsengumi, appoggiando la politica innovatrice dello shogun, andrebbe considerato un gruppo estremista certamente, ma anchesso "riforrnista".
Lo Shinsengumi adottava diverse uniformi, di solito di colore blu, contrassegnate dal profilo di due monti stilizzati in bianco sui baveri dell'aori. Il gohatto, il regolamento che ogni membro dello Shinsengumi si impegnava ad onorare, constava come anticipato di 5 regole. Sarebbe in realtà più corretto parlare di cinque divieti categorici.
Deviare dal codice samurai
Abbandonare lo Shinsengumi
Raccogliere denaro
Partecipare a conflitti tra estranei
Combattere per ragioni private
La pena era l'obblgo del seppuku, o l'esecuzione capitale per chi venisse ritenuto indegno di una morte onorevole. Erano inoltre richiesto mediante giuramento di continuare a combattere fino alla morte in caso di uccisione del proprio comandante, e di abbandonare sul posto i corpi dei propri caduti, sempre eccezione fatta per il comandante.
 Toshizō Hijikata (1835 - 1869) era noto per la sua intransigenza nell'esigere il rispetto delle regole e per la fermezza con cui reprimeva i non infrequenti episodi in cui dei membri della milizia abusavano del loro potere di fatto. Dopo la morte di Kondo raggiunse gli ultimi focolai della resistenza, deciso a testimoniare con la morte in battaglia non solo la sua fedeltà personale allo shogun ma anche quella di tutti i samurai che avevano prestato giuramento. Cadde in combattimento, colpito da una pallottola mentre a cavallo caricava il nemico, il 20 giugno 1869.
Toshizō Hijikata (1835 - 1869) era noto per la sua intransigenza nell'esigere il rispetto delle regole e per la fermezza con cui reprimeva i non infrequenti episodi in cui dei membri della milizia abusavano del loro potere di fatto. Dopo la morte di Kondo raggiunse gli ultimi focolai della resistenza, deciso a testimoniare con la morte in battaglia non solo la sua fedeltà personale allo shogun ma anche quella di tutti i samurai che avevano prestato giuramento. Cadde in combattimento, colpito da una pallottola mentre a cavallo caricava il nemico, il 20 giugno 1869.
E' divenuto anche lui un personaggio leggendario e al giorno d'oggi protagonista degli immancabili manga.
Nelle illustrazioni dei fumetti e nei costumi dei cosplay, adolescenti che amano travestirsi nei loro personaggi preferiti, anche Hijikata viene generalmente rappresentato come un bishōnen, e indossa costumi fantasiosi e sgargianti.
Nonostante avesse nel 1865 appena 30 anni Oshima lo dipinge come un uomo maturo, tendente alla riflessione, più moderato di quanto sembra essere stato nella realtà.
 E' il capitano del primo gruppo di combattimento, Sôji Okita (Rinji Takeda, a sinistra), a mettere alla prova di persona i volontari. Solo due emergono dalla massa. Tra di loro l'irruento Tashiro Hyozo (Asano Tadanobu), dalla tecnica non eccezionale ma irriducibile, ed il giovanissimo efebico Sozaburo Kano.
E' il capitano del primo gruppo di combattimento, Sôji Okita (Rinji Takeda, a sinistra), a mettere alla prova di persona i volontari. Solo due emergono dalla massa. Tra di loro l'irruento Tashiro Hyozo (Asano Tadanobu), dalla tecnica non eccezionale ma irriducibile, ed il giovanissimo efebico Sozaburo Kano.
Sôji Okita (1844-1868) era noto per le sue capacità di guerriero. Rimasto orfano appena nato, entrò nell'orbita della famiglia Kondo, che era depositaria della scuola di spada Tennen Rishin ryu. Divenne già a 18 anni detentore di una certificazione menkyo kaiden e fu nella cerchia del Tennen ryu che conobbe Isami Kondo e Toshizō Hijikata, seguendoli nella avventura dello Shinsengumi.
 Apparentemente destinato ad un futuro di insegnamento, poiché Isami Kondo lo aveva designato come suo successore a doshu del Tennen ryu, Okita si spense prematuramente poco dopo l'esito della guerra Boshin (1868-69) in cui le forze imperiali sconfissero quelle shogunali. Era affetto da tubercolosi, all'epoca una malattia che mieteva numerose vittime.
Apparentemente destinato ad un futuro di insegnamento, poiché Isami Kondo lo aveva designato come suo successore a doshu del Tennen ryu, Okita si spense prematuramente poco dopo l'esito della guerra Boshin (1868-69) in cui le forze imperiali sconfissero quelle shogunali. Era affetto da tubercolosi, all'epoca una malattia che mieteva numerose vittime.
E' anche lui uno dei personaggi che ha fortemente colpito l'immaginazione sia degli artisti che di giovanissimi cosplay: la sua immagine, più o meno deformata, è sempre più viva nella cultura popolare.
 Per quanto sconfitti agevolmente da Okita sia Kano che Hyozo hanno mostrato sufficiente talento.
Per quanto sconfitti agevolmente da Okita sia Kano che Hyozo hanno mostrato sufficiente talento.
Sono i soli ad avere superato la prova di ammissione e vengono portati al cospetto di Isami Kondo (Yôichi Sai) per l'accettazione formale nello Shinswengumi.
Da questo momento sono vincolati da giuramento al rispetto del gohatto.
 Le due nuove reclute sono destinate fin dall'inizio ad avere un rapporto intenso e pieno di contraddizioni. Tashiro proviene da una famiglia modesta, forse per questo è molto determinato nel suo tentativo di scalata sociale attraverso l'arruolamento.
Le due nuove reclute sono destinate fin dall'inizio ad avere un rapporto intenso e pieno di contraddizioni. Tashiro proviene da una famiglia modesta, forse per questo è molto determinato nel suo tentativo di scalata sociale attraverso l'arruolamento.
Ha la sensazione che Sozaburo, figlio di facoltosi mercanti che intende ritornare samurai, venga ingiustamente favorito a suo discapito.
In realtà delle ragioni per privilegiare il giovanissimo Sozaburo ci sono.
 E' lui che viene prescelto per essere messo subito alla prova: dovrà eseguire la condanna capitale di un miliziano che ha infranto il gohatto chiedendo del denaro in prestito.
E' lui che viene prescelto per essere messo subito alla prova: dovrà eseguire la condanna capitale di un miliziano che ha infranto il gohatto chiedendo del denaro in prestito.
Sozaburo quando gli è stato chiesto da Tashiro perché si sia arruolato si era trincerato dietro un enigmatico sorriso. Lo rivelerà più tardi ad altri: è stato attratto dalla possiblità di uccidere impunemente.
Non ha quindi alcuna difficoltà a decapitare ritualmente il colpevole, presentando impassibile la sua testa ai comandanti dello Shinsengumi come prescritto dal cerimoniale.
Hijikata non ha alcun dubbio: l'atteggiamento del ragazzo è quello di chi ha già ucciso. Sarà un combattente temibile
 Tashiro è invece talmente incontrollato da venir imprigionato per la sua irruzione di protesta durante la cerimonia. Durante la prigionia non ha fatto altro che pensare a Sozaburo.
Tashiro è invece talmente incontrollato da venir imprigionato per la sua irruzione di protesta durante la cerimonia. Durante la prigionia non ha fatto altro che pensare a Sozaburo.
Non resiste a dichiarargli la sua passione.
Che non sembra corrisposta. Sozaburo appare anzi deciso a resistere ad ogni costo a Tashiro, difendendosi anche con le armi, da cui non si separa mai.
 L'ultima vana resistenza prima di cedere al proprio irrefrenabile istinto? Forse piuttosto un metodo freddamente calcolato per rendersi più prezioso.
L'ultima vana resistenza prima di cedere al proprio irrefrenabile istinto? Forse piuttosto un metodo freddamente calcolato per rendersi più prezioso.
Hijikata di lì a poco non avrà alcun dubbio: i due sono diventati amanti.
Durante i combattimenti Tashiro, dalla tecnica rozza per quanto efficace, mette chiaramente in soggezione Sozaburo, ben più preparato tecnicamente e naturalmente predisposto all'arte della spada.
 E' solo l'inizio della scalata del potere da parte di Sozaburo.
E' solo l'inizio della scalata del potere da parte di Sozaburo.
Si rende certamente conto che al di là del potere formale determinato dalle gerarchie, esiste un potere di fatto che gli permetterà di dominare chi vuole.
Non romperà mai definitivamente il rapporto con Tashiro, ma non esiterà a rendersi disponibile alle attenzioni di altri, mantenendosi sempre in bilico - e non sappiamo quanto attribuire al suo carattere e quanto al calcolo premeditato - tra la provocazione e l'atteggiamento succube di chi deve cedere alla violenza altrui.
 I suoi amanti non possono fare a meno di nutrire sentimenti di rivalsa nei suoi confronti, quando si rendono conto di essere in realtà schiavi della persona che pensavano di dominare.
I suoi amanti non possono fare a meno di nutrire sentimenti di rivalsa nei suoi confronti, quando si rendono conto di essere in realtà schiavi della persona che pensavano di dominare.
Tojiro Yuzawa, caduto nella rete mentre pensava di essere il predatore, è tentato di uccidere Sozaburo, anche nei momenti di passione più intensa.
Del resto - Nagisa lo fa dire agli ufficiali dello Shinsengumi riuniti a rapporto - in periodi in cui si liberano potenti passioni politiche è inevitabile l'emergere anche di quelle personali.
 Sozaburo mira però più in alto, per i suoi piani - qualunque essi siano - non gli basta sicuramente appoggiarsi ad un semplice miliziano.
Sozaburo mira però più in alto, per i suoi piani - qualunque essi siano - non gli basta sicuramente appoggiarsi ad un semplice miliziano.
Incontra casualmente il capitano Genzaburō Inoue, comandante del sesto reparto. Sarà lui la sua prossima "tappa".
Anche questo personaggio viene rappresentato da Oshima, come le altre figure storiche, in modo difforme dalla realtà ma più aderente alle necessità della trama.
Sozaburo, che lo ha incontrato per la prima volta mentre era in borghese, lo descrive come un uomo di circa 60 anni, ma viene informato che in realtà ne ha circa 45, per quanto portati male, e che è un adepto del Tennen Rishin ryu, dove viene considerato tuttavia buon elemento di supporto per l'organizzazione della scuola ma privo di talento nell'arte della spada.
Inoue Genzaburō (1830-1868) aveva in realtà all'epoca in cui è ambientata l'opera 34 anni, ed aveva ricevuto quattro anni prima la certificazione della piena padronanza del patrimonio tecnico della scuola. Era anche stimato nello Shinsengumi come comandante abile e coraggioso. Cadde in battaglia all'inizio della guerra Boshin, di cui abbiamo già accennato.
 Dipinto da Oshima come persona semplice e di buoncuore, sembra interessarsi di Sozaburo senza secondi fini e con un fondo di ingenuità, offrendosi come insegnante di spada quando è evidente che il discepolo lo supera di molto.
Dipinto da Oshima come persona semplice e di buoncuore, sembra interessarsi di Sozaburo senza secondi fini e con un fondo di ingenuità, offrendosi come insegnante di spada quando è evidente che il discepolo lo supera di molto.
Proprio durante una "lezione" avviene un fatto che ha conseguenze potenzialmente devastanti.
Due samurai con accento della provincia di Higo hanno ottenuto il permesso di assistere alla lezione, ma sbeffeggiano a voce alta la scarsa padronanza della spada da parte di Inoue.
 E' un affronto che l'intero Shinsengumi intende punire. Non si ha alcuna traccia però dei due sconosciuti samurai, che si sono allontanati immediatamente.
E' un affronto che l'intero Shinsengumi intende punire. Non si ha alcuna traccia però dei due sconosciuti samurai, che si sono allontanati immediatamente.
Sarà Sozaburo a rintracciarli, con un paziente lavoro di investigazione e pedinamento.
 Riferisce ad Inoue.
Riferisce ad Inoue.
Questi intende vendicare l'affronto di persona, per riguadagnare la reputazione perduta.
Di nottte, accompagnato dal solo Sozaburo, si reca presso la locanda dove alloggiano i due samurai di Higo.
Il corpo dello Shinsengumi, riconosciuto ufficialmente dallo shogun, aveva diritto di investigazione e perquisizione, pur avendo sede nella città imperiale di Kyoto ossia nel cuore delle forze avversarie.
 Il compito di affrontare gli sconosciuti sarebbe improbo per Inoue, che rimane ferito prima ancora di mettere mano alla spada: viene fatto cadere da una scala a pioli mentre cerca di scendere nel canale dove si sono rifugiati i fuggitivi abbandonando la locanda.
Il compito di affrontare gli sconosciuti sarebbe improbo per Inoue, che rimane ferito prima ancora di mettere mano alla spada: viene fatto cadere da una scala a pioli mentre cerca di scendere nel canale dove si sono rifugiati i fuggitivi abbandonando la locanda.
Sozaburo lo difende coraggiosamente, ma ha la peggio. Una ferita alla fronte lo acceca momentaneamente, e sarebbe facile preda del suo avversario.
Lo salva l'arrivo di una squadra dello Shinsengumi guidata da Okita, che ha scoperto la folle impresa dei due e ha ottenuto il permesso di andare in loro soccorso.
 Della squadra fa parte Tashiro, sconvolto per la ferita di Sozaburo che sembra più grave di quanto sia per l'ingente perdita di sangue.
Della squadra fa parte Tashiro, sconvolto per la ferita di Sozaburo che sembra più grave di quanto sia per l'ingente perdita di sangue.
E' solo a lui e ai suoi disperati appelli però che Sozaburo risponde, riprendendo i sensi.
Tuttavia qualcosa si è incrinato nel loro rapporto, senza ancora rescinderlo del tutto.
 Nel dicembre di quell'anno Kondo Isami rientra da un viaggio ad Hiroshima, e raduna i suoi fedelissimi.
Nel dicembre di quell'anno Kondo Isami rientra da un viaggio ad Hiroshima, e raduna i suoi fedelissimi.
Il sottufficiale Jo Yamazaki partecipa animatamente alla discussione, di cui approfitta Oshima per sottolineare le stridenti contraddizioni d quel conflitto. I seguaci dello shogun sono tradizionalisti e favorevoli all'espulsione dello straniero, esattamente come i loro avversari.
Kondo chiede anche notizie di Sozaburo, considerato un giovane promettente anche se inquietante. Hijikata non può fare a meno di chiedere a se stesso come mai tutti si sentano in dovere di essere indulgenti col giovane.
 E' una legge non scritta cui nemmeno lui si sottrae. Proprio Yamazaki viene chiamato al suo cospetto e gli viene affidata una missione delicata: "convertire" Sozaburo, iniziandolo al rapporto con la donna.
E' una legge non scritta cui nemmeno lui si sottrae. Proprio Yamazaki viene chiamato al suo cospetto e gli viene affidata una missione delicata: "convertire" Sozaburo, iniziandolo al rapporto con la donna.
Questo dovrebbe far cessare i problemi da lui causati all'ordine interno dello Shinsengumi, ed aiutare anche lui stesso.
Mette a disposizione di Yamazaki del denaro, da utilizzare per una visita al quartiere dei piaceri di Shimabara.
 Il compito di Yamazaki (Masa Tommies) non sarà facile.
Il compito di Yamazaki (Masa Tommies) non sarà facile.
Sozaburo continua a sottrarsi ad ogni offerta, adducendo i motivi più futili per continui rinvii.
 Finirà per accettare, non è possibile sapere se per acquiescienza o perché sinceramente incuriosito ed attratto dalla possibilità che un nuovo mondo si apra a lui.
Finirà per accettare, non è possibile sapere se per acquiescienza o perché sinceramente incuriosito ed attratto dalla possibilità che un nuovo mondo si apra a lui.
Oppure semplicemente per non contraddire Yamazaki, che è il suo nuovo obiettivo.
 Tutto è stato preparato a dovere per l'iniziazione di Sozaburo.
Tutto è stato preparato a dovere per l'iniziazione di Sozaburo.
La geisha prescelta è una delle più affascinanti, e l'apparato che precede la sua apparizione e che la circonda mentre fa il suo ingresso sulla scena è spettacolare
 Solo una grande maestro come Oshima poteva rendere appieno sullo schermo l'incommensurabile fascino di una geisha.
Solo una grande maestro come Oshima poteva rendere appieno sullo schermo l'incommensurabile fascino di una geisha.
Incede impassibile eppure inequivocabilmente apportatrice di promesse.
Il suo passo è esasperatamente lento e rituale, mentre si dirige verso l'uomo che avrà la fortuna di essere oggetto delle sue attenzioni.
Ma tutto sarà vano: Sozaburo rientrerà nella caserma dello Shinsengumi a tarda notte,ma senza avere ceduto alle seduzioni della geisha. A Yamazaki che gliene chiede ragione candidamente confesserà: è lui che vuole, non una donna.
 Di lì a breve la situazione precipita: l'antico amante di Sozaburo, Yukawa, viene trovato morto: ucciso con un colpo di spada alla schiena, e finito con uno al ventre.
Di lì a breve la situazione precipita: l'antico amante di Sozaburo, Yukawa, viene trovato morto: ucciso con un colpo di spada alla schiena, e finito con uno al ventre.
Yamakazi viene poi assalito di notte, mentre si trova da solo. Riesce a difendersi e a mettere in fuga il suo inseguitore, senza riuscire ad identificarlo. Ma l'uomo ha perduto sul posto un kozuka, il piccolo coltello di servizio che viene spesso inserito nel fodero della katana o del wakizashi, le due spade che il samurai ha l'obbligo di portare.
Una breve indagine accerta che l'arma di Tashiro ha l'alloggiamento per il kozuka, che tuttavia manca.
 Kondô è categorico: ci sono prove sufficienti per concludere che Tashiro, in preda alla gelosia, è l'autore dei due agguati. Deve essere eliminato, e deve farlo Sozaburo. Hijikata pensa che sia troppo crudele chiederglielo; e che forse l'impresa sia superiore alle sue forze, visto lo stato di soggezione di cui è preda di fronte a Tashiro.
Kondô è categorico: ci sono prove sufficienti per concludere che Tashiro, in preda alla gelosia, è l'autore dei due agguati. Deve essere eliminato, e deve farlo Sozaburo. Hijikata pensa che sia troppo crudele chiederglielo; e che forse l'impresa sia superiore alle sue forze, visto lo stato di soggezione di cui è preda di fronte a Tashiro.
Ma ottiene solo di essere presente allo scontro come osservatore, assieme ad Okita.
Deve quindi convocare Sozaburo per comunicargli le decisioni del comandante. Il giovane si mostra sorpreso quando apprende di dover uccidere Tashiro. Ma non muove obiezioni: assicura solamente che farà del suo meglio.
 Hijikata ed Okita attendono sul posto, defilati per non essere osservati dai due duellanti che stanno per arrivare.
Hijikata ed Okita attendono sul posto, defilati per non essere osservati dai due duellanti che stanno per arrivare.
Ingannano l'attesa parlando. Okita confessa di non comprendere persone come Sozaburo o Tashiro, di essere addirittura infastidito da loro.
Nonostante abbia deciso di abbandonare ogni azione autonoma entrando nello Shinsengumi ed eseguendo senza discutere ogni ordine, ama leggere: per farsi una propria opinione e per conoscere il pensiero degli altri.
 Una lettura che lo ha molto impressionato è il racconto di un samurai che sceglie la morte per mantenere la parola data, abbandonando il corpo ridotto in prigionia per liberare lo spirito che tornerà così dall'amico cui aveva promesso il ritorno.
Una lettura che lo ha molto impressionato è il racconto di un samurai che sceglie la morte per mantenere la parola data, abbandonando il corpo ridotto in prigionia per liberare lo spirito che tornerà così dall'amico cui aveva promesso il ritorno.
Okita vede e denuncia lucidamente i difetti umani che si annidano anche tra gli angeli sterminatori dello Shinsengumi: lo stesso Hijikata non ne è immune, è geloso anche lui.
Geloso del suo rapporto privilegiato con Kondô, e non esita a mettersi di mezzo non appena intraveda un potenziale rivale.
 Ma Okita? saprebbe lo stesso Okita mantenersi imparziale di fronte al fascino di Sozaburo?
Ma Okita? saprebbe lo stesso Okita mantenersi imparziale di fronte al fascino di Sozaburo?
Lui assicura di non subire quel tipo di influenze, ma Hijikata non allude solamente all'attrazione sessuale.
Non può fare a meno di immaginare se stesso costretto ad affrontare Sozaburo.
E poi Okita, dapprima nella parte del carnefice, poi in quella della vittima.
Senza che sia ben chiaro, né ad Hijikata né tantomeno allo spettatore quando sia un ruolo e quando l'altro.
 Non c'è più tempo per i propri pensieri. Sozaburo e Tashiro sono arrivati.
Non c'è più tempo per i propri pensieri. Sozaburo e Tashiro sono arrivati.
Il giovane tenta di colpire a sorpresa l'altro, che riesce però ad evitare il colpo e messosi in guardia dopo aver estratto la spada gli chiede ragione di questo tradimento
Ne riceve in risposta un ambiguo sorriso, che non si saprebbe se definire angelico o diabolico, se di amore o di sfida.
Sozaburo lo accusa dell'uccisione di Yukawa e dell'agguato a Yamazaki, che hanno provocato la sua condanna a morte.
 Tashiro si difende, e i suoi accenti sono quelli di chi disperatamente afferma la verità.
Tashiro si difende, e i suoi accenti sono quelli di chi disperatamente afferma la verità.
Non è vero, è stato lo stesso Sozaburo ad uccidere Yukawa, per liberarsi di un legame ormai inutile.
E sempre lui ad aggredire Yamazaki, lasciando sul posto il suo kozuka per fargli ricadere addosso la colpa.
 Rimane poco da dire, la parola rimane alle spade.
Rimane poco da dire, la parola rimane alle spade.
Sozaburo continua a scontare la sua sudditanza psicologica di Tashiro, che oltre ad essergli superiore fisicamente trova ulteriori risorse nel suo carattere irriducibile.
Riesce a disarmare Sozaburo, e lo ha ormai alla sua mercé.
E' in quel momento che il ragazzo gli chiede perdono. E gli sussurra poi qualcosa che i due samurai che osservano senza essere visti non riescono a cogliere.
 E' un attimo.
E' un attimo.
Mentre Tashiro esita ed allenta la pressione della spada, Sozaburo fulmineo estrae la seconda lama che porta alla cintura e lo colpisce mortalmente.
Infierirà poi sul corpo inerme, prima di dare freddamente il colpo di grazia e allontanarsi infine con indifferenza, senza degnare di un ultimo sguardo il cadavere del suo antico amante.
 Pur senza aver potuto comprendere cosa abbia detto Sozaburo per sottrasi alla morte, sia Hijikata che Okita hanno la sensazione di avere completamente frainteso la vicenda.
Pur senza aver potuto comprendere cosa abbia detto Sozaburo per sottrasi alla morte, sia Hijikata che Okita hanno la sensazione di avere completamente frainteso la vicenda.
Non è pensabile che Tashiro mentisse, quando pensava di essere solo a solo con Sozaburo senza nessuno che ascoltasse. La sua potrebbe essere stata la verità.
O perlomeno, una parte non rinunciabile della verità.
 I due si allontanano, in silenzio.
I due si allontanano, in silenzio.
Okita ha un ripensamento: ha dimenticato qualcosa, deve tornare indietro un attimo.
Si allontana velocemente verso la stessa direzione in cui si era diretto Sozaburo.
Hijikata Toshizō rimane solo.
 Di fronte a lui, emergente dalla nebbia notturna, la sagoma di un giovane ciliegio in fioritura precoce.
Di fronte a lui, emergente dalla nebbia notturna, la sagoma di un giovane ciliegio in fioritura precoce.
Come molti sanno il ciliegio - sakura - è il simbolo dello spirito samurai: fiorisce improvvisamente, con maestosa bellezza, ma il tempo del fiore è limitato. E' destinato a durare pochi giorni.
Così il samurai: deve essere pronto a cadere in ogni momento, senza rimpianto, lasciando solo il ricordo della sua bellezza.
Hijikita estrarrà la lama per troncare d'un sol colpo l'intero tronco.
Il ciliegio deve cadere quando il suo tempo è arrivato. Senza esitazioni, senza rimorsi, senza rimpianti.