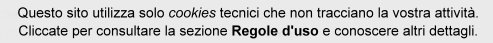Dizionario
 Ogni attività umana ha un suo linguaggio e un suo vocabolario specifico. Troverete in un glossario - ossia dizionario specialistico - le parole che difficilmente si trovano in un dizionario generico o che difficilmente vi vengono interpretate correttamente.
Ogni attività umana ha un suo linguaggio e un suo vocabolario specifico. Troverete in un glossario - ossia dizionario specialistico - le parole che difficilmente si trovano in un dizionario generico o che difficilmente vi vengono interpretate correttamente.
All'interno della cerchia inevitabilmente ristretta degli addetti ai lavori le parole si trasformano, si trasfigurano come se assumessero le caratteristiche dell'ambiente in cui vengono pronunciate, rivestendosi di significati specifici che sfuggono o possono sfuggire sia all'osservatore esterno che a coloro che muovono i primi incerti passi nell'arte.
- Premessa 1: Parte Linguistica e Parte Sistematica
Premessa
Parte linguistica
Regole di fonetica
Come regola generale possiamo dire che per pronunciare nel modo più corretto la lingua giapponese, occorre considerare le varie sillabe di ciascuna parola sprovviste di qualsiasi accento tonico e pronunciarle perciò tutte con eguale tono. A titolo di esempio, la pronuncia assolutamente piana della frase “ma chi te lo fa fare”. Esistono numerose eccezioni, segnalate con diversi sistemi di cui si fa cenno avanti.
Accento
La pronuncia delle vocali a, e, i, o, u, è in linea generale, assai vicina a quella della lingua italiana; fanno eccezione i ed u, che hanno suono quasi impercettibile davanti a k e h (es. shihonage) e in fine di parola (es. desu, pron. des’)
Consonanti
Nella lingua giapponese le consonanti hanno pronuncia assai vicina all’italiano salvo i casi indicati.
ch seguito da vocale ha suono simile alla c dolce italiana (es. cibo)
k suona come la c dura e il ch della lingua italiana (es. casa, chiodo)
j seguito da vocale ha un suono simile alla g dolce italiana (es. gioco)
g sempre e solo g dura (es. gatto); ha un suono profondamente gutturale
sh seguito da vocale va pronunciato come lo sc dolce italiano (es. scivolo)
h indica leggera aspirazione, più vicina al nostro f che alla h aspirata anglo-tedesca
l/r il suono l nella lingua giapponese non esiste, ma è sostituito dalla r che però ha un numero minore di vibrazioni rispetto alla r italiana; cosicché la pronuncia giapponese di questo suono è intermedia tra la l e la r
s ha sempre suono aspro (es. naso), da non confondersi con la nostra s dolce (es. quasi)
w come la w inglese ha un suono simile alla u
y suona come la i consonantica italiana (es. iato)
Alcune consonanti italiane non esistono in giapponese. Per questa ragione il glossario non comprende ad esempio alcun termine che inizi con la lettera L o con la Q. Alcune consonanti hanno pronuncia diversa a seconda della loro collocazione; ad esempio la h si pronuncia muta ed aspirata all’inizio della parola, come in hi (costolatura sulla lama di una spada) ma si pronuncia quasi sempre b e come tale viene trascritta quando si colloca all’interno di una parola, ad esempio koshibi (costolatura sulla parte della lama vicino al manico); il k si può pronunciare e trascrivere keiko (allenamento) in inizio di parola o con la g all’interno come in kagarigeiko (allenamento in gruppo). Altre consonanti hanno pronuncia incerta e vengono accettate più forme di trascrizione, come per katatetori e katatedori, entrambe corrette.
Regole di trascrizione
Esistono diversi sistemi di trascrizione dal giapponese alle lingue occidentali, quello generalmente più usato è il metodo Hepburn cui questo glossario cerca di adeguarsi; ma di fatto esistono discordanze, per ragioni pratiche, su alcuni punti essenziali, per esempio nel rafforzamento delle vocali. Dovrebbero essere rappresentate con un particolare segno grafico come per esempio in aikidō, ma la mancanza degli opportuni caratteri presso le tipografie – o nei sistemi informatici – ha fatto sì che venissero utilizzati dei palliativi, trascrivendo con aikidô, aikidoo oppure aikidou. Questi metodi sono equivalenti e non cambiano in ogni caso né il significato del termine né la pronuncia. Una ulteriore complicazione è costituita dal fatto che solo alcuni termini richiedono sempre il rafforzativo; tutti gli altri vengono normalmente pronunciati in maniera piana, ma se la fonetica suggerisce altrimenti ogni vocale può essere rafforzata.
Parte sistematica
Regole generali
Sono stati privilegiati ovviamente i termini tecnici propri dell’aikido e quelli riferentesi all’anatomia. Sono stati riportati quando possibili i termini tecnici utilizzati dalle differenti scuole di aikido ma viene generalmente utilizzata la terminologia maggiormente utilizzata nelle scuole Aikikai che rappresentano una importante percentuale del totale. Vengono riportati i termini tecnici utilizzati in altre arti marziali qualora abbiano attinenza con la pratica dell’aikido, senza pretendere di esaurirne la casistica. In particolare numerosi termini si riferiscono a diverse scuole di spada o di arma.
Termini Storici
Vengono riportati alcuni termini storici, in particolare quelli riferentesi alle epoche Edo in cui viene formalizzata l’etica del samurai e in cui nascono numerose scuole tuttora esistenti, Meiji, in cui termina traumaticamente l’era del samurai mentre la sopravvivenza delle scuole viene messa in causa ed inizia un processo di trasformazione ed adattamento, Showa, in cui nascono le arti marziali moderne tra cui l’aikido.
Arti complementari
Alcune arti complementari a quelle marziali sono state incluse nel glossario; la scelta è puramente indicativa e non vuole essere esaustiva; si sono privilegiate le arti che storicamente sono state praticate da numerosi maestri di arti marziali, ad esempio la calligrafia per cui è addirittura difficile trovare un maestro di rilevanza storica che non la praticasse, e tutte quelle che richiedendo una attenta osservazione e partecipazione agli eventi, senza coinvolgimento emotivo ma con la massima sensibilità, vengono considerate propedeutiche e complementari alle arti marziali.
Omissioni
Sono volontariamente omessi i personaggi, ad eccezione di quelli storici e degli appartenenti alla famiglia Ueshiba
- Premessa 2: Parte tecnica
Premessa 2
Parte tecnica
Pur traendo le basi dell'aikidô dalla preesistente disciplina plurisecolare del Daitô ryu, fortemente strutturata, il fondatore Ueshiba Morihei lasciò volutamente indeterminate molte caratteristiche della sua arte, preferendo calcare soprattutto - e fortemente - su principi di base da elaborare poi liberamente quando il praticante fosse giunto in condizioni tali di maturità da renderlo possibile e necessario.
Di conseguenza non è stata introdotta una terminologia specifica, anche perché per molti anni la pratica si è sviluppata soprattutto se non esclusivamente attraverso l'apprendimento pratico rinunciando spesso a porre delle basi teoriche, che arrivarono dopo. Citiamo a questo punto una testimonianza del maestro Hideki Hosokawa (Aikido, 1988-1), che rammentava le sue prime lezioni con Tada sensei, quando per una intera settimana dovette fare solamente tenkan per poi finalmente, per farlo "diveritre" un po', passare a kaiten:
«Capito? Nepure irimi tenkan! All'Honbu Dojo a quei tempi l'irimi tenkan non esisteva.O sensei in verità non ne ha mai parlato.»
Questo naturalmente non vuol dire che non esistesse l'irimi tenkan, ma semplicemente che non era stato codificato come ashisabaki di base e che il termine era ancora sconosciuto. Accanto ai temini tardivi ma introdotti con i crismi dell'ufficialità, esistono molti altri termini introdotti dagli shidosha inviati dall'Honbu Dojo a insegnare all'estero, coniati lì per lì quando emergeva la necessità di fornire una risposta ai praticanti stranieri, che avvertivano un forte bisogno di assegnare un nome a tutto quanto andavano apprendendo.
Questo spiega la difformità tra le varie scuole di alcuni termini e la necessità di un glossario in qualche modo allargato, che tenga conto almeno delle varianti più utilizzate. Col tempo naturalmente la terminologia ufficiale dello Zaidan Hojin Aikikai tende a prevalere sulle altre, ma questa tendenza va considerata positivamente: consente infatti di disporre di un esperanto dell'aikidô. In qualunque parte del mondo si trovi il praticante, ospite del dojô di una qualsiasi scuola, sa che avrà a che fare con termini già familiari e comprende cosa viene proposto dall'insegnante quando riconosce i termini katatetori aihanmi ikkyo o katadori nikkyo ura.
Y: Ya - Yusai
Ya Freccia.
Yabusame Antica tecnica di tiro con l’arco da un cavallo al galoppo contro bersagli fissi disposti lungo un percorso
Yah Kiai usato da uchidachi nell’attacco nei kata di spada
Yaku soku geiko Forma di esercitazione con reciproche proiezioni senza far resistenza alcuna.
Yama Montagna.
Yama arashi Lett. “tempesta sulla montagna”; leggendaria tecnica del judo degli esordi, che alcuni identificano come una forma insolita di shihonage
Yame Fermatevi, stop; comando alla fine di una esibizione o di un allenamento. Interrompe l’azione nei combattimenti
Yari Termine generico attribuito a vari tipi di lance ed alabarde.
Yari jutsu L’arte di maneggiare la lancia
Yari yubu Combattimento con la lancia (arte marziale).
Yarido Addestramento nella pratica dello yari.
Yasumu Pausa di riposo
Yawara Antica denominazione per ju jutsu
Yen Moneta giapponese.
Yoho giri Fendente orizzontale.
Yoi Pronto, pronti, prepararsi all’esercizio, State pronti!
Yoki Coltivare energia vitale (composto di ki).
Yoko Lato; di lato, orizzontale, laterale, di fianco
Yoko chiburi Chiburi orizzontale, (termine della scuola enshin ryu).
Yoko ichi min ji Una linea orizzontale.
Yoko kubi shime Attacco con strangolamento di lato
Yoko men Lato del capo o della faccia. Si distingue hidari yokomen e migi yokomen (lato destro o sinistro)
Yoko men uchi Attacco con colpo laterale al capo, al viso, al collo o al tronco, portato con la mano o con un’arma
Yoko uchi Colpo fendente laterale
Yoko ukemi Caduta laterale.
Yokofurumi Movimento laterale
Yoku/Yuki La virtù del coraggio
Yon Quattro.
Yon dan 4° Dan
Yon kajo Antico termine per yonkyo (quarta tecnica); ancora usato nello Yoshinkan Aikido
Yonkyo Quarta tecnica dell’aikido; tecnica di difesa a terra con presa tekubi osae (pressione dolorosa all’avambraccio di uke
Yon kyu 4° Kyu
Yoroi (kachu) Armatura pesante del samurai. L'armatura leggera viene chiamata kogusoku.
Yoroshiku onegai shimasu Per piacere, prego (molto gentile)
Yoru Avvicinarsi.
Yoseikan Aikido Scuola di aikido di Mochizuki Minoru, poi fondatore del metodo eclettico Yoseikan Budo
Yoseki Vedi Joseki
Yoshi Buono; invito a continuare il combattimento.
Yoshimitsu, Minamoto Fondatore dell’arte marziale aiki nel 12° secolo
Yoshinkan Aikido Stile di aikido sviluppato da Shioda Gozo
Yu Esistere.
Yubi Dito / dito del piede
Yudachi Chi ha un grado dan nel budo
Yudansha Chi possiede un grado dan; dagli ideogrammi aru = avere, dan = grado e sha = persona
Yuen Dolce, delicato; vedi ju
Yuka Supporti per riporre i tatami
Yukata Indumento giapponese, di aspetto simile al kimono, robusto ed utilizzato nella vita di tutti i giorni o per il riposo
Yuki Coraggio (composto di ki).
Yukoku no shi Nobile protettore della nazione (il samurai)
Yukuri Piano, lento.
Yumi Arco giapponese in lamina di bambu, asimettrico e di grandi dimensioni (circa 220 cm)
Yuru yaka ni Scorrevole, omogeneo
Yusai Metodo di meditazione della religione Omoto, seguito da Ueshiba Morihei
Z: Za - Zuki
Za Sedile, seggio, posto a sedere.
Za fu Cuscino per meditazione
Za gi Tecnica da seduto (come suwari waza)
Za ho Modo di sedere sui talloni per concentrarsi.
Za rei Saluto tradizionale con inchino, eseguito in ginocchio; quello in piedi si chiama ritsu rei
Za zen Posizione di meditazione nello Zen con le gambe incrociate davanti
Zaidan hojin Aikikai Fondazione Culturale Aikikai; nome ufficiale della organizzazione che si occupa dello sviluppo e della diffusione dell’Aikido, fondata il 30 aprile 1940 col nome di kobukai, cambiato il 9 febbraio 1948 in quello definitivo di Aikikai; riconosciuta dal Ministero della Educazione Nazionale giapponese ha come scopi statutari tra l’altro lo sviluppo di corpo e spiirito attraverso la pratica dell’aikido, organizzazione di mostre, conferenze e raduni, aprire sale per allenamenti, pubblicare libri e riviste concernenti l’aikido, attività diverse allo scopo di completare quelle elencate in precedenza
Zan shin “Spirito intatto”, stato di allerta chi dopo aver subito un attacco è immediatamente pronto per concentranzione ed autocontrollo ad affrontare il successivo
Zekken Distintivo ricamato con il nome proprio e del dojo (o la città o la nazione).
Zempaku Avambraccio.
Zempo kaiten Capriola in avanti; vedi chuga eri
Zengaku Fronte (del capo)
Zengo Movimento, direzione avanti ed indietro
Zenpo Davanti, avanti
Zenshin L’intero corpo
Zentai Totale
Zenwan Avambraccio
Zoori Sandalo da usare all’interno del dojo; anticamente di paglia intrecciata con una striscia di cuoio passante tra le dita, attualmente sono quasi sempre di gomma o plastica.
Zubon Pantaloni del keikogi.
Zuki Vedi tsuki
W: Wa - Waza
Wa Pace, accordo, armonia (meta suprema dell’aikido)
Wa jutsu Tecniche di armonia e coordinazione; situazione in cui i due partner si muovono in armonia reciproca
Wago (suru) Principio dell’aikido: armonizzare, accordarsi
Waka sensei Il Giovane Maestro; giovane insegnante; figlio di un maestro. In aikido è attribuito al successore designato alla carica di doshu (caposcuola)
Wakarimasen Non capisco
Wakarimashita ka? Avete capito?
Wakarimasu Ho capito.
Waki Ascella; anche lato
Waki gamae / kamae Posizione di guardia laterale della spada conosciuta anche come yo no kamae o sha no kamae, o nella scuolaOno-ha Itto Ryu come onken. La chiave di questa posizione é quella di celare la spada (o la lunghezza della spada) rivolta con la punta all’indietro ed esporre apparentemente il corpo al nemico, ma mantenendo lo sguardo fisso su di lui
Waki gatame Chiave articolare di braccio eseguita lateralmente (al suolo).
Waki no shita Ascella
Waki otoshi Proiezione mediante leva (judo).
Wakikage Punto di atemi nell’ascella
Wakizashi Spada giapponese corta, tra 1 e 2 shaku di lama; letteralmente “compagno di cintura”
Warui Cattivo.
Waza Tecnica, arte, modo di colpire