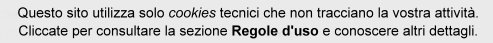Tecnica e Cultura
 Tecnica e cultura sono secondo noi strettamente ed indissolubilmente legati, sia nella pratica delle arti marziali sia nella pratica delle altre meravigliose arti tradizionali giapponesi.
Tecnica e cultura sono secondo noi strettamente ed indissolubilmente legati, sia nella pratica delle arti marziali sia nella pratica delle altre meravigliose arti tradizionali giapponesi.
Lo ricordano costantemente i grandi maestri, quando ci fanno presente che la spada deve essere impugnata con la stessa delicatezza, la stessa sensibilità e la stessa disponibilità a rappresentare l'armonia del creato che spingono il pittore ad impugnare il pennello o il violinista il suo strumento.
Tecnica quindi, ma anche e soprattutto ricerca del giusto e del bello. In altre parole, cultura.
Il diploma di aikido: come leggerlo, come consegnarlo, come riceverlo
Parliamo naturalmente del Diploma per eccellenza: quello che viene rilasciato agli yudansha dallo Zaidan Hojin Aikikai, che viene consegnato solamente durante i raduni più importanti, a meno di cause di forza maggiore, e da maestri di grande caratura. Naturalmente solo le associazioni riconosciute dall'Hombu Dojo, la scuola centrale di aikido che è il "nocciolo duro" dell'Ente Morale Aikikai di Tokyo, possono registrare i gradi presso l'archivio centrale e ottenere per l'esaminato la yudansha card, un po' il passaporto del praticante di aikido, che gli consente di essere accettato pressoché ovunque a praticare perché anche le scuole indipendenti riconoscono il prestigio della scuola Aikikai, e naturalmente il diploma di cui stiamo parlando.
I possessori di uno o più diplomi di questo tipo li custodiscono gelosamente, li affiggono sui lati d'onore del loro dojo, non sempre però riescono a leggerli o perlomeno a decifrare cosa vi è scritto. Ed ecco qua una breve spiegazione, compilata con la collaborazione preziosa di persone esperte in materia, cui vanno i debiti ringraziamenti ma non dovranno andare rimproveri in caso di qualche fraintendimento da parte nostra.
Innanzitutto qualche premessa: stiamo parlando per ora del diploma rilasciato agli yudansha dal primo al quarto dan: i diplomi dei gradi successivi non sono sostanzialmente molto diversi, lo vedremo più avanti, ma sono confezionati in maniera diversa; quelli che esaminiamo ora sono stampati su un foglio di dimensioni 33cm x 51, quindi quelle più adatte per essere solennemente aperto e tenuto con le braccia aperte dal maestro incaricato di consegnarlo, all'altezza degli occhi in modo da poterlo agevolmente leggere a voce alta. Parleremo in seguito del corretto svolgimento della cerimonia della consegna.
I diplomi dal quinto grado dan, o quello grossomodo equivalente di menkyo nelle scuole che utilizzano ancora il sistema di certificazione mokuroku, vengono consegnati chiusi, seguendo una antica tradizione. Il praticante che presentava un diploma di questo tipo per essere accettato in un dojo o in un feudo veniva ammesso per così dire d'ufficio: il diploma non veniva nemmeno aperto, facevano fede l'importanza del grado conseguito e la certificazione assicurata dai timbri della scuola e del suo soke impressi all'esterno.
Ma è ora di spiegare come va letto il diploma; naturalmente la lettura va, in verticale, da destra a sinistra; basterà seguire la numerazione

| 1 | Zaidan 財団 Hojin 法人 Aikikai 合氣会 | Fondazione Culturale Aikikai | |
| 2 | Dai 第 shisen 四 kūhyaku 九 rokuji 六 kyū 九 gō 号 | Numero quattromila novecento sessanta nove progressivo | a |
| 3 | Sho 證 | Certificato | |
| 4 | Migi no mono konpan 右 者 今般 aikido 合氣道 | (alla) persona di fronte ora aikido | b |
| 5 | yo 四 dan 段 o ヲ inkasu 允可ス | 4° dan concede | c |
| 6 | Heisei 平成 juichi nen 十一年 nigatsu 二月 tsuitachi 一日 | Heisei, 11° anno, febbraio, 1° giorno | d |
| 7 | Aikido合氣道 | Aikido | |
| 8 | Doshu 道主 Ueshiba 植芝 Moriteru 守央 | Doshu, Ueshiba Moriteru | e |
La traduzione parola per parola non rende correttamente il testo in italiano, rimane però facilmente interpretabile.
Note:
a Le cifre giapponesi sono: rei 零 0, ichi 一 1, ni 二 2, san 三 3, shi 四 4, go 五 5, roku 六 6, shichi 七 7, hachi 八 8, ku 九 9. In certi tipi di numerazione - ed anche nei gradi dan - il 4 si pronuncia yon e il 7 nana.
b Migi no mono letteralmente significa "alla persona a destra", konpan "questa volta"
c I gradi sono shodan 壱段 (che andrebbe reso non con primo dan ma con dan iniziale), nidan 弐段,
sandan 参段, yodan 四段. I primi 3 utilizzano kanji diversi dai semplici numerali, utilizzati nei documenti ufficiali per evitare contraffazioni: se si adottassero i numeri convenzionali basterebbe aggiungere una linea per trasformare 1 in 2 e 2 in 3.
d Fino all'8 gennaio 1989 l'era è Showa (1926-1988), segue l'era Heisei, attualmente, dal 1. aprile 2019, ci troviamo nell'era Reiwa. In giapponese i mesi non hanno nomi distinti come in italiano ma vengono detti primo, secondo ... dodicesimo mese (gatsu).
e I certificati hanno fino al 1969 la firma di Ueshiba Morihei, di Ueshiba Kisshomaru dal 1969 al 1999, di Ueshiba Moriteru dal 1999
 E' ora finalmente di vedere il famoso diploma di secondo livello, riservato ai gradi superiori: a partire dal quinto dan.
E' ora finalmente di vedere il famoso diploma di secondo livello, riservato ai gradi superiori: a partire dal quinto dan.
Come detto, non viene inviato aperto ma ripiegato dentro una busta, conservando l'antica tradizione.
Così come arriva dall'Hombu Dojo ha l'aspetto di una anonima busta commerciale, per quanto di buona qualità.
 Ma una etichetta col nome del destinatario rivela già che il contenuto è qualcosa di peculiare, indirizzato ad una persona specifica.
Ma una etichetta col nome del destinatario rivela già che il contenuto è qualcosa di peculiare, indirizzato ad una persona specifica.
Gli ideogrammi sopra al nome dicono godan i (livello quinto dan). L'ultimo ideogramma alla destra del nome è dono, un appellativo onorifico.
 L'anonima busta giallina, del tipo che si trova in ogni cartoleria, è destinata a contenerne un'altra di tipo tradizionale, che viene così preservata dall'usura. Sarebbe un peccato rovinarla, è una bella busta confezionata con carta di fattura speciale, e i lembi non sono incollati ma semplicemente ripiegati.
L'anonima busta giallina, del tipo che si trova in ogni cartoleria, è destinata a contenerne un'altra di tipo tradizionale, che viene così preservata dall'usura. Sarebbe un peccato rovinarla, è una bella busta confezionata con carta di fattura speciale, e i lembi non sono incollati ma semplicemente ripiegati.
Reca impresso al centro, in splendido isolamento, un singolo ideogramma, che già conosciamo: sho (證): certificato.
E' una busta che assomiglia a quella in cui anticamente gli shugyosha itineranti conservavano il loro mokuroku (l'attestato della scuola di appartenenza). Veniva consegnata al dojocho ospitante, per chiedere l'ammissione ai corsi o un confronto con gli allievi del dojo.
La persona che riceveva il certificato, ove riconosceva i timbri di una scuola a lui nota o comunque di chiara fama, dichiarava normalmente sufficiente tale prova per ammettere il richiedente, senza aprire la busta né esaminare materialmente il certificato.
 E' ovvio però che al momento della cerimonia della consegna la busta viene aperta ed il contenuto viene letto in pubblico. Andiamo quindi ad aprire anche noi la seconda busta: vi troviamo dentro, ancora ripiegato, il certficato vero e proprio.
E' ovvio però che al momento della cerimonia della consegna la busta viene aperta ed il contenuto viene letto in pubblico. Andiamo quindi ad aprire anche noi la seconda busta: vi troviamo dentro, ancora ripiegato, il certficato vero e proprio.
La carta è splendida, del tipo usato per certe buste origami. Anzi, facciamo notare che c'è anche chi chiama semplicemente origami i vari tipi di certificato, ad esempio i kantei che accompagnano le migliori spade, visto che in fondo sono dei fogli di carta piegati.
Il colore è bianco purissimo, e l'impressione al tatto è molto piacevole.
Ora lo dispiegheremo.
 Quando aperto questo diploma si rivela molto più grande dell'altro; ma viene utilizzata per la scrittura solamente la parte superiore, quella inferiore invece viene lasciata completamente vuota.
Quando aperto questo diploma si rivela molto più grande dell'altro; ma viene utilizzata per la scrittura solamente la parte superiore, quella inferiore invece viene lasciata completamente vuota.
 Un'altra particolarità: la foto controluce mette in evidenza la filigrana impressa nella carta: Zaidan Hojin Aikikai, che significa come abbiamo già visto Fondazione Culturale Aikikai.
Un'altra particolarità: la foto controluce mette in evidenza la filigrana impressa nella carta: Zaidan Hojin Aikikai, che significa come abbiamo già visto Fondazione Culturale Aikikai.
E adesso finalmente iniziamo a leggere anche questo certificato. Conoscete già i numeri, sapete ormai che la lettura va da destra a sinistra, dall'alto verso il basso. Non abbiamo ovviamente considerato la colonna ove vengono scritti cognome e nome in romaji ossia caratteri romani, occidentali, nel caso il diploma sia destinato a un praticante non giapponese.
Il nome viene pennellato con uno stile molto "piatto" per evitare di debordare nella zona sottostante, al di sotto della piegatura. Il problema non si pone di solito per i nomi giapponesi, che anche quando sono molto lunghi vengono resi con pochi ideogrammi.

| 1 | Zaidan 財団 Hojin 法人 Aikikai 合氣会 | Fondazione Culturale Aikikai |
| 2 | Dai 第 shisen 四 nihyaku 二 shichiju 七 ku 九 gō 号 | Numero 4279 progressivo |
| 3 | Sho 證 | Certificato |
| 4 | Migi no mono konpan 右 者 今般 aikido 合氣道 | (alla) persona di fronte ora aikido |
| 5 | go 五 dan 段 i ni ressu ....ス * | (nei) 5° dan lo accogliamo |
| 6 | Heisei 平成 nijuichi nen 二十 一 年 ichigatsu 一月 juichi nichi 十一日 | Heisei, 21° anno, gennaio, 11° giorno |
| 7 | Aikido 合氣道 | Aikido |
| 8 | Doshu 道主 Ueshiba 植芝 Moriteru 守央 | Doshu, Ueshiba Moriteru |
* i kanji sono in corso di identificazione
Dovremo nella prossima parte dire qualcosa di come va ricevuto il diploma all'atto della consegna uffficiale. Secondo la regola in uso nell'Aikikai d'Italia solamente in casi particolari e su richiesta dell'interessato il diploma viene spedito. Altrimenti viene consegnato durante un raduno nazionale, sul tatami, al termine di una lezione, davanti alla schiera dei praticanti che assiste in seiza.
Una volta superato l’esame sembrava che fosse finita… invece dovremo ancora ricevere il diploma e ci ritroveremo di fronte a un maestro che lo consegnerà con una cerimonia protocollare. Quindi dobbiamo sapere come comportarci correttamente.
Anche se si è nel proprio dojo e si riceve un diploma di kyu valgono le stesse regole, ma per i diplomi dan di solito ci si trova in un grande raduno, affollato di molti praticanti. Quindi è bene esser pronti e non sistemarsi troppo lontani.
 Nelle grandi occasioni l’inizio della cerimonia della consegna è inequivocabile: accanto al maestro, sulla sua destra ed in posizione leggermente arretrata, si posiziona chi ha l’incarico di portare i diplomi, controllarli, tenerli in ordine e consegnarli al maestro aperti, per permettergli di leggere il nome e chiamare la persona interessata. Nei maggiori raduni è anche lui un maestro di alto grado. I diplomi oltre il quarto dan vengono come sappiamo consegnati chiusi dentro la busta, all’esterno della quale è ripetuto il nome.
Nelle grandi occasioni l’inizio della cerimonia della consegna è inequivocabile: accanto al maestro, sulla sua destra ed in posizione leggermente arretrata, si posiziona chi ha l’incarico di portare i diplomi, controllarli, tenerli in ordine e consegnarli al maestro aperti, per permettergli di leggere il nome e chiamare la persona interessata. Nei maggiori raduni è anche lui un maestro di alto grado. I diplomi oltre il quarto dan vengono come sappiamo consegnati chiusi dentro la busta, all’esterno della quale è ripetuto il nome.
Chi deve ricevere il diploma esce dai ranghi e passando davanti ai praticanti in seiza percorre in piedi, senza correre ma neppure procedendo con lentezza, a passo naturale come naturale dovrebbe essere ogni cosa che riguarda l’aikido, il tratto che porta davanti al maestro. Qui si mette in seiza e si inchina solennemente. Il rei dell'aikido, per esplicita volontà del Fondatore, si esegue poggiando contemporaneamente le due mani sul tatami, distanziate tra loro di un palmo circa od accostate, e non poggiando prima la mano sinistra e poi la destra.
 Il maestro fa quindi cenno di avvicinarsi per cui si fanno alcuni passi in shikkō fino a trovarsi a circa 2 metri di distanza. Occorre tuttavia prestare estrema attenzione ad eventuali variazioni procedurali richieste dal maestro: è possibile ad esempio, è successo anche recentemente, che richieda di posizionarsi direttamente davanti a lui soprassedendo alla fase preliminare. Questo succede soprattutto quando i diplomi da consegnare sono molti ed è necessario accelerare la procedura.
Il maestro fa quindi cenno di avvicinarsi per cui si fanno alcuni passi in shikkō fino a trovarsi a circa 2 metri di distanza. Occorre tuttavia prestare estrema attenzione ad eventuali variazioni procedurali richieste dal maestro: è possibile ad esempio, è successo anche recentemente, che richieda di posizionarsi direttamente davanti a lui soprassedendo alla fase preliminare. Questo succede soprattutto quando i diplomi da consegnare sono molti ed è necessario accelerare la procedura.
A questo punto il maestro procede alla lettura del documento, con voce altisonante adeguata alla circostanza. Chi ha la fortuna di ricevere il diploma dalle mani di un grande maestro, come Hiroshi Tada sensei, si rende conto immediatamente di trovarsi di fronte alla incarnazione dell’arte dell’aikido, e avverte fisicamente la vibrazione della sua energia nell’atto della proclamazione. Basterebbe questa sensazione a fornire lo stimolo per continuare nella ricerca, fino ad ottenere una nuova occasione per essere di fronte a lui.
 Appena terminata la proclamazione si avanza in shikkō fino a poter ricevere il diploma con le due braccia tese (il famoso ma ai che dovremmo padroneggiare: questa è una delle circostanze in cui va ricordato ed applicato).
Appena terminata la proclamazione si avanza in shikkō fino a poter ricevere il diploma con le due braccia tese (il famoso ma ai che dovremmo padroneggiare: questa è una delle circostanze in cui va ricordato ed applicato).
Attenzione: è antica usanza che gli uomini porgano prima la mano destra e poi la sinistra, entrambe con il palmo rivolto in alto. Le donne invece porgono prima la sinistra e poi la destra.
Assieme al diploma giapponese l’Aikikai d’Italia usa consegnare quello nazionale, e la yudansha card per chi ha ottenuto il grado shodan.
 Sempre tenendo il diploma con le due mani lo si porta in alto all'incirca all'altezza degli occhi, accennando un inchino in segno di ringraziamento, lo si mantiene poi all'altezza del mento, per rispetto nei confronti del documento, che non deve essere sfiorato dall’alito. Ricordiamo che anche nell’esame di una spada ad esempio ci si deve astenere dall’alitarvi sopra, tantevvero che si usava esaminare una lama tenendo un foglio di carta ben serrato nella bocca.
Sempre tenendo il diploma con le due mani lo si porta in alto all'incirca all'altezza degli occhi, accennando un inchino in segno di ringraziamento, lo si mantiene poi all'altezza del mento, per rispetto nei confronti del documento, che non deve essere sfiorato dall’alito. Ricordiamo che anche nell’esame di una spada ad esempio ci si deve astenere dall’alitarvi sopra, tantevvero che si usava esaminare una lama tenendo un foglio di carta ben serrato nella bocca.
Non si deve tuttavia esagerare, sollevando troppo il diploma fino a portarlo a volte addirittura sopra la testa, come si vede spesso. La corretta postura con cui si presenta o si riceve un oggetto nei confronti di una persona di riguardo, è questa. Si tratta di un fotogramma del film Sanjuro, di Akira Kurosawa, e la scena rappresenta la presentazione del pranzo da parte di un gruppo di ancelle a Tsubaki Sanjuro, ospite della casa.
 L'immagine precedente ha lo scopo di illustrare l'analogia tra molte abitudini ed usanze adottate nel mondo delle arti marziali e quelle derivate dalla tradizione in senso più vasto.
L'immagine precedente ha lo scopo di illustrare l'analogia tra molte abitudini ed usanze adottate nel mondo delle arti marziali e quelle derivate dalla tradizione in senso più vasto.
Questa seconda immagine raffigura il maestro
 Infine si appoggia il diploma sul tatami, sulla propria destra, e si esegue un inchino vero e proprio; quindi lo si riprende con due mani e ci si allontana in ushiro shikkō riguadagnando il punto dove ci si era messi in seiza.
Infine si appoggia il diploma sul tatami, sulla propria destra, e si esegue un inchino vero e proprio; quindi lo si riprende con due mani e ci si allontana in ushiro shikkō riguadagnando il punto dove ci si era messi in seiza.
Qui ci si rialza e ci si avvia infine verso il proprio posto, sempre ad andatura naturale ed in assoluto silenzio. Va da sé che durante tutta la cerimonia protocollare non bisogna mai volgere le spalle allo shomen ed al maestro. Ma ancora una volta non è finita: già da ora si deve cominciare a lavorare per il prossimo dan!
Il bokken: strumento di lavoro, simbolo di una antica tradizione marziale
 Tutti o quasi i praticanti di aikido sanno che cosa è il bokken, più propriamente detto bokuto: una spada di legno lunga circa un metro che riproduce la forma di una katana, la spada maggiormente utilizzata dai samurai, adottata oggigiorno nella pratica del’aikido (aikiken) ma già da diversi secoli nelle scuole di kenjutsu. Piú difficile naturalmente trovare qualcuno che sappia anche a quali caratteristiche deve rispondere il bokken, e quale è la sua storia.
Tutti o quasi i praticanti di aikido sanno che cosa è il bokken, più propriamente detto bokuto: una spada di legno lunga circa un metro che riproduce la forma di una katana, la spada maggiormente utilizzata dai samurai, adottata oggigiorno nella pratica del’aikido (aikiken) ma già da diversi secoli nelle scuole di kenjutsu. Piú difficile naturalmente trovare qualcuno che sappia anche a quali caratteristiche deve rispondere il bokken, e quale è la sua storia.
Leggi tutto: Il bokken: strumento di lavoro, simbolo di una antica tradizione marziale
Esami. Si parla sempre di esami.
 Ma è sempre un piacere quando ad occuparsi di questa materia, apparentemente inflazionata ma in realtà mai esaurita e mai esauribile. è un insegnante qualificato come Fabrizio Ruta, che nella sua carriera ha formato diverse decine di yudansha. Spesso (troppo spesso?) si parla del significato dell'esame. Non altrettanto spesso si danno ai praticanti gli indispensabili punti di riferimento necessari per presentarsi ben preparati ad un esame.
Ma è sempre un piacere quando ad occuparsi di questa materia, apparentemente inflazionata ma in realtà mai esaurita e mai esauribile. è un insegnante qualificato come Fabrizio Ruta, che nella sua carriera ha formato diverse decine di yudansha. Spesso (troppo spesso?) si parla del significato dell'esame. Non altrettanto spesso si danno ai praticanti gli indispensabili punti di riferimento necessari per presentarsi ben preparati ad un esame.
I nostri mon: il simbolo delle casate dei nostri maestri
 Mon potrebbe essere tradotto con emblema, stemma, blasone: è insomma il simbolo della casata cui appartiene il samurai. Gli stemmi occidentali possono essere abbastanza complessi e la scienza che se ne occupa, l'araldica, è ardua: richiede la conoscenza profonda di un linguaggio specifico che sfugge ai profani. Per nostra fortuna i mon giapponesi sono abbastanza semplici, sobri. Ma è ora di vederli. Il nostro sito è curato da praticanti ed insegnanti che aderiscono all'Aikikai d'Italia, organizzazione riconosciuta dalle autorità italiane con il nome per esteso di Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese. E anche l'Aikikai d'Italia, nel solco della tradizione giapponese, ha il suo mon; eccolo:
Mon potrebbe essere tradotto con emblema, stemma, blasone: è insomma il simbolo della casata cui appartiene il samurai. Gli stemmi occidentali possono essere abbastanza complessi e la scienza che se ne occupa, l'araldica, è ardua: richiede la conoscenza profonda di un linguaggio specifico che sfugge ai profani. Per nostra fortuna i mon giapponesi sono abbastanza semplici, sobri. Ma è ora di vederli. Il nostro sito è curato da praticanti ed insegnanti che aderiscono all'Aikikai d'Italia, organizzazione riconosciuta dalle autorità italiane con il nome per esteso di Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese. E anche l'Aikikai d'Italia, nel solco della tradizione giapponese, ha il suo mon; eccolo:
Questo simbolo, che ho avuto l'onore di disegnare, non nasce comunque dal nulla. Non sarebbe stato nemmeno logico: l'Aikikai d'Italia si ricollega, attraverso lo Zaidan Hojin Aikikai, associazione "madre" fondata nel 1942 da Ueshiba Morihei a Tokyo (e riconosciuta a sua volta dal governo giapponese) alla tradizione nipponica. Al simbolo, o mon, dell'Aikikai so honbu come anche viene definita mi sono ovviamente collegato per quello italiano. Devo dire che sospetto di avere lanciato una moda: diverse altre associazioni nazionali aderenti alla casa madre hanno seguito l'esempio. Da una parte fa piacere, dall'altro sento il dovere di mettervi in guardia: lo sapete che sono un pessimo soggetto, se prendermi come esempio diventasse davvero una moda... ma torniamo al nostro mon:
 La International Aikido Federation ha adottato un mon praticamente identico a quello dell'Aikikai so Honbu, colore a parte: nell'originale i petali sono decisamente più chiari, azzurri e non blu, tendenti quasi al celeste. Molti yudansha potranno controllare all'interno del koshi ita della loro hakama ( se non sanno cosa è il koshi ita o addirittura l'hakama possono consultare il glossario dell'aikido alle lettere K ed H. Infatti i migliori fabbricanti di indumenti ed attrezzature per aikido hanno ricevuto dall'Honbu Dojo l'autorizzazione ad utilizzare il mon ufficiale nei loro prodotti.
La International Aikido Federation ha adottato un mon praticamente identico a quello dell'Aikikai so Honbu, colore a parte: nell'originale i petali sono decisamente più chiari, azzurri e non blu, tendenti quasi al celeste. Molti yudansha potranno controllare all'interno del koshi ita della loro hakama ( se non sanno cosa è il koshi ita o addirittura l'hakama possono consultare il glossario dell'aikido alle lettere K ed H. Infatti i migliori fabbricanti di indumenti ed attrezzature per aikido hanno ricevuto dall'Honbu Dojo l'autorizzazione ad utilizzare il mon ufficiale nei loro prodotti.
Avrete immediatamente notato che ho parlato di petali: il mon rappresenta infatti un fiore di sakura ossia ciliegio. Un albero che produce fiori semplici ma che riuniti assieme ricoprono di bianche splendide cortine giardini e boschi: nell'epoca della fioritura l'intero popolo giapponese si arresta ed accorre ad ammirare lo spettacolo dei sakura in fiore. Ma dopo aver rappresentato in modo indimenticabile lo splendore e la forza della natura, dopo aver fatto il proprio dovere, il fiore cade, senza rimpianti. Niente paura, al tempo giusto ci saranno altri fiori e l'albero, o l'intero giardino, risplenderà di nuovo. E' Il fiore che rappresenta meglio di ogni altra cosa lo spirito del Giappone e del samurai, come dice il noto proverbio che ci ricorda gli ideali tradizionali del popolo giapponese:
 Hana wa sakuragi,
Hana wa sakuragi,
Hito wa bushi
ossia, tradotto liberamente:
Tra i fiori il ciliegio,
Tra gli uomini il cavaliere
Mi perdonerete se ho usato il termine cavaliere, ma mi sembra quello più adatto a racchiudere il significato di bushi; normalmente si usa tradurre questo detto utilizzando la parola samurai, ma come avete visto nell'originale non c'è.
 Quindi anche il mon dell'Aikikai so Honbu si è ispirato a qualcosa di precedente; e precisamente ad un antico mon, utilizzato da molte e nobili famiglie; ed il mon del Dojo Musubi? Naturalmente anche questo ha voluto ispirarsi al fiore di sakura, ma ho voluto trasformarlo in qualcosa di altrettanto simbolico, legato alla cultura giapponese e a quella samurai in particolare.
Quindi anche il mon dell'Aikikai so Honbu si è ispirato a qualcosa di precedente; e precisamente ad un antico mon, utilizzato da molte e nobili famiglie; ed il mon del Dojo Musubi? Naturalmente anche questo ha voluto ispirarsi al fiore di sakura, ma ho voluto trasformarlo in qualcosa di altrettanto simbolico, legato alla cultura giapponese e a quella samurai in particolare.
Ed esattamente una tsuba, ossia la guardia di una katana, la spada giapponese (nihonto) che tanto ha fatto parlare di se attraverso i secoli, come potete leggere in un'altra sezione di questo sito.
E detto dei mon legati ad organizzazioni ed enti immateriali, passiamo finalmente a quelli legati alle persone.
 In questo ritratto ufficiale del grande maestro Ueshiba Morihei, fondatore dell'aikido, eseguito intorno al 1960 e proveniente dal libro fotografico celebrativo del centenario della sua nascita, pubblicato dall'Honbu Dojo nel 1983, possiamo vedere l'utilizzo più immediato del mon di famiglia.Lo troviamo riportato sopra l'aori, una sopravveste che veniva indossata dai samurai sopra gli abiti. Il mon viene applicato ai lati del bavero e sulle maniche.
In questo ritratto ufficiale del grande maestro Ueshiba Morihei, fondatore dell'aikido, eseguito intorno al 1960 e proveniente dal libro fotografico celebrativo del centenario della sua nascita, pubblicato dall'Honbu Dojo nel 1983, possiamo vedere l'utilizzo più immediato del mon di famiglia.Lo troviamo riportato sopra l'aori, una sopravveste che veniva indossata dai samurai sopra gli abiti. Il mon viene applicato ai lati del bavero e sulle maniche.
Bisogna aggiungere che molti anni fa, quando l'aikido era ancora in fase pionieristica, diversi insegnanti italiani di non poche arti marziali avevano preso l'abitudine di presentarsi alle dimostrazioni in pubblico o addirittura alle lezioni in alta tenuta, con l'aori e - ovviamente - muniti di mon.
Certamente, l'abito tradizionale giapponese viene utilizzato ancora oggigiorno in occasioni speciali o da parte di persone di rango. Viene tuttavia considerato un abito da indossare con la dovuta cautela ed una certa parsimonia.
A detta del maestro Hosokawa, che trovava tutta la faccenda molto divertente, l'uso indiscriminato dell'aori e del mon da parte degli occidentali ha tra i giapponesi lo stesso effetto che potrebbe avere tra di noi quello di un signore giapponese che si presentasse ad una cena informale tra amici in pizzeria munito di abito a code, cappello a cilindro, bastone col manico d'avorio e mantello alla Mandrake. Ossia l'effetto di rendere immediatamente e irrimediabilmente stravagante e fuori luogo la persona abbigliata in quel modo.
 Ci portiamo ora, col dovuto rispetto, alle spalle di o sensei ed osserviamo quest'altra immagine. Proviene dalla stessa fonte ma questa volta è una foto, scattata nel 1967 per preparare una pubblicazione dedicata al Maestro il cui titolo suonava come "Tecniche trascendenti".
Ci portiamo ora, col dovuto rispetto, alle spalle di o sensei ed osserviamo quest'altra immagine. Proviene dalla stessa fonte ma questa volta è una foto, scattata nel 1967 per preparare una pubblicazione dedicata al Maestro il cui titolo suonava come "Tecniche trascendenti".
CI rendiamo ora conto che un altro mon è riportato abitualmente dietro l'aori, un poco sotto il colletto. E' importante, da un punto di vista pratico: rendeva distinguibile il lignaggio della persona anche vedendolo passare da dietro. Ma lo è anche per conoscere il remoto retroscena di una tecnica di aikido.
In quel punto, per concretizzare con un atto materiale la propria vittoria, sfregiando il mon del nemico vinto, veniva dato il colpo di grazia al samurai sconfitto in duello od in combattimento.
Un "ricordo" di questa tecnica di combattimento è all'origine della tecnica di aikido chiamata ushirokiriotoshi, croce (molta) e delizia (poca) di chi si prepara per l'esame di 1° kyu.
 Nella foto in basso, pubblicata su Aikido anno XII, Novembre 1983 (il primo numero di Aikido, la rivista dell'Aikikai d'Italia, che il destino mi chiamò a curare) vediamo appunto il maestro Hiroshi Tada nell'esecuzione di un ushiro kiri otoshi: taglio da dietro con rovesciamento, ossia con sollevamento per aria delle gambe dell'uke mentra il capo cade al suolo.
Nella foto in basso, pubblicata su Aikido anno XII, Novembre 1983 (il primo numero di Aikido, la rivista dell'Aikikai d'Italia, che il destino mi chiamò a curare) vediamo appunto il maestro Hiroshi Tada nell'esecuzione di un ushiro kiri otoshi: taglio da dietro con rovesciamento, ossia con sollevamento per aria delle gambe dell'uke mentra il capo cade al suolo.
Naturalmente se si enfatizza il "taglio" che qui il maestro esegue sul viso quindi tagliando con movimento a tirare. Per dare invece il colpo di grazia definitivo sul punto in cui è collocato il mon si eseguirebbe con l'altra mano un movimento di penetrazione a spingere con il tanto (pugnale).
La foto ne accompagna altre che riconosco come mie, scattate nel 1982 al raduno estivo di Coverciano (ho memoria, appunto, fotografica).
Ma questa non è mia, non appartiene a quella sequenza e ne ignoro la provenienza, si trovava in archivio e senza alcuna indicazione. Presumibilmente fu scattata dal compianto Giovanni Granone negli anni 70: una foto bella e fortunata, perché fotografare l'aikido non è facile e un pizzico di fortuna aiuta, ma anche scattata con presenza di spirito (il ki, sempre lui...), senso della distanza e della posizione, scelta di tempo impeccabile.
Abbiamo detto che l'aori con il mon di famiglia non è cosa da tutti: Ueshiba Morihei lo portava spesso, ma ricordiamoci che si trattava di una persona per molti versi di altri tempi. Nacque nel dicembre del 1883 in un piccolo villaggio di pescatori dove a malapena si sapeva che il "mondo" del samurai stava cambiando per l'arrivo degli stranieri e del 'progresso' e che in breve sarebbe addirittura scomparso, lasciando per nostra fortuna numerose e tangibili tracce ed una cospicua eredità, che comprende l'aikido, che abbiamo il dovere di tramandare a chi verrà dopo di noi.
Tokyo, Budokan Hall, Kagami Biragi 1994: il maestro Tada riceve l'onoreficenza del Budo korosho
 Oggigiorno l'aori è un indumento soprattutto da cerimonia, si indossa ad esempio durante i matrimoni e le cerimonie ufficiali. Ma non basta l'occasione per avere un mon: occorre discendere da un lignaggio i cui membri fossero autorizzati all'utilizzo del blasone familiare.In occasione della consegna del Budo korosho, una importante onoreficenza riservata a chi si è particolarmente distinto nel mondo delle arti marziali, ecco il maestro Hiroshi Tada, anche per il resto debitamente abbigliato per l'occasione, indossare l'aori con il suo mon.
Oggigiorno l'aori è un indumento soprattutto da cerimonia, si indossa ad esempio durante i matrimoni e le cerimonie ufficiali. Ma non basta l'occasione per avere un mon: occorre discendere da un lignaggio i cui membri fossero autorizzati all'utilizzo del blasone familiare.In occasione della consegna del Budo korosho, una importante onoreficenza riservata a chi si è particolarmente distinto nel mondo delle arti marziali, ecco il maestro Hiroshi Tada, anche per il resto debitamente abbigliato per l'occasione, indossare l'aori con il suo mon.
La foto proviene da Aikido, anno XXIV, aprile 1994. ed è stata scattata da Giovanni Capannelli, autore dell'articolo. All'epoca risiedeva a Tokyo ove praticava presso il Dojo Gessoji del maestro Tada, ed era il suo traduttore di fiducia.
Non ho avuto modo di identificare questo mon, la risoluzione della foto non è sufficiente, ma non mi sono arreso.
 Le pubblicazioni specializzate, che hanno una certa diffusione perché i mon si prestano molto ad elaborazioni grafiche e sono comunque molto belli da vedere, li suddividono per tipologia e non per il nome delle famiglie: sarebbe troppo complicato, molti stemmi erano utilizzati da più rami o più famiglie. Per rintracciare l'origine di un mon quindi bisogna aver bene compreso di quali elementi è composto e ricercarlo nella giusta categoria. Nonostante tutto qualcosa ho trovato, però questo kamon (anche questo termine viene utilizzato), per quanto attribuito alla famiglia Tada, non sembra corrispondere con quanto intuibile dalla foto precedente.
Le pubblicazioni specializzate, che hanno una certa diffusione perché i mon si prestano molto ad elaborazioni grafiche e sono comunque molto belli da vedere, li suddividono per tipologia e non per il nome delle famiglie: sarebbe troppo complicato, molti stemmi erano utilizzati da più rami o più famiglie. Per rintracciare l'origine di un mon quindi bisogna aver bene compreso di quali elementi è composto e ricercarlo nella giusta categoria. Nonostante tutto qualcosa ho trovato, però questo kamon (anche questo termine viene utilizzato), per quanto attribuito alla famiglia Tada, non sembra corrispondere con quanto intuibile dalla foto precedente. Per fortuna è arrivato in soccorso nientepopodimeno che il maestro stesso, spiegando durante una lezione che il mon della sua famiglia rappresenta la luna e un fiore di loto. Non è detto che sia esattamente questo, ma sicuramente non è molto differente.
Per fortuna è arrivato in soccorso nientepopodimeno che il maestro stesso, spiegando durante una lezione che il mon della sua famiglia rappresenta la luna e un fiore di loto. Non è detto che sia esattamente questo, ma sicuramente non è molto differente. Non ho avuto invece particolari problemi ad identificare il mon del maestro Hosokawa, il suo significato e le sue origini: mi ha detto tutto lui... Rappresenta il sole con gli 8 pianeti e visto che le origini certe della famiglia Hosokawa risalgono all'VIII secolo circa della nostra era questo dimostra anche l'avanzamento della scienza astronomica nel Giappone protostorico. I pianeti più esterni sono stati scoperti in occidente solo in epoca recente, prima in seguito a calcoli matematici per identificare le origini delle perturbarzioni nelle orbite dei pianeti interni, e solo dopo avvistati al telescopio. Come è noto il nono pianeta, Plutone, è stato scoperto da Tombaugh solo in epoca relativamente recente.
Non ho avuto invece particolari problemi ad identificare il mon del maestro Hosokawa, il suo significato e le sue origini: mi ha detto tutto lui... Rappresenta il sole con gli 8 pianeti e visto che le origini certe della famiglia Hosokawa risalgono all'VIII secolo circa della nostra era questo dimostra anche l'avanzamento della scienza astronomica nel Giappone protostorico. I pianeti più esterni sono stati scoperti in occidente solo in epoca recente, prima in seguito a calcoli matematici per identificare le origini delle perturbarzioni nelle orbite dei pianeti interni, e solo dopo avvistati al telescopio. Come è noto il nono pianeta, Plutone, è stato scoperto da Tombaugh solo in epoca relativamente recente.
 Per la verità il maestro ci ha sempre scherzato sopra, sostenendo che era il mon della Sip (ora Telecom , ma i giovani non capiranno: abituati alla tastiera numerica non ricordano o nemmeno hanno mai visto il disco numeratore dei vecchi telefoni).
Per la verità il maestro ci ha sempre scherzato sopra, sostenendo che era il mon della Sip (ora Telecom , ma i giovani non capiranno: abituati alla tastiera numerica non ricordano o nemmeno hanno mai visto il disco numeratore dei vecchi telefoni).
E notoriamente non ama nemmeno la luce dei riflettori, quindi è particolarmente arduo avvistarlo con l'aori ed il mon degli Hosokawa.
 Ma ci vengono in aiuto tanti piccoli oggetti della vita "quotidiana" del samurai., che potremmo più verosimilmente immaginare indossati dal maestro. Ecco ad esempio un'altra tsuba (guardia) di spada, decorata col motivo del suo mon.
Ma ci vengono in aiuto tanti piccoli oggetti della vita "quotidiana" del samurai., che potremmo più verosimilmente immaginare indossati dal maestro. Ecco ad esempio un'altra tsuba (guardia) di spada, decorata col motivo del suo mon.
E ora che lo conosciamo, cercandolo con attenzione, potremmo trovare questo mon un po' dappertutto. In circa 1200 anni la famiglia Hosokawa ha fatto molto parlare di se, basti pensare che il più famoso samurai di tutti i tempi, Miyamoto Musashi, era al servizio del ramo di Honshu degli Hosokawa (il maestro proviene invece da Shikoku), e venne adottato anche da altre famiglie.
 Passiamo al maestro Fujimoto: per la verità non sono sicuro che quello che vedete sia il suo mon di famgilia, anche perchè l'albero genealogico del maestro è un po' complesso.
Passiamo al maestro Fujimoto: per la verità non sono sicuro che quello che vedete sia il suo mon di famgilia, anche perchè l'albero genealogico del maestro è un po' complesso.
Di sicuro è il mon che ha scelto per la sua scuola, e altrettanto di sicuro è un mon di antiche origini.
 Qui potete potete vedere l'originale, tratto dal solito manuale di araldica giapponese. Prometto che gli chiederò informazioni ad una delle prossime occasioni (lo rivedrò: il maestro ci ha lasciato nel febbraio 2012, ma saprò ritrovarlo).
Qui potete potete vedere l'originale, tratto dal solito manuale di araldica giapponese. Prometto che gli chiederò informazioni ad una delle prossime occasioni (lo rivedrò: il maestro ci ha lasciato nel febbraio 2012, ma saprò ritrovarlo).
Sempre naturalmente se non troveremo argomenti più urgenti ed appassionanti, e nella cultura giapponese ve ne sono tanti.
 Naturalmente anche il maestro Takeda Sokaku che trasmise a Morihei Ueshiba il daito ryu aikijujutsu, l'arte che ha dato i natali all'aikido, era di famiglia samurai, discendente dal ramo dei Minamoto, famiglia che per secoli ha avuto il dominio sull'intero Giappone, residente nel feudo di Aizu. Il suo mon di famiglia, che ora è anche l'emblema della scuola, che spesso è anche definita semplicemente Takeda ryu, è lo yotsume: il simbolo dei "quattro occhi".
Naturalmente anche il maestro Takeda Sokaku che trasmise a Morihei Ueshiba il daito ryu aikijujutsu, l'arte che ha dato i natali all'aikido, era di famiglia samurai, discendente dal ramo dei Minamoto, famiglia che per secoli ha avuto il dominio sull'intero Giappone, residente nel feudo di Aizu. Il suo mon di famiglia, che ora è anche l'emblema della scuola, che spesso è anche definita semplicemente Takeda ryu, è lo yotsume: il simbolo dei "quattro occhi".
 Ma non dimentichiamoci di o sensei, la persona che ci ha dato l'immenso dono dell'aikido; abbiamo già intravisto il suo mon, vediamolo ora nel dettaglio e apprendiamone il significato: si chiama in gergo araldico takaha (piume di falco).
Ma non dimentichiamoci di o sensei, la persona che ci ha dato l'immenso dono dell'aikido; abbiamo già intravisto il suo mon, vediamolo ora nel dettaglio e apprendiamone il significato: si chiama in gergo araldico takaha (piume di falco).
E per oggi credo proprio che sia tutto.
I mon antichi provengono da
Japanese design Motifs, 4260 illustration of japanese crests
compiled by the Matsuya Piece Goods Store
Dover Publications, New York, 1972
ISBN 0-486-22874-6
Cronologia dell'aikido: arte nuova, moderna. Ma con 1000 anni di storia.
|
XI secolo |
Minamoto Yoshimitsu, dopo avere studiato le tecniche ancestrali del suo clan e quelle del tegoi (predecessore del sumo) e avere approfondito personalmente sulla base dell'esperienza bellica, getta le basi di un nuovo sistema di formazione marziale. Lo definisce Daito ryu, dal nome del palazzo nel feudo di Kai ove ha la sua residenza | |
| XII secolo | Minamoto Nobuyoshi assume il nome di famiglia di Takeda | |
| XVI secolo | Dopo la sconfitta di Takeda Katsuyori nella battaglia di Nagashino un ramo della famiglia si trasferisce nel feudo di Aizu nel nord, dove rimarrà fino ai nostri giorni. Continua a trasmettere la conoscenza del Daito ryu, che viene talvolta definito aiki jujutsu. L'arte sarebbe stata influenzata nel corso dei secoli dai contatti con altre scuole, in particolare l'Hana ha Itto ryuoshikiuchi, metodo di combattimento segreto trasmesso nei clan maggiormante legati allo shogun. | |
| 1859 | 10 ottobre | Nasce Takeda Sokaku. Inizialmente è destinato allo studio del Jikishinkage ryu sotto la guida di Sasakibara Kenkichi, ma la morte del fratello maggiore fa sì che diventi il soke del Daito ryu. Inizia allora una lunga opera di insegnamento itinerante. |
|
1883 |
14 dicembre |
Nasce in Tanabe, nella prefettura di Wakayama, il Fondatore dell'aikido, Ueshiba Morihei |
|
1900-1919 |
|
Inizia lo studio delle arti marziali, che si protrarrà fino al 1920 circa, attingendo a numerose fonti. Intorno al 1915 incontra in Hokkaido, ove si era trasferito, Takeda Sokaku. Ne riceve l'insegnamento e decide di seguirne la strada. |
| 1919 | Costretto a rientrare a Tanabe per una malattia del padre, Ueshiba si ferma lungo il viaggio ad Ayabe per incontrare Onisaburo Deguchi, capo carismatico della setta Omoto kyo, cui rimarrà legato negli anni successivi. | |
|
1921 |
|
Scomparso il padre, prima che abbia potuto rivederlo, Ueshiba decide di trasferirsi ad Ayabe. Diverrà guardia del corpo di Deguchi, e fonderà un suo dojo ove insegnerà Daito ryu, presumibilmente dandogli una forte impronta personale. |
|
1920 |
27 giugno |
Nasce in Ayabe Kisshomaru Ueshiba, che diventerà secondo doshu alla morte del Fondatore |
| 1925 | primavera | Al ritorno da un avventuroso viaggio in Mongolia in cui Deguchi e i suoi seguaci hanno rischiato più volte la vita, Ueshiba Morihei avverte di non essere più la stessa persona di prima. Dopo un duello cortese con un ufficiale di marina prende coscienza di se stesso e del suo destino. |
|
1927 |
|
Col consenso di Deguchi il Fondatore si trasferisce a Tokyo con la famiglia ed inizia l’insegnamento della Via dell’Aiki a Shiba Shirogane. |
|
1931 |
|
Inizia l’attività del dojo Kobukan a Wakamatusu-cho, Shinjuku; diventerà poi l’Hombu Dojo |
| 1935-1940 | Ueshiba Morihei getta le basi per il riconoscimento ufficiale di una nuova arte marziale, cui darà il nome di aikido | |
|
1940 |
|
La Fondazione Kobukai viene ufficialmente riconosciuta dal governo giapponese. Verranno poi definitivamente adottati e riconosciuti i termini aikido ed Aikikai. |
|
1940 |
|
Inizia l’allestimento di un luogo all’aperto per la pratica ad Iwama-Machi, nella prefettura di Ibaraki. Negli anni successivi Ueshiba Morihei decide di prendere le distanze da ogni incarico pubblico e ritirarsi ad Iwama per venerarvi il dio dell'aiki e proseguire il suo percorso interno. |
|
1942 |
|
Viene ufficialmente adottato il nome Aikido. Kisshomaru Ueshiba diviene presidente della Fondazione Kobukai |
|
1943 |
|
Viene terminata la costruzione del Tempio dell’Aiki a Iwama-Machi. Il 25 aprile scompare Takeda Sokaku. |
|
1947 |
|
Riorganizzazione del Kobukai, che diventa Fondazione Aikikai |
|
1948 |
|
Kisshomaru Ueshiba diventa Direttore Generale della Fondazione Hombu Dojo. In questo anno vengono gettate le basi per il fuuturo sviluppo dell’Aikido. Riprendono i corsi all'Hombu Dojo, interrotti per gli eventi bellici. |
|
1951 |
|
Nasce in Tokyo Moriteru Ueshiba, che diverrà il terzo doshu. |
|
1959 |
|
Viene pubblicato il primo numero di Aikido Shinbun, con una succinta edizione inglese: The Aikido. |
|
1960 |
|
Il Fondatore riceve l’onoreficenza Shiju Hosho |
|
1967 |
|
Viene inaugurato il nuovo Hombu Dojo; in occasione dell’inaugurazione il Fondatore tiene la sua ultima dimostrazione in pubblico. La città di Tokyo riconosce ufficialmente l’insegnamento dell’Aikido |
|
1969 |
26 aprile |
Il Fondatore scompare, all’età di 86 anni. Gli viene conferita l’onoreficenza postuma dello Zuihosho. |
|
1969 |
|
All’età di 48 anni, Kisshomaru Ueshiba diviene il secondo doshu. |
|
1974 |
|
Vengono gettate le basi per per la International Aikido Federation, di cui il doshu viene nominato Presidente a vita. |
|
1975 |
|
In occasione di un lungo viaggio all’estero del Doshu per organizzare la nascente IAF, appare per la prima volta all'estero a Roma, all’età di 24 anni, Moriteru Ueshiba, futuro doshu. |
|
1976 |
|
Il primo congresso della IAF si tiene a Tokyo, con la partecipazione di oltre 400 delegati da 29 nazioni. |
|
1979 |
9 giugno |
In occasione del 10° anniversario della morte di o sensei, durante il 17° Enbukai Nazionale di Aikido, per la prima volta waka sensei Moriteru Ueshiba dimostra la sua tecnica. |
|
1981 |
|
Celebrazione del 50° anniversario dall’inaugurazione dell’Hombu Dojo. |
|
1982 |
novembre |
Primo viaggio ufficiale in Europa di waka sensei. Si reca a Roma dove tiene un raduno presso il Dojo Centrale, ed a Mantova. |
|
1991 |
|
Vengono celebrati il 50° anniversario della fondazione dell’Aikikai ed il 60° dalla fondazione dell’Hombu Dojo. |
|
1999 |
4 gennaio |
Scompare Kisshomaru Ueshiba, dopo 30 anni alla guida dell’Aikikai. |
|
1999 |
18 gennaio |
All’età di 48 anni, dopo 24 anni dalla sua prima apparizione in pubblico, Moriteru Ueshiba diviene il terzo doshu. |
| 2010 | Dirige i suoi primi seminari all'estero Mitsuteru Ueshiba, waka sensei, designato per divenire il quarto doshu |