Gendai
Riflessioni. Ancora
 Ha senso allenarsi a dominare la paura attraverso la ripetizione di azioni predeterminate ed eseguite con reciproco consenso? Di fronte a un combattimento reale, come reagiremmo? Questo è lo scopo delle domande che si pone e ci pone Roberto Sabatini, in un intervento che avanza delle proposte sull'insegnamento e sulla pratica dell'aikido, che consiglio di leggere o rileggere prima di andare avanti a scorrere queste mie riflessioni. Da lì partono non le mie risposte, non ne ho da proporre in argomenti che mi superano, ma le mie riflessioni. Non controriflessioni: un prolungamento se vogliamo delle riflessioni e proposte precedenti, già accettate in linea di principio anche se lo sviluppo della prima riflessione porta fisiologicamente a dei distinguo.
Ha senso allenarsi a dominare la paura attraverso la ripetizione di azioni predeterminate ed eseguite con reciproco consenso? Di fronte a un combattimento reale, come reagiremmo? Questo è lo scopo delle domande che si pone e ci pone Roberto Sabatini, in un intervento che avanza delle proposte sull'insegnamento e sulla pratica dell'aikido, che consiglio di leggere o rileggere prima di andare avanti a scorrere queste mie riflessioni. Da lì partono non le mie risposte, non ne ho da proporre in argomenti che mi superano, ma le mie riflessioni. Non controriflessioni: un prolungamento se vogliamo delle riflessioni e proposte precedenti, già accettate in linea di principio anche se lo sviluppo della prima riflessione porta fisiologicamente a dei distinguo.
 Quello che viene proposto è in sostanza uno spazio riservato ad un aikido meno collaborativo, sia per allontanare l'ombra dell'eccesso di compiacenza da parte dell'uke sia per abituare il tori a confrontarsi non con situazioni attentamente programmate in anticipo, ma con proposte (ossia attacchi) non prevedibili che richiederanno risposte istintive. Allenandosi a superare in questo modo almeno in parte la paura e l'irrazionalità che vengono dall'incertezza, dall'ignoto. Un procedimento apparentabile a quello dello zen, che propone al praticante i koan, problemi di cui non potrà venire a capo né con la logica né con l'addestramento.
Quello che viene proposto è in sostanza uno spazio riservato ad un aikido meno collaborativo, sia per allontanare l'ombra dell'eccesso di compiacenza da parte dell'uke sia per abituare il tori a confrontarsi non con situazioni attentamente programmate in anticipo, ma con proposte (ossia attacchi) non prevedibili che richiederanno risposte istintive. Allenandosi a superare in questo modo almeno in parte la paura e l'irrazionalità che vengono dall'incertezza, dall'ignoto. Un procedimento apparentabile a quello dello zen, che propone al praticante i koan, problemi di cui non potrà venire a capo né con la logica né con l'addestramento.
Non ho obiezioni pratiche, salvo quella del limitato tempo a disposizione per la pratica nei dojo di oggigiorno, spesso sufficiente a malapena per la base ma non per pur utili didattiche complementari, con una punta di pessimismo sulla possibilità di superare questo ostacolo. Ma piuttosto che affrontare una disamina dei problemi pratici avrei piacere che si discutesse dei concetti di fondo.
 La paura dell'ignoto potremmo definirla come un timor panico, non determinabile: cosa ci porta l'ignoto? Quello che non conosciamo. è evidente. Ma che difesa potremmo mai immaginare o perfino allenare contro quello che ignoriamo? Potremo allenarci a ridurre i tempi di reazione ma non ad avere la giusta reazione. Qui entra in gioco piuttosto la sensibilità. Ma accrescere la sensibilità è già lo scopo primario dell'aikido. Pur tenendo presente che l'utilizzo di questa sensibilità per il raggiungimento di obiettivi concreti è una possibile conseguenza della acquisita capacità ma non ne è l'obiettivo primario. Non è una contraddizione in termini: la nostra arte dovrebbe averci già abituato all'idea che l'eccesso di desiderio allontana l'obiettivo.
La paura dell'ignoto potremmo definirla come un timor panico, non determinabile: cosa ci porta l'ignoto? Quello che non conosciamo. è evidente. Ma che difesa potremmo mai immaginare o perfino allenare contro quello che ignoriamo? Potremo allenarci a ridurre i tempi di reazione ma non ad avere la giusta reazione. Qui entra in gioco piuttosto la sensibilità. Ma accrescere la sensibilità è già lo scopo primario dell'aikido. Pur tenendo presente che l'utilizzo di questa sensibilità per il raggiungimento di obiettivi concreti è una possibile conseguenza della acquisita capacità ma non ne è l'obiettivo primario. Non è una contraddizione in termini: la nostra arte dovrebbe averci già abituato all'idea che l'eccesso di desiderio allontana l'obiettivo.
Tuttavia prima ancora che dell'ignoto noi abbiamo anche se non soprattutto paura del noto: della sofferenza e del male che conosciamo, incluso quello che è dentro di noi. Ed è quella paura, quella del noto, che dobbiamo soprattutto controllare. Non titanicamente tentare di superare: ci ritroveremmo con un pugno di mosche nella improbabile ipotesi che vi riuscissimo. Il timore infatti è anche potenzialmente una forma di rispetto: e il rispetto non deve mai venir meno, se non si vuole essere perdenti già in partenza.
La ripetizione regolare del confronto con quanto, sia pur noto, continua a incuterci timore o perlomeno a metterci in difficoltà ci mette in condizione di trasformare in rispetto la nostra paura, attraverso la conoscenza e l'accettazione. E da questo punto di vista l'aikido, che non ha mai fine e che propone quotidianamente non tanto nuove sfide, ma sempiterni rinnovi quotidiani della stessa sfida, è un buono strumento e segue un percorso logico.
Il superamento di questa logica e di questa forma di pratica, una sorta di astrattismo dell'aikido, può essere un passo successivo. Ma appare difficile compierlo prima di avere completato il percorso precedente.
 Del resto molti koryu – antiche scuole – si sono trovate di fronte al medesimo dilemma: pur nate in epoche inquiete, curavano l'allenamento al noto, che ancora oggi perpetuano, attraverso l'esecuzione di schemi preordinati definiti kata. Ad esso affiancavano, sia sistematicamente sia per iniziativa del singolo praticante il confronto obiettivo; combattimenti, sia pure formali e raramente spinti agli estremi. Ancora al giorno d'oggi chi studia lo iaido frequentemente pratica anche kendo per misurarsi con altri, mentre dall'altro lato chi è già avvezzo all'avversario esterno spesso decide di completare il suo percorso formativo sostitiendo lo shinai con lo iaito per misurarsi con se stesso.
Del resto molti koryu – antiche scuole – si sono trovate di fronte al medesimo dilemma: pur nate in epoche inquiete, curavano l'allenamento al noto, che ancora oggi perpetuano, attraverso l'esecuzione di schemi preordinati definiti kata. Ad esso affiancavano, sia sistematicamente sia per iniziativa del singolo praticante il confronto obiettivo; combattimenti, sia pure formali e raramente spinti agli estremi. Ancora al giorno d'oggi chi studia lo iaido frequentemente pratica anche kendo per misurarsi con altri, mentre dall'altro lato chi è già avvezzo all'avversario esterno spesso decide di completare il suo percorso formativo sostitiendo lo shinai con lo iaito per misurarsi con se stesso.
Sappiamo infatti che qualunque metodo di confronto formale, l'esperienza dei secoli passati lo ha dimostrato, non ha valenza assoluta. Sono stati frequenti i casi di grandi campioni rivelatisi mediocri combattenti o rimasti addirittura paralizzati dalla paura nel momento del confronto senza limite. Si è dimostrato più raro invece il caso di persone con un adeguato livello di serenità interiore che non si dimostrassero all'altezza di affrontare con dignità ogni compito, anche quelli per cui non avessero competenze o preparazione specifica. E' fin troppo scontato citare l'episodio, forse leggendario, del maestro di the completamente digiuno dell'arte della spada che con la sua calma interiore, raggiunta con l'accettazione della idea della sconfitta e della morte, incusse tale timore ad un samurai allenato ai combattimenti senza regole, che lo aveva sfidato, da indurlo alla rinuncia e alla fuga.
Ma tornando ai giorni e ai casi nostri: esiste già in nuce nella metodica dell'aikido quanto sottolineato da Roberto nell'intervento da cui prende lo spunto il mio: Morihei Ueshiba nel suo Budo (Mediterranee, 1994) così invita alla pratica: «Riempitevi con il ki ed invitate il vostro avversario a colpire di shomen» (p. 42); «Riempitevi di ki ed invitate il vostro avversario a portare un colpo di yokomen» (p. 46).
Non va dimenticato ovviamente che quelli assegnatici dal fondatore sono obiettivi cui tendere quotidianamente, non patrimonio acquisito e certificato da un diploma, per quanto possa essere elevato il grado tecnico raggiunto. Ma non va nemmeno dimenticato che Morihei Ueshiba ci ha invitato esplicitamente a cercare di praticare in questo modo, e Tada sensei ce lo ricorda giustamente molto spesso: dobbiamo agire e non reagire, condizionare e determinare gli eventi, compresi quelli potenzialmente ostili, e non subirli.
 Se c'è un problema non è nel metodo dell'aikido, o non soltanto in esso: il problema è dentro di noi. Non lo supereremo vincendo un altro. E dobbiamo tendere a far sì che uke dipenda da quello che decidiamo noi, e non viceversa. Per questo ritengo che lo spazio per la «proposta Sabatini» ci debba essere, naturalmente a discrezione di ogni singolo insegnante, ma delimitato. Deve apparire chiaro al praticante ove si interrompa un metodo per adottarne un altro complementare, e quando si ritorni al metodo di base.
Se c'è un problema non è nel metodo dell'aikido, o non soltanto in esso: il problema è dentro di noi. Non lo supereremo vincendo un altro. E dobbiamo tendere a far sì che uke dipenda da quello che decidiamo noi, e non viceversa. Per questo ritengo che lo spazio per la «proposta Sabatini» ci debba essere, naturalmente a discrezione di ogni singolo insegnante, ma delimitato. Deve apparire chiaro al praticante ove si interrompa un metodo per adottarne un altro complementare, e quando si ritorni al metodo di base.
Rimanendo per il momento approfondimenti e riflessioni ulteriori, vorrei sottolineare anche che il metodo dell'aikido, definito da Tada sensei uchikomi, non appartiene alla categoria dei metodi di confronto o combattimento (kumite) né a quella dei metodi formali (kata) ma forma una categoria a se stante: è un metodo relazionale (per una idea di cosa intendo esprimere con questi concetti debbo citare il mio articolo in merito).
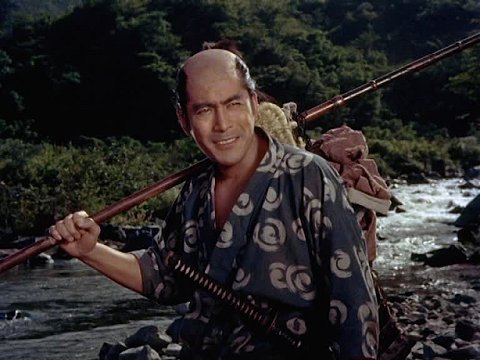 E' chiaro che in una relazione tutto possa dipendere da noi ma sempre inquadrato in un rapporto complesso la cui evoluzione non possiamo né dobbiamo decidere o controllare in completa autonomia. Ci poniamo in relazione per offrire qualcosa di noi e per ricevere qualcosa da altri, con un rapporto non di scambio ma di reciproca libera donazione. In questa ottica non è necessario ricercare nel rapporto una figura dominante una figura vincente. Certamente è giusto che ognuna delle parti metta in gioco il meglio di se, dando vita a un confronto che permetta alla relazione di crescere. E ' uno scopo ben più alto e non ultimo più proficuo che non il semplice ottenimento di una mera vittoria in un gioco di relazione.
E' chiaro che in una relazione tutto possa dipendere da noi ma sempre inquadrato in un rapporto complesso la cui evoluzione non possiamo né dobbiamo decidere o controllare in completa autonomia. Ci poniamo in relazione per offrire qualcosa di noi e per ricevere qualcosa da altri, con un rapporto non di scambio ma di reciproca libera donazione. In questa ottica non è necessario ricercare nel rapporto una figura dominante una figura vincente. Certamente è giusto che ognuna delle parti metta in gioco il meglio di se, dando vita a un confronto che permetta alla relazione di crescere. E ' uno scopo ben più alto e non ultimo più proficuo che non il semplice ottenimento di una mera vittoria in un gioco di relazione.
E' vero anche però che in ogni relazione è lecito e talvolta giusto il dissenso, l'opposizione: ma finalizzato sempre a terminare in consenso, allineandosi sulle posizioni che appaiono più adeguate. E che si possa esprimere anche un dissenso a priori, finalizzato ad ottenere la controprova della validità di quanto richiesto dalla controparte. Certamente, secondo me ma soprattutto secondo la logica si può e talvotla anzi si deve. Ma ritengo che si tratti di eccezioni: talvolta necessarie e provvidenziali ma sempre eccezioni: il metodo dell'aikido ricerca il consenso ma non considera necessario raggiungerlo sistematicamente attraverso il dissenso. Occorre prepararsi a queste situazioni, ma non occorre cercarle.
Tutto questo non per dichiarare il mio dissenso da quanto esposto in precedenza da Roberto: concordo con lui. Ritengo che a questo genere di proposte vada riservato uno spazio. D'altronde non sono nuove, come forse ricorderà lui stesso riportando alla memoria come ci si allenava molti anni fa nel reparto agitati del mai abbastanza compianto Dojo Centrale, ove la compiacenza verso il tori non era mai una priorità. Devo però aggiungere che, a mio parere, il livello necessario per affrontare con successo questi metodi di lavoro, e non parlo di mero livello tecnico, non è negoziabile: l'uomo ha bisogno di una solida base di certezza prima di potersi avventurare con successo nel mondo dell'incertezza, il solo che possa farlo crescere oltre i suoi limiti «tecnici».
 Ma occorre constatare, senzaltro con amarezza, che noi insegnanti in questo frangente storico stentiamo a portare le persone che si affidano alla nostra guida al di là di questa barriera. Il praticante stesso richiede spesso maggiore certezza, è a disagio di fronte alle sfide. Risolviamo questo nodo prima di varcare nuove barriere, troviamo stimoli a chi prova queste difficoltà, ricordiamogli che la grande sfida cui si è impegnato può essere sì rimandata ma non elusa per sempre. E' comunque, e questo va detto, un momento di passaggio che va superato anchesso. La via della ricerca di un avversario ha il suo tempo, limitato. Quella del confronto con se stesso e della relazione con l'altro dura quanto la vita. Tento di rendere manifesto il mio pensiero con parole non mie.
Ma occorre constatare, senzaltro con amarezza, che noi insegnanti in questo frangente storico stentiamo a portare le persone che si affidano alla nostra guida al di là di questa barriera. Il praticante stesso richiede spesso maggiore certezza, è a disagio di fronte alle sfide. Risolviamo questo nodo prima di varcare nuove barriere, troviamo stimoli a chi prova queste difficoltà, ricordiamogli che la grande sfida cui si è impegnato può essere sì rimandata ma non elusa per sempre. E' comunque, e questo va detto, un momento di passaggio che va superato anchesso. La via della ricerca di un avversario ha il suo tempo, limitato. Quella del confronto con se stesso e della relazione con l'altro dura quanto la vita. Tento di rendere manifesto il mio pensiero con parole non mie.
Dapprima quelle riportate nel XIX secolo da Katsu Kaishu, che chiedeva al maestro Shirai Toru come mai si sentisse così intimorito avendo l'onore di incrociare con lui le armi. La sorridente risposta di Shirai fu: «E’ perché avete fatto già qualche progresso nella spada: chi non ha nulla non sentirà nulla.» Quindi, non abbiamo paura della nostra paura.
E infine quelle di Hiroshi Tada sensei, così come riportate da Fabrizio Ruta, che ringrazio:
 «Focalizzati sull'entrare in sintonia con l'allenamento, con naturalezza, estendendo il tuo corpo. Diventando un tutt'uno con l'allenamento ci si estende in sintonia con la natura. In tal modo, più ci si estende, più l'allenamento diventa intenso. Detto in parole semplici è come entrare in un leggero stato di trance. Ci si unisce con l'oggetto che si ha di fronte senza però farsi trasportare da esso. Il maestro Ueshiba Morihei usava definire questo stato "amore". Nel momento stesso in cui ci si unisce totalmente all'oggetto che si ha di fronte senza opporvisi, ci si può muovere in totale libertà
«Focalizzati sull'entrare in sintonia con l'allenamento, con naturalezza, estendendo il tuo corpo. Diventando un tutt'uno con l'allenamento ci si estende in sintonia con la natura. In tal modo, più ci si estende, più l'allenamento diventa intenso. Detto in parole semplici è come entrare in un leggero stato di trance. Ci si unisce con l'oggetto che si ha di fronte senza però farsi trasportare da esso. Il maestro Ueshiba Morihei usava definire questo stato "amore". Nel momento stesso in cui ci si unisce totalmente all'oggetto che si ha di fronte senza opporvisi, ci si può muovere in totale libertà
E' così che si entra nello stato di samadhi. E' così che ci si allena»

